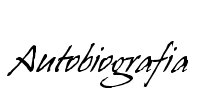[Pagina precedente]...ntre io stavo in Accademia a Torino. Quel suo dolore mi penetrò altamente; ma pure la brama di veder cose nuove, l'idea di dover tra pochi giorni viaggiar per le poste, io che usciva di fresco dall'aver fatto il primo mio viaggio in una villa distante quindici miglia da Asti, tirato da due placidissimi manzi; e cento altre simili ideuzze infantili che la fantasia lusinghiera mi andava apprestando alla mente, mi alleggerivano in gran parte il dolore del morto fratello, e dell'afflittissima madre. Ma pure, quando si venne all'atto di dover partire, io mi ebbi quasi a svenire, e mi addolorò di dover abbandonare il maestro don Ivaldi forse ancor piú che lo staccarmi dalla madre.
Incalessato poi quasi per forza dal mio fattore, che era un vecchio destinato per accompagnarmi a Torino in casa dello zio dove doveva andare da prima, partii finalmente, scortato anche dal servitore destinatomi fisso, che era un certo Andrea, alessandrino, giovine di molta sagacità e di bastante educazione secondo il suo stato ed il nostro paese, dove il saper leggere e scrivere non era allora comune. Era di luglio nel 1758, non so qual giorno, quando io lasciai la casa materna la mattina di buonissima ora. Piansi durante tutta la prima posta; dove poi giunto, nel tempo che si cambiava i cavalli, io volli scendere nel cortile, e sentendomi molto assetato senza voler domandare un bicchiere, né far attinger dell'acqua per me, accostatomi all'abbeveratoio de' cavalli, e tuffatovi rapidamente il maggior corno del mio cappello, tanta ne bevvi quanta ne attinsi. L'aio fattore, avvisato dai postiglioni, subito vi accorse sgridandomi assai; ma io gli risposi, che chi girava il mondo si doveva avvezzare a tai cose, e che un buon soldato non doveva bere altrimente. Dove poi avessi io pescate queste idee achillesche, non lo saprei; stante che la madre mi aveva sempre educato assai mollemente, ed anzi con risguardi circa la salute affatto risibili. Era dunque anche questo in me un impetino di natura gloriosa, il quale si sviluppava tosto che mi veniva concesso di alzare un pocolino il capo da sotto il giogo.
E qui darò fine a questa prima epoca della mia puerizia, entrando ora in un mondo alquanto men circoscritto, e potendo con maggior brevità, spero, andarmi dipingendo anche meglio. Questo primo squarcio di una vita (che tutta forse è inutilissima da sapersi) riuscirà certamente inutilissimo per tutti coloro, che stimandosi uomini si vanno scordando che l'uomo è una continuazione del bambino.
Epoca seconda
ADOLESCENZA
Abbraccia otto anni d'ineducazione.
CAPITOLO PRIMO
Partenza dalla casa materna, ed ingresso
nell'Accademia di Torino, e descrizione di essa.
Eccomi or dunque per le poste correndo a quanto piú si poteva; in grazia che io al pagar della prima posta aveva intercesso presso al pagante fattore a favore del primo postiglione per fargli dar grassa mancia; il che mi avea tosto guadagnato il cuor del secondo. Onde costui andava come un fulmine, accennandomi di tempo in tempo con l'occhio e un sorriso, che gli farei anche dare lo stesso dal fattore; il quale per esser egli vecchio ed obeso, esauritosi nella prima posta nel raccontarmi delle sciocche storiette per consolarmi, dormiva allora tenacissimamente e russava come un bue. Quel volar del calesse mi dava intanto un piacere, di cui non avea mai provato l'eguale; perché nella carrozza di mia madre, dove anche di radissimo avea posto il sedere, si andava di un quarto di trotticello da far morire; ed anche in carrozza chiusa, non si gode niente dei cavalli; ma all'incontro nel calesse nostro italiano uno ci si trova quasi su la groppa di essi, e si gode moltissimo anche della vista del paese. Cosí dunque di posta in posta, con una continua palpitazione di cuore pel gran piacere di correre, e per la novità degli oggetti, arrivai finalmente a Torino verso l'una o le due dopo mezzo giorno. Era una giornata stupenda, e l'entrata di quella città per la Porta Nuova, e la piazza di San Carlo fino all'Annunziata presso cui abitava il mio zio, essendo tutto quel tratto veramente grandioso, e lietissimo all'occhio, mi aveva rapito, ed era come fuor di me stesso. Non fu poi cosí lieta la sera; perché ritrovandomi in nuovo albergo, tra visi sconosciuti, senza la madre, senza il maestro, con la faccia dello zio che appena aveva visto una altra volta, e che mi riusciva assai meno accarezzante, e amoroso della madre; tutto questo mi fece ricadere nel dolore, e nel pianto, e nel desiderio vivissimo di tutte quelle cose da me abbandonate il giorno antecedente. Dopo alcuni dí, avvezzatomi poi alla novità, ripigliai e l'allegria e la vivacità in un grado assai maggiore ch'io non avessi mostrata mai; ed anzi fu tanta, che allo zio parve assai troppa; e trovandomi essere un diavoletto, che gli metteva a soqquadro la casa, e che per non avere maestro che mi facesse far nulla, io perdeva assolutamente il mio tempo, in vece di aspettare a mettermi in Accademia all'ottobre come s'era detto, mi v'ingabbiò fin dal dí primo d'agosto dell'anno 1758.
In età di nove anni e mezzo io mi ritrovai dunque ad un tratto traspiantato in mezzo a persone sconosciute, allontanato affatto dai parenti, isolato, ed abbandonato per cosí dire a me stesso; perché quella specie di educazione pubblica (se chiamarla pur vorremo educazione) in nessuna altra cosa fuorché negli studi, e anche Dio sa come, influiva su l'animo di quei giovinetti. Nessuna massima di morale mai, nessun ammaestramento della vita ci veniva dato. E chi ce l'avrebbe dato, se gli educatori stessi non conoscevano il mondo né per teoria né per pratica?
Era quell'Accademia un sontuosissimo edificio diviso in quattro lati, in mezzo di cui un immenso cortile. Due di essi lati erano occupati dagli educandi; i due altri lati dal Regio teatro, e dagli archivi del re. In faccia a questi per l'appunto era il lato che occupavamo noi, chiamati del Secondo e Terzo Appartamento; in faccia al teatro stavano quei del Primo, di cui parlerò a suo tempo. La galleria superiore del lato nostro, chiamavasi Terzo Appartamento, ed era destinata ai piú ragazzi, ed alle scuole inferiori; la galleria del primo piano, chiamata Secondo, era destinata ai piú adulti; de' quali una metà od un terzo studiavano all'Università, altro edificio assai prossimo all'Accademia; gli altri attendevano in casa agli studi militari. Ciascuna galleria conteneva almeno quattro camerate di undici giovani ciascheduna, cui presiedeva un pretuccio chiamato assistente, per lo piú un villan rivestito, a cui non si dava salario nessuno; e con la tavola sola e l'alloggio si tirava innanzi a studiare anch'egli la teologia, o la legge all'Università; ovvero se non erano anch'essi studenti, erano dei vecchi ignorantissimi e rozzissimi preti. Un terzo almeno del lato ch'io dissi destinato al Primo Appartamento, era occupato dai paggi del re in numero di venti o venticinque, che erano totalmente separati da noi, all'angolo opposto del vasto, cortile, ed attigui agli accennati archivi.
Noi dunque giovani studenti eramo assai male collocati cosí: fra un teatro, che non ci toccava di entrarvi se non se cinque o sei sere in tutto il carnovale; fra i paggi, che atteso il servizio di corte, le caccie, e le cavalcate, ci pareano godere di una vita tanto piú libera e divagata della nostra; e tra i forestieri finalmente che occupavano il Primo Appartamento, quasi ad esclusione dei paesani, essendo una colluvie di tutti i boreali, inglesi principalmente, russi, e tedeschi, e d'altri stati d'Italia; e questa era piú una locanda che una educazione, poiché a niuna regola erano astretti, se non se al ritrovarsi la sera in casa prima della mezza notte. Del resto, andavano, e a corte, e ai teatri, e nelle buone e nelle cattive compagnie, a loro intero piacimento. E per supplizio maggiore di noi poverini del Secondo e Terzo Appartamento, la distribuzione locale portava che ogni giorno per andare alla nostra cappella alla messa, ed alle scuole di ballo, e di scherma, dovevamo passare per le gallerie del Primo Appartamento, e quindi vederci continuamente in su gli occhi la sfrenata e insultante libertà di quegli altri; durissimo paragone colla severità del nostro sistema, che chiamavamo andantemente galera. Chi fece quella distribuzione era uno stolido, e non conosceva punto il cuore dell'uomo; non si accorgendo della funesta influenza che doveva avere in quei giovani animi quella continua vista di tanti proibiti pomi.
CAPITOLO SECONDO
Primi, studi, pedanteschi, e malfatti.
Io era dunque collocato nel Terzo Appartamento, nella camerata detta di mezzo; affidato alla guardia di quel servitore Andrea, che trovatosi cosí padrone di me senza avere né la madre, né lo zio, né altro mio parente che lo frenasse, diventò un diavolo scatenato. Costui dunque mi tiranneggiava per tutte le cose domestiche a suo pieno arbitrio. E cosí l'assistente poi faceva di me, come degli altri tutti, nelle cose dello studio, e della condotta usuale. Il giorno dopo il mio ingresso nell'Accademia, venne da quei professori esaminata la mia capacità negli studi, e fui giudicato per un forte quartano, da poter facilmente in tre mesi di assidua applicazione entrare in terza. Ed in fatti mi vi accinsi di assai buon animo, e conosciuta ivi per la prima volta l'utilissima gara dell'emulazione, a competenza di alcuni altri anche maggiori di me per età, ricevuto poi un nuovo esame nel novembre, fui assunto alla classe di terza. Era il maestro di quella un certo don Degiovanni; prete, di forse minor dottrina del mio buon Ivaldi; e che aveva inoltre assai minore affetto e sollecitudine per i fatti miei, dovendo egli badare alla meglio, e badandovi alla peggio, a quindici, o sedici suoi scolari, che tanti ne avea.
Tirandomi cosí innanzi in quella scoluccia, asino, fra asini, e sotto un asino, io vi spiegava il Cornelio Nipote, alcune egloghe di Virgilio, e simili; vi si facevano certi temi sguaiati e sciocchissimi; talché in ogni altro collegio di scuole ben dirette, quella sarebbe stata al piú piú una pessima quarta. Io non era mai l'ultimo fra i compagni; l'emulazione mi spronava finché avessi o superato o agguagliato quel giovine che passava per il primo; ma pervenuto poi io al primato, tosto mi rintiepidiva e cadea nel torpore. Ed era io forse scusabile, in quanto nulla poteva agguagliarsi alla noia e insipidità di cosí fatti studi. Si traducevano le Vite di Cornelio Nipote, ma nessuno di noi, e forse neppure il maestro, sapeva chi si fossero stati quegli uomini di cui si traducevan le vite, né dove fossero i loro paesi, né in quali tempi, né in quali governi vivessero, né cosa si fosse un governo qualunque. Tutte le idee erano o circoscritte, o false, o confuse; nessuno scopo in chi insegnava; nessunissimo allettamento in chi imparava. Erano insomma dei vergognosissimi perdigiorni; non c'invigilando nessuno; o chi lo faceva, nulla intendendovi. Ed ecco in qual modo si viene a tradire senza rimedio la gioventú.
Passato quasi che tutto l'anno 1759 in simili studi, verso il novembre fui promosso all'Umanità. Il maestro di essa, don Amatis, era un prete di molto ingegno e sagacità, e di sufficiente dottrina. Sotto di questo, io feci assai maggior profitto; e per quanto quel metodo di mal intesi studi lo comportasse, mi rinforzai bastantemente nella lingua latina. L'emulazione mi si accrebbe, per l'incontro di un giovine che competeva con me nel fare il tema; ed alcuna volta mi superava; ma vieppiú poi mi vinceva sempre negli esercizi della memoria, recitando egli sino a seicento versi delle Georgiche di Virgilio d'un fiato, senza sbagliare una sillaba, e non potendo io arrivare neppure a quattrocento, ed anche non bene; cosa, di cui mi angustiava moltissimo. E per quanto mi vo ora ricordando dei moti del mio animo in quelle battaglie puerili, mi pare che la mia indole non fosse di cattiva natura; perché nell'atto dell'essere vinto da quei dugento versi di piú, io mi sentiva bensí soffocar dalla collera, e spesso prorompeva in un dirottissi...
[Pagina successiva]