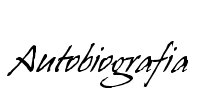[Pagina precedente]...e se non altro questi versi potranno far ridere chi vorrà dar loro un'occhiata, come vanno facendo ridere me nell'atto del trascriverli; e principalmente la scena fra Cleopatra e Photino. Aggiungerò una particolarità , ed è: che nessun'altra ragione in quel primo istante ch'io cominciai a imbrattar que' fogli mi indusse a far parlare Cleopatra piuttosto che Berenice, o Zenobia, o qualunque altra regina tragediabile, fuorché l'esser io avvezzo da mesi ed anni a vedere nell'anticamera di quella signora alcuni bellissimi arazzi, che rappresentavano vari fatti di Cleopatra e d'Antonio.
Guarà poi la mia signora di codesta sua indisposizione; ed io senza mai piú pensare a questa mia sceneggiatura risibile, la depositai sotto un cuscino della di lei poltroncina, dove ella si stette obbliata circa un anno; e cosà furono frattanto, sà dalla signora che vi si sedeva abitualmente, si da qualunque altri a caso vi si adagiasse, covate in tal guisa fra la poltroncina e il sedere di molti quelle mie tragiche primizie.
Ma, trovandomi vie piú sempre tediato ed arrabbiato di far quella vita serventesca, nel maggio di quello stesso anno '74, presi subitamente la determinazione di partire per Roma, a provare se il viaggio e la lontananza mi guarirebbero di quella morbosa passione. Afferrai l'occasione d'una acerba disputa avuta con la mia signora (e queste non erano rare), e senza dir altro, tornato la sera a casa mia, nel giorno consecutivo feci tutte le mie disposizioni, e passato tutto quell'intero giorno senza capitar da lei, la mattina dopo per tempissimo me ne partii alla volta di Milano. Essa non lo seppe che la sera prima (credo il sapesse da qualcuno di casa mia), e subito quella sera stessa al tardi mi rimandò, come è d'uso, e lettere e ritratto. Quest'invio già principiò a guastarmi la testa, e la mia risoluzione già tentennava. Tuttavia, fattomi buon animo, mi avviai, come dissi, per le poste verso Milano. Giunto la sera a Novara, saettato tutto il giorno da quella sguaiatissima passione, ecco che il pentimento, il dolore e la viltà mi muovono un sà feroce assalto al cuore, che fattasi omai vana ogni ragione, sordo al vero, repentinamente mi cangio. Fo proseguire verso Milano un abate francese ch'io m'era preso per compagno, con la carrozza e i miei servi, dicendo loro di aspettarmi in Milano. In tanto, io soletto, sei ore innanzi giorno salto a cavallo col postiglione per guida, corro tutta la notte, e il giorno poi di buon'ora mi ritrovo un'altra volta a Torino; ma per non mi vi far vedere, e non esser la favola di tutti, non entro in città ; mi soffermo in un'osteriaccia del sobborgo, e di là supplichevolmente scrivo alla mia signora adirata, perch'ella mi perdoni questa scappata, e mi voglia accordare un po' d'udienza. Ricevo tostamente risposta. Elia, che era rimasto in Torino per badare alle cose mie durante il mio viaggio che dovea esser d'un anno; Elia, destinato sempre a medicare, o palliar le mie piaghe, mi riporta quella risposta. L'udienza mi vien accordata, entro in città , come profugo, su l'imbrunir della notte; ottengo il mio intero vergognoso perdono, riparto all'alba consecutiva verso Milano, rimasti d'accordo fra noi due che in capo di cinque o sei settimane sotto pretesto di salute me ne ritornerei in Torino. Ed io in tal guisa palleggiato a vicenda tra la ragione e l'insania, appena firmata la pace, trovandomi di bel nuovo soletto su la strada maestra fra i miei pensamenti, fieramente mi sentiva riassalito dalla vergogna di tanta mia debolezza. Cosà arrivai a Milano lacerato da questi rimorsi in uno stato compassionevole ad un tempo e risibile. Io non sapeva allora, ma provava per esperienza quel profondo ed elegante bel detto del nostro maestro d'amore, il Petrarca:
Che chi discerne è vinto da chi vuole.
Due giorni appena mi trattenni in Milano, sempre fantasticando, ora come potrei abbreviare quel maledetto viaggio, ed ora, come lo potrei far durare senza tener parola del ritorno; che libero avrei voluto trovarmi, ma liberarmi non sapea, né potea. Ma, non trovando mai un po' di pace se non se nel moto e divagazione del correr la posta, rapidamente per Parma, Modena, e Bologna mi rendei a Firenze; dove né pure potendomi trattener piú di due giorni, subito ripartii per Pisa e Livorno. Quivi poi ricevute le prime lettere della mia signora, non potendo piú durare lontano, ripartii subito per la via di Lerici e Genova, dove lasciatovi l'abate compagno, e il legno da risarcirsi, a spron battuto a cavallo me ne ritornai a Torino, diciotto giorni dopo esserne partito per fare il viaggio d'un anno. C'entrai anche di notte per non farmi canzonar dalla gente. Viaggio veramente burlesco, che pure mi costò dei gran pianti.
Sotto l'usbergo (non del sentirmi puro) ma del mio viso serio e marmoreo, scansai le canzonature dei miei conoscenti ed amici, che non si attentarono di darmi il ben tornato. Ed in fatti, troppo era mal tornato; e divenuto oramai disprezzabilissimo agli stessi occhi miei, io caddi in un tale avvilimento e malinconia, che se un tale stato fosse lungamente durato, avrei dovuto o impazzire, o scoppiare; come in fatti venni assai presso all'uno ed all'altro.
Ma pure strascinai quelle vili catene ancora dal finir di giugno del '74, epoca del mio ritorno di quel semiviaggio, sino al gennaio del '75, quando alla per fine il bollore della mia compressa rabbia giunto all'estremo scoppiò.
CAPITOLO DECIMOQUINTO
Liberazione vera. Primo sonetto.
Tornato io una tal sera dall'opera (insulso e tediosissimo divertimento di tutta l'Italia) dove per molte ore mi era trattenuto nel palco dell'odiosamata signora, mi trovai cosà esuberantemente stufo che formai la immutabile risoluzione di rompere sà fatti legami per sempre. Ed avendo io visto per prova che il correre per le poste qua e là non mi avea prestato forza di proponimento, che anzi me l'avea subito indebolita e poi tolta, mi volli mettere a maggior prova, lusingandomi che in uno sforzo piú difficile riuscirei forse meglio, stante l'ostinazione naturale del mio ferreo carattere. Fermai dunque in me stesso di non mi muovere di casa mia, che come dissi le stava per l'appunto di faccia; di vedere e guardare ogni giorno le di lei finestre, di vederla passare; di udirne in qualunque modo parlare; e con tutto ciò, di non cedere oramai a nulla, né ad ambasciate dirette o indirette, né alle reminiscenze, né a cosa che fosse al mondo, a vedere se ci creperei, il che poco importavami, o se alla fin fine la vincerei. Formato in me tal proponimento, per legarmivi contraendo con una qualche persona come un obbligo di vergogna, scrissi un bigliettino ad un amico mio coetaneo, che molto mi amava, con chi s'era fatta l'adolescenza, e che allora da parecchi mesi non mi vedea piú, compiangendomi molto di esser naufragato in quella Cariddi, e non potendomene cavar egli, né volendomi perciò parer d'approvare. Nel bigliettino gli dava conto in due righe della mia immutabile risoluzione, e gli acchiudevo un involtone della lunga e ricca treccia de' miei rossissimi capelli, come un pegno di questo mio subitaneo partito, ed un impedimento quasi che invincibile al mostrarmi in nessun luogo cosà tosone, non essendo allora tollerato un tale assetto, fuorché ne' villani, e marinai. Finiva il biglietto col pregarlo di assistermi di sua presenza e coraggio, per rinfrancare il mio. Isolato in tal guisa in casa mia, proibiti tutti i messaggi, urlando e ruggendo, passai i primi quindici giorni di questa mia strana liberazione. Alcuni amici mi visitavano; e mi parve anco mi compatissero; forse appunto perché io non diceva parola per lamentarmi, ma il mio contegno ed il volto parlavano in vece mia. Mi andava provando di leggere qualche cosuccia, ma non intendeva neppur la gazzetta, non che alcun menomo libro; e mi accadeva di aver letto della pagine intere cogli occhi, e talor con le labbra, senza pure saper una parola di quel ch'avessi letto. Andava bensà cavalcando nei luoghi solitari, e questo soltanto mi giovava un poco sà allo spirito che al corpo. In questo semifrenetico stato passai piú di due mesi sino al finir di marzo del '75; finché ad un tratto un'idea nuovamente insortami cominciò finalmente a svolgermi alquanto e la mente ed il cuore da quell'unico e spiacevole e prosciugante pensiero di un sà fatto amore. Fantasticando un tal giorno cosà fra me stesso, se non sarei forse in tempo ancora di darmi al poetare, me n'era venuto, a stento ed a pezzi, fatto un piccolo saggio in quattordici rime, che io, riputandole un sonetto, inviava al gentile e dotto padre Paciaudi, che trattavami di quando in quando, e mi si era sempre mostrato ben affetto, e rincrescente di vedermi cosà ammazzare il tempo e me stesso nell'ozio. Trascriverò qui, oltre il sonetto(2), anche la di lui cortese risposta(3). Quest'ottimo uomo mi era sempre andato suggerendo delle letture italiane, or questa or quella, e tra l'altre, trovata un giorno su un muricciuolo la Cleopatra, ch'egli intitola eminentissima per essere del cardinal Delfino, ricordatosi ch'io gli avea detto parermi quello un oggetto di tragedia, e che lo avrei voluto tentare (senza pure avergli mai mostrato quel mio primo aborto, di cui ho mostrato qui addietro il soggetto), egli me la comprò e donò. Io in un momento di lucido intervallo avea avuta la pazienza di leggerla, e di postillarla; e glie l'avea cosà rimandata, stimandola in me stesso assai peggiore della mia quanto al piano e agli effetti, se io veniva mai a proseguirla, come di tempo in tempo me ne rinasceva il pensiere. Intanto il Paciaudi, per non farmi smarrire d'animo, finse di trovar buono il mio sonetto, benché né egli il credesse, né effettivamente lo fosse. Ed io poi, di là a pochi mesi ingolfatomi davvero nello studio dei nostri ottimi poeti, tosto imparai a stimare codesto mio sonetto per quel giusto nulla ch'egli valeva. Professo con tutto ciò un grand'obbligo a quelle prime lodi non vere, e a chi cortesemente le mi donò, poiché molto mi incoraggirono a cercare di meritarne delle vere.
Già parecchi giorni prima della rottura con la signora, vedendola io indispensabile ed imminente, mi era sovvenuto di ripescare di sotto al cuscino della poltroncina quella mia mezza Cleopatra, stata ivi in macero quasi che un anno. Venne poi dunque quel giorno, in cui, fra quelle mie smanie e solitudine quasi che continua, buttandovi gli occhi su, ed allora soltanto quasi come un lampo insortami la somiglianza del mio stato di cuore con quello di Antonio, dissi fra me stesso: "Va proseguita quest'impresa; rifarla, se non può star cosÃ; ma in somma sviluppare in questa tragedia gli affetti che mi divorano, e farla recitare questa primavera dai comici che ci verranno". Appena mi entrò questa idea, ch'io (quasiché vi avessi ritrovata la mia guarigione) cominciai a schiccherar fogli, rappezzare, rimutare, troncare, aggiungere, proseguire, ricominciare, ed in somma a impazzare in altro modo intorno a quella sventurata e mal nata mia Cleopatra. Né mi vergognai anco di consultare alcuni de' miei amici coetanei, che non avevano, come io, trascurata tanti anni la lingua e poesia italiana; e tutti ricercava ed infastidiva, quanti mi poteano dar qualche lume su un'arte di cui cotanto io mi trovava al buio. E in questa guisa, null'altro desiderando io allora che imparare, e tentare, se mi poteva riuscire quella pericolosissima e temeraria impresa, la mia casa si andava a poco a poco trasformando in una semiaccademia di letterati. Ma essendo io in quelle date circostanze bramoso d'imparare, e arrendevole, per accidente; ma per natura, ed attesa l'incrostata ignoranza, essendo ad un tempo stesso agli ammaestramenti recalcitrante ed indocile; disperavami, annoiava altrui e me stesso, e quasiché nulla venivami a profitto. Era tuttavia sommo il guadagno dell'andarmi con questo nuovo impulso cancellando dal cuore quella non degna fiamma, e di andare ad oncia ad oncia riacquistando il mio già sà lungamente alloppiato intelletto. Non mi trovava almeno piú nella dura ...
[Pagina successiva]