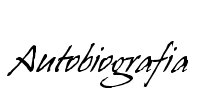[Pagina precedente]..., di vivere solitario e occupato, né ci avrei potuto resistere senza i cavalli che tanto mi sforzavano a pigliar l'aria aperta, e far moto. Ma anche coi cavalli, non la potei durare quella perpetua incessante tensione delle fibre del cervello; e se la gotta, piú savia di me, non mi vi facea dar tregua, avrei finito o col delirar d'intelletto, o col soccombere delle forze fisiche, sendomi ridotto a quasi nulla cibarmi, e pochissimo dormire. Nel maggio tuttavia, mercè la gran dieta, e il riposo, mi trovai bastantemente riavuto di forze; ma alcune circostanze particolari avendo impedito per allora la mia donna di venire in villa, e dovendo differire la consolazione unica per me, del vederla; entrai in un turbamento di spirito, che mi offuscò per piú di tre mesi la mente, talché poco e male lavorai, fino al fin d'agosto, quanto al riapparire dell'aspettata donna tutti questi miei mali di accesa e scontenta fantasia sparirono.
Appena riavutomi di mente e di corpo, dati all'oblio i dolori di questa lontananza, che per mia buona sorte fu l'ultima, tosto mi rimisi al lavoro con ardore e furore. A segno che verso il mezzo decembre, che si partà poi insieme per Parigi, io mi trovai aver verseggiate l'Agide, la Sofonisba, e la Mirra; mi trovai stesi i due Bruti; e scritta la prima satira. Questo nuovo genere, di cui avea già ideato e distribuiti i soggetti fin da nove anni prima in Firenze, l'aveva anche tentato allora in esecuzione; ma scarso ancora troppo di lingua e di padronanza di rima, mi ci era rotto le corna; talché dubbio del potervi riuscire quanto allo stile e verseggiatura, ne avea quasi deposto il pensiere. Ma il raggio vivificante della donna mia, mi ebbe allora restituito l'ardire e baldanza necessari da ciò; e postomi al tentativo, mi vi parve esser riuscito, a principiare almeno l'aringo, se non a percorrerlo. E cosà pure, avendo prima di partir per Parigi fatta una rassegna delle mie rime, e dettate e limate gran parte, me ne trovai in buon numero, e forse troppe.
CAPITOLO DECIMOSETTIMO
Viaggio a Parigi. Ritorno in Alsazia, dopo aver fissato col Didot in Parigi la stampa di tutte le diciannove tragedie. Malattia fierissima in Alsazia, dove l'amico Caluso era venuto per passare l'estate con noi.
Dopo quattordici e piú mesi non interrotti di soggiorno in Alsazia, partii insieme con la signora alla volta di Parigi; luogo a me per natura sua e mia sempre spiacevolissimo, ma che mi si facea allor paradiso poiché lo abitava la mia donna. Tuttavia, essendo incerto se vi rimarrei lungamente, lasciai gli amati cavalli nella villa di Alsazia, e munito soltanto di alcuni libri, e di tutti i miei scritti mi ritrovai in Parigi. Alla prima, il rumore e la puzza di quel caos dopo una sà lunga villeggiatura, mi rattristarono assai. La combinazione poi del ritrovarmi alloggiato assai lontano dalla mia donna, oltre mill'altre cose che di quella Babilonia mi dispiaceano sommamente, mi avrebbero fatto ripartirne ben tosto se io avessi vissuto in me stesso e per me; ma ciò non essendo da tanti anni oramai, con molta malinconia mi adattai alla necessità ; e cercai di cavarne almeno qualche utile coll'impararvi qualche cosa. Ma quanto all'arte del verseggiare non v'essendo in Parigi nessuno dei letterati che intenda piú che mediocremente la lingua nostra, non c'era niente da impararvi per me; quanto poi all'arte drammatica in massa, ancorché i francesi vi si accordino essi stessi esclusivamente il primato, tuttavia i miei principî non essendo gli stessi che han praticato i loro autori tragici, molta e troppa flemma mi ci volea per sentirmi dettare magistralmente continue sentenze, di cui molte vere, ma assai male eseguite da essi. Pure, essendo il mio metodo di poco contradire, e non mai disputare, e moltissimo e tutti ascoltare, e non credere poi quasiché mai in nessuno; io tanto e tanto imparava da quei ciarlieri la sublime arte del tacere.
Quel primo soggiorno, di sei e piú mesi in Parigi, mi giovò, se non altro, alla salute moltissimo. Prima del mezzo giugno si ripartà per la villa d'Alsazia. Ma intanto stando in Parigi avea verseggiato il Bruto primo, e per un accidente assai comico mi era toccato di rimpasticciare tutta intera la Sofonisba. La volli leggere ad un francese già mio conoscente in Torino, dove aveva soggiornato degli anni; persona intelligente di cose drammatiche; e che piú anni prima mi avea ben consigliato sul Filippo, quando glie lo aveva letto in prosa francese, di trasporvi il consiglio dal quarto atto dov'era, nel terzo dove poi è rimasto, e dove nuoce assai meno alla progressione dell'azione, di quel che dianzi nuoceva nel quarto. Sicché leggendo io quella Sofonisba ad un giudice competente, mi immedesimava in lui quant'io piú poteva, per argomentare dal di lui contegno piú che dai di lui detti, qual fosse il suo schietto parere. Egli mi stava ascoltando senza batter palpebra; ma io, che altresà mi stava ascoltando per due, incominciai da mezzo il second'atto a sentirmi assalire da una certa freddezza, che talmente mi andò crescendo nel terzo ch'io non lo potei pur finire; e preso da un impeto irresistibile la buttai sul fuoco, ché stavamo al camminetto noi due solissimi; e parea che quel fuoco mi fosse come un tacito invito a quella severa e pronta giustizia. L'amico, sorpreso di quell'inaspettata stranezza (stante che io non avea neppur detto una parola fino a quel punto, che l'accennasse neppure), si buttò colle mani su lo scartario per estrarlo dal fuoco, ma io già colle molle che aveva rapidissimamente impugnate, inchiodai sà stizzosamente la povera Sofonisba fra i due o tre pezzi che ardevano, che le convenne ardere anch'essa; né abbandonai, da esperto carnefice, le molle, se non se quando la vidi ben avvampante e abbronzita andarsi sparpagliando su per la gola del camminetto. Questo moto frenetico fu fratello carnale di quello di Madrid contro il povero Elia, ma ne arrossisco assai meno, e mi riuscà d'un qualche utile. Mi confermai allora nell'opinione ch'io aveva piú volte concepita su quel soggetto di tragedia; ch'egli era sgradito, traditore, appresentante alla prima un falso aspetto tragico, e non lo mantenendo poi saldo; e feci quasi proposito di non vi pensar altrimenti. Ma i propositi d'autore son come gli sdegni materni. Mi ricadde due mesi dopo quell'infelice prosa della giustiziata Sofonisba fra mani, e rilettala, trovandovi pure qualche cosa di buono, la ripigliai a verseggiare, abbreviandola assai, e tentando con lo stile di supplire e mascherare le mende inerenti al soggetto. E benché io sapessi, e sappia, ch'ella non era né sarebbe mai tragedia di prim'ordine, non ebbi con tutto ciò il coraggio di porla da parte, perché era il solo soggetto in cui si potessero opportunamente sviluppare gli altri sensi delle sublimi Cartagine e Roma. Onde di varie scene di quella debole tragedia, io mi pregio non poco.
Ma la totalità delle mie tragedie parendomi a quell'epoca essersi fatta oramai cosa matura per una stampa generale, mi proposi allora di voler almeno cavar questo frutto dal mio soggiorno che sarei per fissare d'allora in poi in Parigi, di farne una edizione bella, accurata, a bell'agio, senza risparmio nessuno né di spesa né di fatica. Prima dunque di decidermi per questo o per quello degli stampatori volli fare una prova dei caratteri, e proti, e maneggi tipografici parigini, trattandosi di una lingua forestiera. Trovandomi sin dall'anno innanzi dettato e corretto il Panegirico a Traiano, lo stampai a quest'effetto, ed essendo cosa breve, in un mesetto fu terminato. E saviamente feci di tentar quella prova, avendo poi cambiato lo stampatore assai in meglio per tutti i versi. Onde, accordatomi con Didot Maggiore, uomo intendentissimo ed appassionato dell'arte sua, ed oltre ciò accurato molto, e sufficientemente esperto nella lingua italiana, io cominciai sin dal maggio di quell'anno 1787 a stampare il primo volume delle tragedie. Ma incominciai per impegnare me e lui, piú che per altro; sapendo benissimo, che dovendo io partire nel giugno per trattenermi in Alsazia fino all'inverno, la stampa in quel frattempo non progredirebbe gran fatto; ancorché si prendessero le misure per farmi avere settimanalmente le prove da correggersi in Alsazia, e rimandarsi in Parigi. In questo modo io mi legai da me stesso doppiamente a dover ritornare l'inverno in Parigi, cosa alla quale sentiva ripugnanza non poca; volli perciò, che mi vi dovessero costringere parimente e la gloria e l'amore. Lasciai al Didot il manoscritto delle prose che precedono, e quello delle tre prime tragedie, ch'io stupidamente credei ridotte, limate, e accurate quanto potessero essere; me n'avvidi poi, quando fu posto mano a stamparle, quanto io mi fossi ingannato.
Oltre l'amor della quiete, l'amenità della villa, l'essere quivi piú lungamente con la mia donna, alloggiato sotto lo stesso tetto; l'avervi i miei libri, e gli amati cavalli; tutti questi oggetti erano caldissimi sproni al farmi ritornare con delizia in Alsazia. Ma un'altra ragione vi si aggiunse anche allora, che me ne dovea duplicare il diletto. L'amico Caluso mi aveva insperanzito, ch'egli verrebbe in Alsazia a passar quell'estate con noi; ed era questi l'ottimo degli uomini da me conosciuti, e 1'ultimo amico rimastomi dopo la morte del Gori. Dopo alcune settimane del nostro arrivo in Alsazia, verso il fin di luglio la mia donna ed io partimmo dunque espressamente per andare ad incontrare l'amico fino a Ginevra; indi ce ne ritornammo con esso per tutta la Svizzera sino alla nostra villa presso a Colmar; dove ebbi allora riunite tutte le mie piú care cose. Il primo discorso ch'io ebbi a tener con l'amico, fu, oltre ogni mia aspettazione, di affari domestici. Egli avea avuto dalla mia ottima madre un'incombenza assai strana, visto l'età mia, ed occupazioni, e il pensare mio. Quest'era una proposizione di matrimonio. Egli me la fece ridendo; ed io pure ridendo gliela negai: e si combinò la risposta da farsi alla mia amorosissima madre, che ci scusasse ambedue. Ma per dare un saggio dell'affetto e semplice costume di quella rispettabil donna, porrò qui in fondo di pagina(11) la di lei lettera su questo soggetto.
Finito il trattato del matrimonio, ci sfogammo reciprocamente a cuore, l'amico ed io, coi discorsi delle amatissime lettere. Io mi sentiva veramente necessità di conversare su l'arte, di parlar italiano, e di cose italiane; tutte privazioni che da due anni mi si faceano sentire non poco; e ciò con assai grande mio scapito, nell'arte principalmente del verseggiare. E certo, se questi ultimi famosi uomini francesi, come Voltaire e Rousseau, avessero dovuto gran parte della loro vita andarsene erranti in diversi paesi in cui la loro lingua fosse stata ignota o negletta, e non avessero neppur trovato con chi parlarla, essi non avrebbero forse avuto la imperturbabilità e la tenace costanza di scrivere per semplice amor dell'arte e per mero sfogo, come faceva io, ed ho fatto poi per tanti anni consecutivi, costretto dalle circostanze di vivere e conversare sempre con barbari; che tale si può francamente denominare tutta l'Europa da noi, quanto alla letteratura italiana; come lo è pur troppo tuttavia, e non poco, una gran parte della stessa Italia, sui nescia. Che se si vuole anche per gl'italiani scrivere egregiamente, e che si tentino versi in cui spiri l'arte del Petrarca e di Dante, chi oramai in Italia, chi è che veramente e legga ed intenda e gusti e vivamente senta Dante e il Petrarca? Uno in mille, a dir molto. Con tutto ciò, io immobile nella persuasione del vero e del bello, antepongo d'assai (ed afferro ogni occasione di far tal protesta) di gran lunga antepongo di scrivere in una lingua quasi che morta, e per un popolo morto, e di vedermi anche sepolto prima di morire, allo scrivere in codeste lingue sorde e mute, francese ed inglese, ancorché dai loro cannoni ed eserciti elle si vadano ponendo in moda. Piuttosto versi italiani (purché ben torniti) i quali rimangano per ora ignorati, non intesi, o scherniti...
[Pagina successiva]