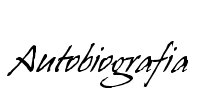[Pagina precedente]...mo pianto, e talvolta anche in atrocissime ingiurie contro al rivale; ma pure poi, o sia ch'egli si fosse migliore di me, o anch'io mi placassi non so come, essendo noi di forza di mano uguali all'incirca, non ci disputavamo quasi mai, e sul totale eramo quasi amici. Io credo, che la mia non piccola ambizioncella ritrovasse consolazione e compenso dell'inferiorità della memoria, nel premio del tema, che quasi sempre era mio; ed inoltre, io non gli poteva portar odio, perché egli era bellissimo; ed io, anche senza secondi fini, sempre sono stato assai propenso per la bellezza, sà degli animali che degli uomini, e d'ogni cosa; a segno che la bellezza per alcun tempo nella mia mente preoccupa il giudizio, e pregiudica spesso al vero.
In tutto quell'anno dell'Umanità , i miei costumi si conservarono ancora innocenti e purissimi; se non in quanto la natura da sé stessa senza ch'io nulla sapessi, me li andava pure sturbando. Mi capitò in quell'anno alle mani, e non mi posso ricordare il come, un Ariosto, l'opere tutte in quattro tometti. Non lo comprai certo, perché danari non avea; non lo rubai, perché delle cose rubate ho conservata memoria vivissima; ho un certo barlume, che lo acquistassi ad un tomo per volta per via di baratto da un altro compagno, che lo scambiasse meco col pollo che ci era dato per lo piú ogni domenica, un mezzo a ciascuno; sicché il mio primo Ariosto mi sarebbe costato la privazione di un par di polli in quattro settimane. Ma tutto questo non lo posso accertare a me stesso per l'appunto. E mi spiace; perché avrei caro di sapere se io ho bevuto i primi primi sorsi di poesia a spese dello stomaco, digiunando del miglior boccone che ci toccasse mai. E non era questo il solo baratto ch'io mi facessi, perché quel benedetto semipollo domenicale, io mi ricordo benissimo di non lo aver mangiato mai per dei se' mesi continui, perché lo avea pattuito in iscambio di certe storie che ci raccontava un certo Lignà na, il quale essendo un divoratore, aguzzavasi l'intelletto per ritondarsi la pancia; e non ammetteva ascoltatori dei suoi racconti, se non se a retribuzione di vettovaglie. Comunque accadesse dunque questa mia acquisizione, io m'ebbi un Ariosto. Lo andava leggendo qua e là senza metodo, e non intendeva neppur per metà quel ch'io leggeva. Si giudichi da ciò quali dovessero essere quegli studi da me fatti fin a quel punto; poiché io, il principe di codesti umanisti, che traduceva pur le Georgiche, assai piú difficili dell'Eneide, in prosa italiana, era imbrogliato d'intendere il piú facile dei nostri poeti. Sempre mi ricorderò, che nel canto d'Alcina, a quei bellissimi passi che descrivono la di lei bellezza io mi andava facendo tutto intelletto per capir bene: ma troppi dati mi mancavano di ogni genere per arrivarci. Onde i due ultimi versi di quella stanza, Non cosà strettamente edera preme, non mi era mai possibile d'intenderli; e tenevamo consiglio col mio competitore di scuola, che non li penetrava niente piú di me, e ci perdevamo in un mare di congetture. Questa furtiva lettura e commento su l'Ariosto finÃ, che l'assistente essendosi avvisto che andava per le mani nostre un libruccio il quale veniva immediatamente occultato al di lui apparire, lo scoprÃ, lo confiscò, e fattisi dar gli altri tomi, tutti li consegnò al sottopriore, e noi poetini restammo orbati d'ogni poetica guida, e scornati.
CAPITOLO TERZO
A quali de' miei parenti in Torino venisse affidata la mia adolescenza.
Nello spazio di questi due primi anni d'Accademia, io imparai dunque pochissimo, e di gran lunga peggiorai la salute del corpo, stante la total differenza e quantità di cibi, ed il molto strapazzo, e il non abbastanza dormire; cose in tutto contrarie al primo metodo tenuto sino ai nove anni nella casa materna. Io non cresceva punto di statura, e pareva un candelotto di cera sottilissimo e pallidissimo. Molti malanni successivamente mi andarono travagliando. L'uno, tra gli altri, cominciò con lo scoppiarmi in piú di venti luoghi la testa, uscendone un umore viscoso e fetente, preceduto da un tale dolor di capo, che le tempie mi si annerirono, e la pelle come incarbonita sfogliandosi piú volte in diversi tempi mi si cambiò tutta in su la fronte e le tempie. Il mio zio paterno il cavalier Pellegrino Alfieri, era stato fatto governatore della città di Cuneo, dove risiedeva almeno otto mesi dell'anno; onde non mi rimaneva in Torino altri parenti che quei della madre, la casa Tornone, ed un cugino di mio padre, mio semi-zio, chiamato il conte Benedetto Alfieri. Era questi il primo architetto del re; ed alloggiava contiguamente a quello stesso Regio teatro da lui con tanta eleganza e maestria ideato, e fatto eseguire. Io andava qualche volta a pranzo da lui, ed alcune volte a visitarlo; il che stava totalmente nell'arbitrio di quel mio Andrea, che dispoticamente mi governava, allegando sempre degli ordini e delle lettere dello zio di Cuneo.
Era quel conte Benedetto un veramente degn'uomo, ed ottimo di visceri. Egli mi amava ed accarezzava moltissimo; era appassionatissimo dell'arte sua; semplicissimo di carattere, e digiuno quasi d'ogni altra cosa, che non spettasse le belle arti. Tra molte altre cose, io argomento quella sua passione smisurata per l'architettura, dal parlarmi spessissimo, e con entusiasmo, a me ragazzaccio ignorante d'ogni arte ch'io m'era, del divino Michelangelo Buonarroti, ch'egli non nominava mai senza o abbassare il capo, o alzarsi la berretta, con un rispetto ed una compunzione che non mi usciranno mai della mente. Egli aveva fatta gran parte della vita in Roma; era pieno del bello antico; ma pure poi alle volte nel suo architettare prevaricò dal buon gusto per adattarsi ai moderni. E di ciò fa fede quella sua bizzarra chiesa di Carignano, fatta a foggia di ventaglio. Ma tali picciole macchie ha egli ben ampiamente cancellate col teatro sopracitato, la volta dottissima ed audacissima della Cavallerizza del re, il Salone di Stupinigi, e la soda e dignitosa facciata del tempio di San Pietro in Ginevra. Mancava forse soltanto alla di lui facoltà architettonica una piú larga borsa di quel che si fosse quella del re di Sardegna e ciò testimoniano i molti e grandiosi disegni ch'egli lasciò morendo, e che furono dal re ritirati, in cui v'erano dei progetti variatissimi per diversi abbellimenti da farsi in Torino, e tra gli altri per rifabbricare quel muro sconcissimo, che divide la piazza del Castello dalla piazza del Palazzo Reale; muro che si chiama, non so perché, il Padiglione.
Mi compiaccio ora moltissimo nel parlar di quel mio zio, che sapea pure far qualche cosa; ed ora soltanto ne conosco tutto il pregio. Ma quando io era in Accademia, egli, benché amorevolissimo per me, mi riusciva pure noiosetto anzi che no; e, vedi stortura di giudizio, e forza di false massime, la cosa che di esso mi seccava il piú era il suo benedetto parlar toscano, ch'egli dal suo soggiorno in Roma in poi mai piú non avea voluto smettere; ancorché il parlare italiano sia un vero contrabbando in Torino, città anfibia. Ma tanta è però la forza del bello e del vero, che la gente stessa che al principio quando il mio zio ripatriò, si burlava del di lui toscaneggiare, dopo alcun tempo avvistisi poi ch'egli veramente parlava una lingua, ed essi smozzicavano un barbaro gergo, tutti poi a prova favellando con lui andavano anch'essi balbettando il loro toscano; e massimamente quei tanti signori, che volevano rabberciare un poco le loro case e farle assomigliar dei palazzi: opere futili in cui gratuitamente per amicizia quell'ottimo uomo buttava la metà del suo tempo compiacendo ad altrui, e spiacendo, come gli sentii dire tante volte, a sé stesso ed all'arte. Onde molte e molte case dei primi di Torino da lui abbellite o accresciute, con atri, e scale, e portoni, e comodi interni, resteranno un monumento della facile sua benignità nel servire gli amici o quelli che se gli dicevano tali.
Questo mio zio aveva anche fatto il viaggio di Napoli insieme con mio padre suo cugino, circa un par d'anni prima che questi si accasasse con mia madre; e da lui seppi poi varie cose concernenti mio padre. Tra l'altre, che essendo essi andati al Vesuvio, mio padre a viva forza si era voluto far calar dentro sino alla crosta del cratere interno, assai ben profonda; il che praticavasi allora per mezzo di certe funi maneggiate da gente che stava sulla sommità della voragine esterna. Circa vent'anni dopo, ch'io ci fui per la prima volta, trovai ogni cosa mutata, ed impossibile quella calata. Ma è tempo, ch'io ritorni a bomba.
CAPITOLO QUARTO
Continuazione di quei non-studi.
Non c'essendo quasi dunque nessuno de' miei che badasse altrimenti a me, io andava perdendo i miei piú begli anni non imparando quasi che nulla, e deteriorando di giorno in giorno in salute; a tal segno, ch'essendo sempre infermiccio, e piagato or qua or là in varie parti del corpo, io era fatto lo scherno continuo dei compagni, che mi denominavano col gentilissimo titolo di carogna; ed i piú spiritosi ed umani ci aggiungevano anco l'epiteto di fradicia. Quello stato di salute mi cagionava delle fierissime malinconie, e quindi si radicava in me sempre piú l'amore della solitudine. Nell'anno 1760 passai con tutto ciò in Rettorica, perché quei mali tanto mi lasciavano di quando in quando studicchiare, e poco ci volea per far quelle classi. Ma il maestro di Rettorica trovandosi essere assai meno abile di quello d'Umanità , benché ci spiegasse l'Eneide, e ci facesse far dei versi latini, mi parve, quanto a me, che sotto di lui io andassi piuttosto indietro che innanzi nell'intelligenza della lingua latina. Ma pure, poiché io non era l'ultimo tra quegli altri scolari, da ciò argomento che dovesse esser lo stesso di loro. In quell'anno di pretesa rettorica, mi venne fatto di ricuperare il mio Ariostino, rubandolo a un tomo per volta al sottopriore, che se l'era innestato fra gli altri suoi libri in un suo scaffale esposto alla vista. E mi prestò opportunità di ciò fare, il tempo in cui andavamo in camera sua alcuni privilegiati, per vedere dalle di lui finestre giuocare al pallon grosso, perché dalla camera sua situata di faccia al battitore, si godeva assai meglio il giuoco che non dalle gallerie nostre che stavangli di fianco. Io aveva l'avvertenza di ben restringere i tomi vicini, tosto che ne avea levato uno; e cosà mi riuscà in quattro giorni consecutivi di riavere i miei quattro tometti, dei quali feci gran festa in me stesso, ma non lo dissi a chi che si fosse. Ma trovo pure, riandando quei tempi fra me, che da quella ricuperazione in poi, non lo lessi quasi piú niente; e le due ragioni (oltre forse quella della poca salute che era la principale) per cui mi pare che lo trascurassi, erano la difficoltà dell'intenderlo piuttosto accresciuta che scemata (vedi rettorico!) e l'altra era quella continua spezzatura delle storie ariostesche, che nel meglio del fatto ti pianta là con un palmo di naso; cosa che me ne dispiace anco adesso, perché contraria al vero, e distruggitrice dell'effetto prodotto innanzi. E siccome io non sapeva dove andarmi a raccapezzare il seguito del fatto, finiva col lasciarlo stare. Del Tasso, che al carattere mio si sarebbe adattato assai meglio, io non ne sapeva neppure il nome. Mi capitò allora, e non mi sovviene neppure come, l'Eneide dell'Annibal Caro, e la lessi con avidità e furore piú d'una volta, appassionandomi molto per Turno, e Camilla. E me ne andava poi anche prevalendo di furto, per la mia traduzione scolastica del tema datomi dal maestro; il che sempre piú mi teneva indietro nel mio latino. Di nessun altro poi de' poeti nostri aveva io cognizione; se non se di alcune opere del Metastasio, come il Catone, l'Artaserse, l'Olimpiade, ed altre che ci capitavano alle mani come libretti dell'opera di questo, o di quel carnovale. E queste mi dilettavano sommamente; fuorché al venir dell'arietta interrompitrice dello sviluppo degli affetti, appunto quando mi ci cominciava a internare io provava un dispiacere vivi...
[Pagina successiva]