AUTOBIOGRAFIA, di Vittorio Alfieri - pagina 25
...
.
Questo era anche uno dei tanti compensi ch'io aveva ritrovati per rinsavirmi a viva forza.
Stavano i miei legami nascosti sotto il mantellone in cui mi avviluppava, ed avendo libere le mani per leggere, o scrivere, o picchiarmi la testa, chiunque veniva a vedermi non s'accorgeva punto che io fossi attaccato della persona alla seggiola.
E cosí ci passava dell'ore non poche.
Il solo Elia, che era il legatore, era a parte di questo segreto; e mi scioglieva egli poi, quando io sentendomi passato quell'accesso di furiosa imbecillità, sicuro di me, e riassodato il proponimento, gli accennava di sciogliermi.
Ed in tante e sí diverse maniere mi aiutai da codesti fierissimi assalti, che alla fine pure scampai dal ricadere in quel baratro.
E tra le strane maniere che in ciò adoperai, fu certo stranissima quella di una mascherata, ch'io feci nel finire di codesto carnevale, al publico ballo del teatro.
Vestito da Apollo assai bene, osai di presentarmivi con la cetra, e strimpellando alla meglio, di cantarvi alcuni versacci fatti da me, i quali anche con mia confusione trascriverò qui in fondo di pagina(4).
Una tale sfacciataggine era in tutto contraria alla mia indole naturale.
Ma, sentendomi io pur troppo debole ancora a fronte di quella arrabbiata passione, poteva forse meritare un qualche compatimento la cagione che mi movea a fare simili scenate; che altro non era se non se il bisogno ch'io sentiva in me stesso di frapporre come ostacolo per me infrangibile la vergogna del ricadere in quei lacci, che con tante publicità avrei vituperati io medesimo.
E in questo modo, senza avvedermene, io per non dovermi vergognar di bel nuovo, in pubblico mi svergognava.
Né queste ridicole e insulse colascionate avrei osato trascrivere, se non mi paresse di doverle, come un autentico monumento della mia imperizia in ogni convenienza e decenza, qui tributare alla verità.
Fra queste sí fatte scede io mi andava pure davvero infiammando a poco a poco del per me nuovo bellissimo ed altissimo amore di gloria.
E finalmente dopo alcuni mesi di continui consulti poetici, e di logorate grammatiche e stancati vocabolari, e di raccozzati spropositi, io pervenni ad appiccicare alla peggio cinque membri ch'io chiamai atti, e il tutto intitolai Cleopatra tragedia.
E avendo messo al pulito (senza forbirmene) il primo atto, lo mandai al benigno padre Paciaudi, perch'egli me lo spilluzzicasse, e dessemene il di lui parere in iscritto.
E qui pure fedelmente trascriverò alcuni versi di esso(5), con la risposta del Paciaudi(6).
Nelle postille da lui apposte a que' miei versi, alcune eran molto allegre e divertenti, e mi fecero ridere di vero cuore, benché fosse alle spalle mie: e questa tra l'altre.
"Verso 184, il latrato del cor..
Questa metafora è soverchiamente canina.
La prego di torla." Le postille di quel primo atto, ed i consigli che nel paterno biglietto le accompagnavano, mi fecero risolvere a tornar rifare il tutto con piú ostinazione ed arrabbiata pazienza.
Dal che poi ne uscí la cosidetta tragedia, quale si recitò in Torino a dí 16 giugno 1775; della quale pure trascriverò, per terza ed ultima prova della mia asinità nella età non poca di anni venzei e mezzo, i primi versi(7), quanti bastino per osservare i lentissimi progressi, e l'impossibilità di scrivere che tuttavia sussisteva, per mera mancanza dei piú triviali studi.
E nel modo stesso con cui avea tediato il buon padre Paciaudi per cavarne una censura di quella mia seconda prova, andai anche tediando molti altri, tra i quali il conte Agostino Tana mio coetaneo, e stato paggio del re nel tempo ch'io stava nell'Accademia.
L'educazione nostra era perciò stata a un di presso consimile, ma egli dopo uscito di paggio avea costantemente poi applicato alle lettere sí italiane che francesi, ed erasi formato il gusto, massimamente nella parte critica filosofica, e non grammaticale.
L'acume, grazia e leggiadria delle di lui osservazioni su quella mia infelice Cleopatra farebbero ben bene ridere il lettore, se io avessi il coraggio di mostrargliele; ma elle mi scotterebbero troppo, e non sarebbero anche ben intese, non avendo io ricopiato che i soli primi quaranta versi di quel secondo aborto.
Trascriverò bensí la di lui letterina(8) con la quale mi rimandò le postille, e basterà a farlo conoscere.
Io frattanto avea aggiunta una farsetta, che si reciterebbe immediataniente dopo la mia Cleopatra; e la intitolai I poeti.
Per dare anco un saggio della mia incompetenza in prosa, ne trascrivo uno squarcio(9).
Né la farsetta però, né la tragedia, erano le sciocchezze d'uno sciocco; ma un qualche lampo e sale qua e là in tutte due traluceva.
Nei Poeti aveva introdotto me stesso sotto il nome di Zeusippo, e primo io era a deridere la mia Cleopatra, la di cui ombra poi si evocava dall'inferno, perch'ella desse sentenza in compagnia d'alcune altre eroine da tragedia, su questa mia composizione paragonata ad alcune altre tragediesse di questi miei rivali poeti, le quali in tutto poteano ben essere sorelle; col divario però, che le tragedie di costoro erano state il parto maturo di una incapacità erudita, e la mia era un parto affrettato di una ignoranza capace.
Furono queste due composizioni recitate con applauso per due sere consecutive; e richieste poi per la terza, essendo io già ben ravveduto e ripentito in cuore di essermi sí temerariamente esposto al pubblico, ancorché mi si mostrasse soverchio indulgente, io quanto potei mi adoprai con gli attori e con chi era loro superiore, per impedirne ogni ulteriore rappresentazione.
Ma, da quella fatal serata in poi, mi entrò in ogni vena un sí fatto bollore e furore di conseguire un giorno meritatamente una vera palma teatrale, che non mai febbre alcuna di amore mi avea con tanta impetuosità assalito.
In questa guisa comparvi io al pubblico per la prima volta.
E se le mie tante, e pur troppe, composizioni drammatiche in appresso non si sono gran fatto dilungate da quelle due prime, certo alla mia incapacità ho dato principio in un modo assai pazzo e risibile.
Ma se all'incontro poi, verrò quando che sia annoverato fra i non infimi autori sí di tragedie che di commedie, converrà pur dire, chi verrà dopo noi, che il mio burlesco ingresso in Parnasso col socco e coturno ad un tempo, è riuscito poi una cosa assai seria.
Ed a questo tratto fo punto a questa epoca di giovinezza, poiché la mia virilità non poteva da un istante piú fausto ripetere il suo cominciamento.
Epoca quarta
VIRILITÀ
Abbraccia trenta piú anni di composizioni, traduzioni, e studi diversi.
CAPITOLO PRIMO
Ideate, e stese in prosa francese le due prime tragedie il Filippo, e il Polinice.
Intanto un diluvio di pessime rime.
Eccomi ora dunque, sendo in età di quasi anni venzette, entrando nel duro impegno e col pubblico e con me stesso, di farmi autor tragico.
Per sostenere una sí fatta temerità, ecco quali erano per allora i miei capitali.
Un animo risoluto, ostinatissimo, ed indomito; un cuore ripieno ridondante di affetti di ogni specie tra' quali predominavano con bizzarra mistura l'amore e tutte le sue furie, ed una profonda ferocissima rabbia ed abborrimento contra ogni qualsivoglia tirannide.
Aggiungevasi poi a questo semplice istinto della natura mia, una debolissima ed incerta ricordanza delle varie tragedie francesi da me viste in teatro molti anni addietro; che debbo dir per il vero, che fin allora lette non ne avea mai nessuna, non che meditata; aggiungevasi una quasi totale ignoranza delle regole dell'arte tragica, e l'imperizia quasi che totale (come può aver osservato il lettore negli addotti squarci) della divina e necessarissima arte del bene scrivere e padroneggiare la mia propria lingua.
Il tutto poi si ravviluppava nell'indurita scorza di una presunzione, o per dir meglio, petulanza incredibile, e di un tale impeto di carattere, che non mi lasciava, se non se a stento e di rado e fremendo, conoscere, investigare, ed ascoltare la verità.
Capitali, come ben vede il lettore, piú adatti assai per estrarne un cattivo e volgare principe, che non un autor luminoso.
Ma pure una tale segreta voce mi si facea udire in fondo del cuore, ammonendomi in suono anche piú energico che nol faceano i miei pochi veri amici: "E' ti convien di necessità retrocedere, e per cosí dir, rimbambire, studiando ex professo da capo la grammatica, e susseguentemente tutto quel che ci vuole per saper scrivere correttamente e con arte".
E tanto gridò questa voce, ch'io finalmente mi persuasi, e chinai il capo e le spalle.
Cosa oltre ogni dire dolorosa e mortificante, nell'età in cui mi trovava, pensando e sentendo come uomo, di dover pure ristudiare, e ricompitare come ragazzo.
Ma la fiamma di gloria sí avvampante mi tralucea, e la vergogna dei recitati spropositi sí fortemente incalzavami per essermi quando che fosse tolta di dosso, ch'io a poco a poco mi accinsi ad affrontare e trionfare di codesti possenti non meno che schifosi ostacoli.
La recita della Cleopatra mi avea, come dissi, aperto gli occhi, e non tanto sul demerito intrinseco di quel tema per sé stesso infelice, e non tragediabile, da chi che si fosse, non che da un inesperto autore per primo suo saggio; ma me gli avea ancor spalancati a segno di farmi ben bene osservare in tutta la sua immensità lo spazio che mi conveniva percorrere all'indietro, prima di potermi, per cosí dire, ricollocare alle mosse, rientrare nell'aringo, e spingermi con maggiore o minor fortuna verso la meta.
Cadutomi dunque pienamente dagli occhi quel velo che fino a quel punto me gli avea sí fortemente ingombrati, io feci con me stesso un solenne giuramento: che non risparmierei oramai né fatica né noia nessuna per mettermi in grado di sapere la mia lingua quant'uomo d'Italia.
E a questo giuramento m'indussi, perché mi parve, che se io mai potessi giungere una volta al ben dire, non mi dovrebbero mai poi mancare né il ben ideare, né il ben comporre.
Fatto il giuramento, mi inabissai nel vortice grammatichevole, come già Curzio nella voragine, tutto armato, e guardandola.
Quanto piú mi trovava convinto di aver fatto male ogni cosa sino a quel punto, altrettanto mi andava tenendo per certo di poter col tempo far meglio, e ciò tanto piú tenendone quasi una prova evidente nel mio scrigno.
E questa prova erano le due tragedie, il Filippo, ed il Polinice, le quali già tra il marzo e il maggio di quell'anno stesso 1775, cioè tre mesi circa prima che si recitasse la Cleopatra, erano state stese da me in prosa francese; e parimente lette da me ad alcuni pochi, mi era sembrato che ne fossero rimasti colpiti.
Né mi era io persuaso di quest'effetto perché me l'avessero piú o meno lodate; ma per l'attenzione non finta né comandata, con cui le avevano di capo in fondo ascoltate, e perché i taciti moti dei loro commossi aspetti mi parvero dire assai piú che le loro parole.
Ma per mia somma disgrazia, quali che si fossero quelle due tragedie, elle si trovavano concepite e nate in prosa francese, onde rimanea loro lunga e difficile via da calcarsi, prima ch'elle si trasmutassero in poesia italiana.
E in codesta spiacevole e meschina lingua le aveva io stese, non già perché io la sapessi, né punto ci pretendessi, ma perché in quel gergo da me per quei cinque anni di viaggio esclusivamente parlato, e sentito, io mi veniva a spiegare un po' piú, ed a tradire un po' meno il pensiero mio; che sempre pur mi accadeva, per via di non saper nessuna lingua, ciò che accaderebbe ad un volante dei sommi d'Italia, che trovandosi infermo, e sognando di correre a competenza de' suoi eguali o inferiori, null'altro gli mancasse ad ottener la vittoria se non se le gambe.
E questa impossibilità di spiegarmi, e tradurre me stesso, non che in versi ma anche in prosa italiana, era tale, che quando io rileggeva un atto, una scena, di quelle ch'eran piaciute ai miei ascoltatori, nessuno d'essi le riconosceva piú per le stesse, e mi domandavano sul serio, perché l'avessi mutate; tanta era l'influenza dei cangiati abiti e panneggiamenti alla stessa figura, ch'ella non era piú né conoscibile, né sopportabile.
Io mi arrabbiava, e piangeva; ma invano.
Era forza pigliar pazienza, e rifare; ed intanto ingoiarmi le piú insulse e antitragiche letture dei nostri testi di lingua per invasarmi di modi toscani, e direi (se non temessi la sguaiataggine dell'espressione), in due parole direi che mi conveniva tutto il giorno spensare per poi ripensare.
Tuttavia, l'aver io quelle due tragedie future nello scrigno, mi facea prestare alquanto piú pazientemente l'orecchio agli avvisi pedagogici, che d'ogni parte mi pioveano addosso.
E parimente quelle due tragedie mi aveano prestato la forza necessaria per ascoltare la recita a' miei orecchi sgradevolissima della Cleopatra, che ogni verso che pronunziava l'attore mi risuonava nel core come la piú amara critica dell'opera tutta, la quale già fin d'allora era divenuta un nulla ai miei occhi; né la considerava per altro, se non se come lo sprone dell'altre avvenire.
Onde, siccome non mi avvilirono punto le critiche (forse giuste in parte, ma piú assai maligne ed indotte) che mi furono poi fatte su le tragedie della mia prima edizione di Siena del 1783, cosí per l'appunto nulla affatto m'insuperbirono, né mi persuasero, quegli ingiusti non meritati applausi che la platea di Torino, mossa forse a compassione della mia giovenile fidanza e baldanza, mi volle pur tributare.
Primo passo adunque verso la purità toscana essere doveva, e lo fu, di dare interissimo bando ad ogni qualunque lettura francese.
Da quel luglio in poi non volli piú mai proferire parola di codesta lingua, e mi diedi a sfuggire espressamente ogni persona o compagnia da cui si parlasse.
Con tutti questi mezzi non veniva perciò a capo d'italianizzarmi.
Assai male mi piegava agli studi gradati e regolati; ed essendo ogni terzo giorno da capo a ricalcitrare contro gli ammonimenti, io andava pur sempre ritentando di svolazzare coll'ali mie.
Perciò, ogni qualunque pensiero mi cadesse nella fantasia, mi provava di porlo in versi; ed ogni genere, ed ogni metro andava tasteggiando, ed in tutti io mi fiaccava le corne e l'orgoglio, ma l'ostinata speranza non mai.
Tra l'altre di queste rimerie (che poesie non ardirò di chiamarle) una me ne occorse di fare, da essere da me cantata ad un banchetto di liberi muratori.
Era questa, o dovea essere un capitolo allusivo ai diversi utensili e gradi e officiali di quella buffonesca società.
E benché io nel primo sonetto quassú trascritto avessi rubato un verso del Petrarca dai suoi capitoli, con tutto ciò, tanta era la mia disattenzione e ignoranza, che allora cominciai questo mio senza piú ricordarmi, e non l'avendo forse mai bene osservata, la regola delle terzine; e cosí me lo proseguii sbagliando, sino alla duodecima terzina; dove essendomene nato il dubbio, aperto Dante conobbi l'errore, e lo corressi in appresso, ma lasciai le dodici terzine com'elle stavano; e cosí le cantai al banchetto: ma quei liberi muratori tanto intendevan di rime e di poesia, quanto dell'arte di fabbricare; e il mio capitolo passò.
Per ultima prova e saggio degli infruttuosi miei sforzi, trascriverò ancora qui, o gran parte, o tutto forse quel capitolo; secondo che mi basterà la carta, e la pazienza(10).
Verso l'agosto di quell'anno stesso '75, credendomi far vita troppo dissipata stando in città, e non potere perciò studiare abbastanza, me n'andai nei monti che confinano tra il Piemonte e il Delfinato, e passai quasi due mesi in un borguccio, chiamato Cezannes a' piedi del Monginevro, dove è fama che Annibale varcasse l'Alpi.
Io benché riflessivo per natura, talvolta pure sconsiderato per impeto, non riflettei nel prendere quella risoluzione, che in quei monti mi tornerebbe fra i piedi la maladettissima lingua francese, che con giusta e necessaria ostinazione io m'era proposto di sfuggire sempre.
Ma a questo mi indusse quell'abate, ch'io dissi mi avea accompagnato in quel viaggio ridicolo fatto l'anno innanzi a Firenze.
Era quest'abate nativo di Cezannes; chiamavasi Aillaud; era pieno d'ingegno, di una lieta filosofia, e di molta coltura nella letteratura latina e francese.
Egli era stato aio di due fratelli coi quali io m'era trovato assai collegato nella prima gioventú, ed allora aveamo fatto amicizia l'Aillaud ed io; e continuatala dappoi.
Debbo dire pel vero, che codesto abate ne' miei primi anni avea fatto il possibile per inspirarmi l'amore delle lettere, dicendomi che ci avrei potuto riuscire; ma il tutto invano.
E alle volte si era fatto fra noi il seguente risibile patto: ch'egli mi dovrebbe leggere per un'ora intera del romanzo, o novelliere, intitolato Les Milles et une Nuits, con che poi io mi sottomettessi a sentirmi leggere per soli dieci minuti uno squarcio delle tragedie di Racine.
Ed io me ne stava tutto orecchi nel tempo di quella prima insulsa lettura, e mi addormentava poi al suono dei dolcissimi versi di quel gran tragico; cosa, di cui l'Aillaud arrabbiava, e vituperavami, con gran ragione.
Questa era la mia disposizione a diventar tragico, quando stava nel Primo Appartamento della Reale Accademia.
Ma neppur dappoi ho potuto ingoiar mai la cantilena metodica muta e gelidissima dei versi francesi, che non mi sono sembrati mai versi; né quando non mi sapea che cosa si fosse un verso, né quando poi mi parve di saperlo.
Torno a quel mio ritiro estivo in Cezannes, dove oltre l'abate letterato, aveva anche meco un abate citarista, che m'insegnava suonar la chitarra, stromento che mi parea inspirare poesia, e pel quale una qualche disposizione avea; ma non poi la stabile volontà, che si agguagliasse al trasporto che quel suono mi cagionava.
Onde né in questo stromento, né sul cimbalo, che da giovane avea imparato, non ho mai ecceduta la mediocrità, ancorché l'orecchio e la fantasia fossero in me musichevoli nel sommo grado.
Passai cosí quell'estate fra codesti due abati, di cui l'uno mi sollevava dalla angoscia per me sí nuova (dell'applicar seriamente allo studio) col suonarmi la cetra; l'altro poi mi facea dar al diavolo col suo francese.
Con tutto ciò deliziosissimi momenti mi furono, ed utilissimi, quelli in cui mi venne pur fatto di raccogliermi in me stesso; e di lavorare efficacemente e disrugginire il mio povero intelletto, e dischiudere nella memoria le facoltà dell'imparare, le quali oltre ogni credere mi si erano oppilate in quei quasi dieci anni continui d'incallimento nel piú vituperoso letargico ozio.
Subito mi accinsi a tradurre o ridurre in prosa e frase italiana quel Filippo o quel Polinice, nati in veste spuria.
Ma, per quanto mi ci arrovellassi, quelle due tragedie mi rimanevano pur sempre due cose anfibie, ed erano tra il francese e l'italiano senza esser né l'una cosa né l'altra; appunto come dice il Poeta nostro della carta avvampante:
...
un color bruno,
che non è nero ancora, e il bianco muore.
In quest'angoscia di dover fare versi italiani di pensieri francesi mi era già travagliato aspramente anche nel rifare la terza Cleopatra; talché alcune scene di essa, ch'io avea stese e poi lette in francese al mio censor tragico e non grammatico, al conte Agostino Tana, e ch'egli avea trovate forti, e bellissime, tra cui quella d'Antonio con Augusto, allorché poi vennero trasmutate ne' miei versacci poco italiani, slombati, facili, e cantanti, essi gli comparvero una cosa men che mediocre; e me lo disse chiaramente; ed io lo credei; e dirò di piú, che lo sentii anche io.
Tanto è pur vero che in ogni poesia il vestito fa la metà del corpo, ed in alcune (come nella lirica) l'abito fa il tutto; a segno che alcuni versi
con la lor vanità che par persona
trionfano di parecchi altri in cui
fosser gemme legate in vile anello.
E noterò pure qui, che sí al padre Paciaudi, che al conte Tana, e principalmente a questo secondo, io professerò eternamente una riconoscenza somma per le verità che mi dissero, e per avermi a viva forza fatto rientrare nel buon sentiero delle sane lettere.
E tanta era in me la fiducia in questi due soggetti, che il mio destino letterario è stato interamente ad arbitrio loro; ed avrei ad ogni lor minimo cenno buttata al fuoco ogni mia composizione che avessero biasimata, come feci di tante rime, che altra correzione non meritavano.
Sicché, se io ne sono uscito poeta, mi debbo intitolare, per grazia di Dio, e del Paciaudi, e del Tana.
Questi furono i miei santi protettori nella feroce continua battaglia in cui mi convenne passare ben tutto il primo anno della mia vita letteraria, di sempre dar la caccia alle parole e forme francesi, di spogliar per dir cosí le mie idee per rivestirle di nuovo sotto altro aspetto, di riunire in somma nello stesso punto lo studio d'un uomo maturissimo con quello di un ragazzaccio alle prime scuole.
Fatica indicibile, ingratissima, e da ributtare chiunque avesse avuto (ardirò dirlo) una fiamma minor della mia.
Tradotte dunque in mala prosa le due tragedie, come dissi, mi posi all'impresa di leggere e studiare a verso a verso per ordine d'anzianità tutti i nostri poeti primari, e postillarli in margine, non di parole, ma di uno o piú tratticelli perpendicolari ai versi; per accennare a me stesso se piú o meno mi andassero a genio quei pensieri, o quelle espressioni, o quei suoni.
Ma trovando a bella prima Dante riuscirmi pur troppo difficile, cominciai dal Tasso, che non avea mai neppure aperto fino a quel punto.
Ed io leggeva con sí pazza attenzione, volendo osservar tante e sí diverse e sí contrarie cose, che dopo dieci stanze non sapea piú quello ch'io avessi letto, e mi trovava essere piú stanco e rifinito assai che se le avessi io stesso composte.
Ma a poco a poco mi andai formando e l'occhio e la mente a quel faticosissimo genere di lettura; e cosí tutto il Tasso, la Gerusalemme; poi l'Ariosto, il Furioso; poi Dante senza commenti, poi il Petrarca, tutti me gli invasai d'un fiato postillandoli tutti, e v'impiegai forse un anno.
Le difficoltà di Dante, se erano istoriche, poco mi curava di intenderle, se di espressione, di modi, o di voci, tutto faceva per superarle indovinando; ed in molte non riuscendo, le poche poi ch'io vinceva mi insuperbivano tanto piú.
In quella prima lettura io mi cacciai piuttosto in corpo un'indigestione che non una vera quintessenza di quei quattro gran luminari; ma mi preparai cosí a ben intenderli poi nelle letture susseguenti, a sviscerarli, gustarli, e forse anche rassomigliarli.
Il Petrarca però mi riuscí ancor piú difficile che Dante; e da principio mi piacque meno; perché il sommo diletto dei poeti non si può mai estrarre, finché si combatte coll'intenderli.
Ma dovendo io scrivere in verso sciolto, anche di questo cercai di formarmi dei modelli.
Mi fu consigliata la traduzione di Stazio del Bentivoglio.
Con somma avidità la lessi, studiai, e postillai tutta; ma alquanto fiacca me ne parve la struttura del verso per adattarla al dialogo tragico.
Poi mi fecero i miei amici censori capitare alle mani l'Ossian del Cesarotti, e questi furono i versi sciolti che davvero mi piacquero, mi colpirono e m'invasarono.
Questi mi parvero con poca modificazione, un eccellente modello pel verso di dialogo.
Alcune altre tragedie, o nostre italiane, o tradotte dal francese, che io volli pur leggere sperando d'impararvi almeno quanto allo stile, mi cadevano dalle mani per la languidezza, trivialità, e prolissità dei modi e del verso, senza parlare poi della snervatezza dei pensieri.
Tra le men cattive lessi e postillai le quattro traduzioni del Paradisi dal francese, e la Merope originale del Maffei.
E questa, a luoghi mi piacque bastantemente per lo stile, ancorché mi lasciasse pur tanto desiderare per adempirne la perfettibilità, o vera, o sognata, ch'io me n'andava fabbricando nella fantasia.
E spesso andava interrogando me stesso: or, perché mai questa nostra divina lingua, sí maschia ancor ed energica e feroce in bocca di Dante, dovrà ella farsi cosí sbiadita ed eunuca nel dialogo tragico? Perché il Cesarotti che sí vibratamente verseggia nell'Ossian, cosí fiaccamente poi sermoneggia nella Semiramide e nel Maometto del Voltaire da esso tradotte? Perché quel pomposo galleggiante scioltista caposcuola, il Frugoni, nella sua traduzione del Radamisto del Crebillon, è egli sí immensamente minore del Crebillon e di sé medesimo? Certo, ogni altra cosa ne incolperò che la nostra pieghevole e proteiforme favella.
E questi dubbi ch'io proponeva ai miei amici e censori, nissuno me li sciogliea.
L'ottimo Paciaudi mi raccomandava frattanto di non trascurare nelle mie laboriose letture la prosa, ch'egli dottamente denominava la nutrice del verso.
Mi sovviene a questo proposito, che un tal giorno egli mi portò il Galateo del Casa, raccomandandomi di ben meditarlo quanto ai modi, che certo ben pretti toscani erano, ed il contrario d'ogni franceseria.
Io, che da ragazzo lo aveva (come abbiam fatto tutti) maledetto, poco inteso, e niente gustatolo, mi tenni quasiché offeso di questo puerile o pedantesco consiglio.
Onde, pieno di mal talento contro quel Galateo, lo apersi.
Ed alla vista di quel primo Conciossiacosache, a cui poi si accoda quel lungo periodo cotanto pomposo e sí poco sugoso, mi prese un tal impeto di collera, che scagliato per la finestra il libro, gridai quasi maniaco: "Ella è pur dura e stucchevole necessità, che per iscrivere tragedie in età di venzett'anni mi convenga ingoiare di nuovo codeste baie fanciullesche, e prosciugarmi il cervello con sí fatte pedanterie".
Sorrise di questo mio poetico ineducato furore; e mi profetizzò che io leggerei poi il Galateo, e piú d'una volta.
E cosí fu in fatti; ma parecchi anni dopo, quando poi mi era ben bene incallite le spalle ed il collo a sopportare il giogo grammatico.
E non il solo Galateo, ma presso che tutti quei nostri prosatori del Trecento, lessi e postillai poi, con quanto frutto, nol so.
Ma fatto si è che chi gli avesse ben letti quanto ai lor modi, e fosse venuto a capo di prevalersi con giudizio e destrezza dell'oro dei loro abiti, scartando i cenci delle loro idee, quegli potrebbe forse poi ne' suoi scritti sí filosofici che poetici, o istorici, o d'altro qualunque genere, dare una ricchezza, brevità, proprietà, e forza di colorito allo stile, di cui non ho visto finora nessuno scrittore italiano veramente andar corredato.
Forse, perché la fatica è improba; e chi avrebbe l'ingegno, e la capacità di sapersene giovare, non la vuol fare; e chi non ha questi dati, la fa invano.
CAPITOLO SECONDO
Rimessomi sotto il pedagogo a spiegare Orazio.
Primo viaggio letterario in Toscana.
Verso il principio dell'anno '76, trovandomi già da sei e piú mesi ingolfato negli studi italiani, mi nacque una onesta e cocente vergogna di non piú intendere quasi affatto il latino; a segno che, trovando qua e là, come accade, delle citazioni, anco le piú brevi e comuni, mi trovava costretto di saltarle a piè pari, per non perder tempo a diciferarle.
Trovandomi inoltre inibita ogni lettura francese, ridotto al solo italiano, io mi vedeva affatto privo d'ogni soccorso per la lettura teatrale.
Questa ragione, aggiuntasi al rossore, mi sforzò ad intraprendere questa seconda fatica, per poter leggere le tragedie di Seneca, di cui alcuni sublimi tratti mi aveano rapito; e leggere anche le traduzioni letterali latine dei tragici greci, che sogliono essere piú fedeli e meno tediose di quelle tante italiane che sí inutilmente possediamo.
Mi presi dunque pazientemente un ottimo pedagogo, il quale, postomi Fedro in mano, con molta sorpresa sua e rossore mio, vide e mi disse che non l'intendeva, ancorché l'avessi già spiegato in età di dieci anni; ed in fatti provandomici a leggerlo traducendolo in italiano, io pigliava dei grossissimi granchi, e degli sconci equivoci.
Ma il valente pedagogo, avuto ch'egli ebbe cosí ad un tempo stesso il non dubbio saggio e della mia asinità, e della mia tenacissima risoluzione, m'incoraggí molto, e in vece di lasciarmi il Fedro mi diede l'Orazio, dicendomi: "Dal difficile si viene al facile; e cosí sarà cosa piú degna di lei.
Facciamo degli spropositi su questo scabrosissimo principe dei lirici latini, e questi ci appianeran la via per scendere agli altri ".
E cosí si fece; e si prese un Orazio senza commenti nessuni; ed io spropositando, costruendo, indovinando, e sbagliando, tradussi a voce tutte l'Odi dal principio di gennaio a tutto il marzo.
Questo studio mi costò moltissima fatica, ma mi fruttò anche bene, poiché mi rimise in grammatica senza farmi uscire di poesia.
In quel frattempo non tralasciava però di leggere e postillare sempre i poeti italiani, aggiungendone qualcuno dei nuovi, come il Poliziano, il Casa, e ricominciando poi da capo i primari; talché il Petrarca e Dante nello spazio di quattr'anni lessi e postillai forse cinque volte.
E riprovandomi di tempo in tempo a far versi tragici, avea già verseggiato tutto il Filippo.
Ma benchè fosse venuto alquanto men fiacco e men sudicio della Cleopatra, pure quella versificazione mi riusciva languida, prolissa, fastidiosa e triviale.
Ed in fatti quel primo Filippo, che poi alla stampa si contentò di annoiare il pubblico con soli millequattrocento e qualche versi, nei due primi tentativi pertinacemente volle annoiare e disperare il suo autore con piú di due mila versi, in cui egli diceva allora assai meno cose, che nei millequattrocento dappoi.
Quella lungaggine e fiacchezza di stile, ch'io attribuiva assai piú alla penna mia che alla mente mia, persuadendomi finalmente ch'io non potrei mai dir bene italiano finché andava traducendo me stesso dal francese, mi fece finalmente risolvere di andare in Toscana per avvezzarmi a parlare, udire, pensare, e sognare in toscano, e non altrimenti mai piú.
Partii dunque nell'aprile del '76, coll'intenzione di starvi sei mesi, lusingandomi che basterebbero a disfrancesarmi.
Ma sei mesi non disfanno una triste abitudine di dieci e piú anni.
Avviatomi alla volta di Piacenza e di Parma, me n'andava a passo tardo e lento, ora in biroccio, ora a cavallo, in compagnia de' miei poetini tascabili, con pochissimo altro bagaglio, tre soli cavalli, due uomini, la chitarra, e le molte speranze della futura gloria.
Per mezzo del Paciaudi conobbi in Parma, in Modena, in Bologna, e in Toscana, quasi tutti gli uomini di un qualche grido nelle lettere.
E quanto io era stato non curante di tal mercanzia ne' miei primi viaggi, altrettanto e piú era poi divenuto curioso di conoscere i grandi, e i medi in qualunque genere.
Allora conobbi in Parma il celebre nostro stampatore Bodoni, e fu quella la prima stamperia in cui io ponessi mai i piedi, benché fossi stato a Madrid, e a Birmingham, dove erano le due piú insigni stamperie d'Europa, dopo il Bodoni.
Talché io non aveva mai vista un'a di metallo, né alcuno di quei tanti ordigni che mi doveano poi col tempo acquistare o celebrità o canzonatura.
Ma certo in nessuna piú augusta officina io potea mai capitare per la prima volta, né mai ritrovare un piú benigno, piú esperto, e piú ingegnoso espositore di quell'arte maravigliosa che il Bodoni, da cui tanto lustro e accrescimento ha ricevuto e riceve.
Cosí a poco a poco ogni giorno piú ridestandomi dal mio lungo e crasso letargo, io andava vedendo e imparando (un po' tardetto) assai cose.
Ma la piú importante si era per me, ch'io andava ben conoscendo appurando e pesando le mie facoltà intellettuali letterarie, per non isbagliar poi, se poteva, nella scelta del genere.
Né in questo studio di me medesimo io era tanto novizio come negli altri; atteso che piuttosto precedendo l'età che aspettandola, io fin da anni addietro avea talvolta impreso a diciferare a me stesso la mia morale entità; e l'avea fatto anche con penna, non che col pensiero.
Ed ancora conservo una specie di diario che per alcuni mesi avea avuta la costanza di scrivere annoverandovi non solo le mie sciocchezze abituali di giorno in giorno, ma anche i pensieri, e le cagioni intime, che mi faceano operare o parlare: il tutto per vedere, se in cosí appannato specchio mirandomi, il migliorare d'alquanto mi venisse poi a riuscire.
Avea cominciato il diario in francese; lo continuai in italiano; non era bene scritto né in questa lingua, né in quella; era piuttosto originalmente sentito e pensato.
Me ne stufai presto, e feci benissimo; perché ci si perdeva il tempo e l'inchiostro, trovandomi essere tuttavia un giorno peggiore dell'altro.
Serva questo per prova, ch'io poteva forse ben per l'appunto conoscere e giudicare la mia capacità e incapacità letteraria in tutti i suoi punti.
Parendomi dunque ormai discernere appieno tutto quello che mi mancava e quel poco ch'io aveva in proprio dalla natura, io sottilizzava anche piú in là per discernere tra le parti che mi mancavano, quali fossero quelle che mi sarei potute acquistar nell'intero, quali a mezzo soltanto, e quali niente affatto.
A questo sí fatto studio di me stesso io forse sarò poi tenuto (se non di essere riuscito) di non avere almeno tentato mai nessun genere di composizione al quale non mi sentissi irresistibilmente spinto da un violento impulso naturale; impulso, i di cui getti sempre poi in qualunque bell'arte, ancorché l'opera non riesca perfetta, si distinguono di gran lunga dai getti dell'impulso comandato, ancorché potessero pur procreare un'opera in tutte le sue parti perfetta.
Giunto in Pisa vi conobbi tutti i piú celebri professori, e ne andai cavando per l'arte mia tutto quell'utile che si poteva.
Nel fregarmi con costoro, la piú disastrosa fatica ch'io provassi, ell'era d'interrogarli con quel riguardo e destrezza necessaria per non smascherar loro spiattellatamente la mia ignoranza; ed in somma dirò con fratesca metafora, per parer loro professo, essendo tuttavia novizio.
Non già ch'io potessi né volessi spacciarmi per dotto; ma era al buio di tante e poi tante cose, che coi visi nuovi me ne vergognava; e pareami, a misura che mi si andavano dissipando le tenebre, di vedermi sempre piú gigantesca apparire questa mia fatale e pertinace ignoranza.
Ma non meno forse gigantesco era e facevasi il mio ardimento.
Quindi, mentr'io per una parte tributava il dovuto omaggio al sapere d'altrui, non mi atterriva punto per l'altra il mio non sapere; sendomi ben convinto che al far tragedie il primo sapere richiesto, si è il forte sentire; il qual non s'impara.
Restavami da imparare (e non era certo poco) l'arte di fare agli altri sentire quello che mi parea di sentir io.
Nelle sei o sette settimane ch'io dimorai a Pisa, ideai e distesi a dirittura in sufficiente prosa toscana la tragedia d'Antigone, e verseggiai il Polinice un po' men male che il Filippo.
E subito mi parve di poter leggere il Polinice ad alcuni di quei barbassori dell'Università, i quali mi si mostrarono assai soddisfatti della tragedia, e ne censurarono qua e là l'espressioni, ma neppure con quella severità che avrebbe meritata.
In quei versi, a luoghi si trovavan dette cose felicemente; ma il totale della pasta ne riusciva ancora languida, lunga, e triviale a giudizio mio; a giudizio dei barbassori, riusciva scorretta qualche volta, ma fluida, diceano, e sonante.
Non c'intendevamo.
Io chiamava languido e triviale ciò ch'essi diceano fluido e sonante; quanto poi alle scorrezioni, essendo cosa di fatto e non di gusto, non ci cadea contrasto.
Ma neppure su le cose di gusto cadeva contrasto tra noi, perché io a maraviglia tenea la mia parte di discente, come essi la loro di docenti; era però ben fermo di volere prima d'ogni cosa piacere a me stesso.
Da quei signori dunque io mi contentava d'imparare negativamente, ciò che non va fatto; dal tempo, dall'esercizio, dall'ostinazione, e da me, io mi lusingava poi d'imparare quel che va fatto.
E s'io volessi far ridere a spese di quei dotti, com'essi forse avran riso allora alle mie, potrei nominar taluno fra essi, e dei piú pettoruti, che mi consigliava, e portava egli stesso la Tancia del Buonarroti, non dirò per modello, ma per aiuto al mio tragico verseggiare, dicendomi che gran dovizia di lingua e di modi vi troverei.
Il che equivarrebbe a chi proponesse a un pittore di storia di studiare il Callotta.
Altri mi lodava lo stile del Metastasio, come l'ottimo per la tragedia.
Altri, altro.
E nessun di quei dotti era dotto in tragedia.
Nel soggiorno di Pisa tradussi anche la Poetica d'Orazio in prosa con chiarezza e semplicità per invasarmi que' suoi veridici e ingegnosi precetti.
Mi diedi anche molto a leggere le tragedie di Seneca, benché in tutto ben mi avvedessi essere quelle il contrario dei precetti d'Orazio.
Ma alcuni tratti di sublime vero mi trasportavano, e cercava di renderli in versi sciolti per mio doppio studio, di latino e d'italiano, di verseggiare e grandeggiare.
E nel fare questi tentativi mi veniva evidentemente sotto gli occhi la gran differenza tra il verso giambo ed il verso epico, i di cui diversi metri bastano per distinguere ampiamente le ragioni del dialogo da quelle di ogni altra poesia; e nel tempo stesso mi veniva evidentemente dimostrato che noi italiani non avendo altro verso che l'endecasillabo per ogni componimento eroico, bisognava creare una giacitura di parole, un rompere sempre variato di suono, un fraseggiare di brevità e di forza, che venissero a distinguere assolutamente il verso sciolto tragico da ogni altro verso sciolto e rimato sí epico che lirico.
I giambi di Seneca mi convinsero di questa verità, e forse in parte me ne procacciarono i mezzi.
Che alcuni tratti maschi e feroci di quell'autore debbono per metà la loro sublime energia al metro poco sonante, e spezzato.
Ed in fatti qual è sí sprovvisto di sentimento e d'udito, che non noti l'enorme differenza che passa tra questi due versi? L'uno, di Virgilio, che vuol dilettare e rapire il lettore:
Quadrupedante putrem sonitu quatit ungula campum;
l'altro, di Seneca che vuole stupire e atterrir l'uditore; e caratterizzare in due sole parole due personaggi diversi:
Concede mortem.
Si recusares, darem.
Per questa ragione stessa non dovrà dunque un autor tragico italiano nei punti piú appassionati e fieri porre in bocca de' suoi dialogizzanti personaggi dei versi, che quanto al suono in nulla somiglino a quei peraltro stupendi e grandiosissimi del nostro epico:
Chiama gli abitator dell'ombre eterne
il rauco suon della tartarea tromba.
Convinto io nell'intimo cuore della necessità di questa total differenza da serbarsi nei due stili, e tanto piú difficile per noi italiani, quando è giuoco forza crearsela nei limiti dello stesso metro, io dava dunque poco retta ai saccenti di Pisa quanto al fondo dell'arte drammatica, e quanto allo stile da adoprarvisi; gli ascoltava bensí con umiltà e pazienza su la purità toscanesca e grammaticale; ancorché neppure in questo i presenti toscani gran cosa la sfoggino.
Eccomi intanto in meno d'un anno dopo la recita della Cleopatra, possessore in proprio del patrimonietto di tre altre tragedie.
E qui mi tocca di confessare, pel vero, di quai fonti le avessi tratte.
Il Filippo, nato francese, e figlio di francese, mi venne di ricordo dall'aver letto piú anni prima il romanzo di Don Carlos, dell'Abate di San Reale.
Il Polinice, gallo anch'egli, lo trassi dai Fratelli nemici, del Racine.
L'Antigone, prima non imbrattata di origine esotica, mi venne fatta leggendo il duodecimo libro di Stazio nella traduzione su mentovata, del Bentivoglio.
Nel Polinice l'avere io inserito alcuni tratti presi nel Racine, ed altri presi dai Sette prodi di Eschilo, che leggicchiai nella traduzione francese del padre Brumoy, mi fece far voto in appresso, di non piú mai leggere tragedie d'altri prima d'aver fatte le mie, allorché trattava soggetti trattati, per non incorrere cosí nella taccia di ladro, ed errare o far bene, del mio.
Chi molto legge prima di comporre, ruba senza avvedersene, e perde l'originalità, se l'avea.
E per questa ragione anche avea abbandonato fin dall'anno innanzi la lettura di Shakespeare (oltre che mi toccava di leggerlo tradotto in francese).
Ma quanto piú mi andava a sangue quell'autore (di cui però benissimo distingueva tutti i difetti), tanto piú me ne volli astenere.
Appena ebbi stesa l'Antigone in prosa, che la lettura di Seneca m'infiammò e sforzò d'ideare ad un parto le due gemelle tragedie, l'Agamennone, e l'Oreste.
Non mi parea con tutto ciò, ch'elli mi siano riuscite in nulla un furto fatto da Seneca.
Nel fin di giugno sloggiai da Pisa, e venni in Firenze, dove mi trattenni tutto il settembre.
Mi vi applicai moltissimo all'impossessarmi della lingua parlabile; e conversando giornalmente con fiorentini, ci pervenni bastantemente.
Onde cominciai da quel tempo a pensare quasi esclusivamente in quella doviziosissima ed elegante lingua; prima indispensabile base per bene scriverla.
Nel soggiorno in Firenze verseggiai per la seconda volta il Filippo da capo in fondo, senza neppur piú guardare quei primi versi, ma rifacendoli dalla prosa.
Ma i progressi mi pareano lentissimi, e spesso mi parea anzi di scapitare che di migliorare.
Nel corrente di agosto, trovandomi una mattina in un crocchio di letterati, udii a caso rammentare l'aneddoto storico di Don Garzia ucciso dal proprio padre Cosimo I.
Questo fatto mi colpí; e siccome stampato non è, me lo procurai manoscritto, estratto dai pubblici archivi di Firenze, e fin d'allora ne ideai la tragedia.
Continuava intanto a schiccherare molte rime, ma tutte mi riuscivano infelici.
E benché non avessi in Firenze nessun amico censore che equivalesse al Tana e al Paciaudi, pure ebbi abbastanza senno e criterio di non ne dar copia a chi che si fosse, e anche la sobrietà di pochissimo andarle recitando.
Il mal esito delle rime non mi scoraggiava con tutto ciò; ma bensí convincevami che non bisognava mai restare di leggerne dell'ottime, e d'impararne a memoria, per invasarmi di forme poetiche.
Onde in quell'estate m'inondai il cervello di versi del Petrarca, di Dante, del Tasso, e sino ai primi tre canti interi dell'Ariosto; convinto in me stesso, che il giorno verrebbe infallibilmente, in cui tutte quelle forme, frasi, e parole d'altri mi tornerebbero poi fuori dalle cellule di esso miste e immedesimate coi miei propri pensieri ed affetti.
CAPITOLO TERZO
Ostinazione negli studi piú ingrati.
Nell'ottobre tornai in Torino, perché non avea prese le misure necessarie per soggiornare piú lungamente fuor di casa, non già perché io mi presumessi intoscanito abbastanza.
Ed anche molte altre frivole ragioni mi fecero tornare.
Tutti i miei cavalli lasciati in Torino mi vi aspettavano e richiamavano; passione che in me contrastò lungamente con le Muse, e non rimase poi perdente davvero, se non se piú d'un anno dopo.
Né mi premeva allora tanto lo studio e la gloria, che non mi pungesse anco molto a riprese la smania del divertirmi; il che mi riusciva assai piú facile in Torino dove c'avea buona casa, aderenze d'ogni sorta, bestie a sufficienza, divagazioni ed amici piú del bisogno.
Malgrado tutti questi ostacoli, non rallentai punto lo studio in quell'inverno; ed anzi mi accrebbi le occupazioni e gl'impegni.
Dopo Orazio intero, avea letti e studiati ad oncia ad oncia piú altri autori, e fra questi Sallustio.
La brevità ed eleganza di quest'istorico mi avea rapito talmente, che mi accinsi con molta applicazione a tradurlo; e ne venni a capo in quell'inverno.
Molto, anzi infinito obbligo io debbo a quel lavoro; che poi piú e piú volte ho rifatto, mutato e limato, non so se con miglioramento dell'opera, ma certamente con molto mio lucro sí nell'intelligenza della lingua latina, che nella padronanza di maneggiar l'italiana.
Era frattanto ritornato di Portogallo l'incomparabile abate Tommaso di Caluso; e trovatomi contro la sua aspettativa ingolfato davvero nella letteratura, e ostinato nello scabroso proposito di farmi autor tragico, egli mi secondò, consigliò, e soccorse di tutti i suoi lumi con benignità e amorevolezza indicibile.
E cosí pure fece l'eruditissimo conte di San Raffaele, ch'io appresi in quell'anno a conoscere, e altri coltissimi individui, i quali tutti a me superiori di età, di dottrina, e d'esperienza nell'arte mi compativano pure, ed incoraggivano; ancorché non ne avessi bisogno atteso il bollore del mio carattere.
Ma la gratitudine che sovra ogni altra professo e sempre professerò a tutti i suddetti personaggi, si è per aver essi umanamente comportata la mia incomportabile petulanza d'allora; la quale, a dir anche il vero, mi andava però di giorno in giorno scemando, a misura che riacquistava lume.
Sul finir di quell'anno '76, ebbi una grandissima e lungamente sospirata consolazione.
Una mattina andato dal Tana, a cui sempre palpitante e tremante io solea portare le mie rime, appena partorite che fossero, gli portai finalmente un sonetto al quale pochissimo trovò che ridire e lo lodò anzi molto come i primi versi ch'io mi facessi meritevoli di un tal nome.
Dopo le tante e continue afflizioni ed umiliazioni ch'io avea provate nel leggergli da piú d'un anno le mie sconcie rime, ch'egli da vero e generoso amico senza misericordia nessuna censurava, e diceva il perché e il suo perché mi appagava; giudichi ciascuno qual soave néttare mi giunsero all'anima quelle insolite sincere lodi.
Era il sonetto una descrizione del ratto di Ganimede, fatto a imitazione dell'inimitabile del Cassiani sul ratto di Proserpina.
Egli è stampato da me il primo tra le mie rime.
E invaghito della lode, tosto ne feci anche due altri, tratto il soggetto dalla favola, e imitai anch'essi come il primo, a cui immediatamente anche nella stampa ho voluto poi che seguitassero.
Tutti e tre si risentono un po' troppo della loro serva origine imitativa, ma pure (s'io non erro) hanno il merito d'essere scritti con una certa evidenza, e bastante eleganza; quale in somma non mi era venuta mai fin allora.
E come tali ho voluto serbarli, e stamparli con pochissime mutazioni molti anni dopo.
In seguito poi di quei tre primi sufficienti sonetti, come se mi si fosse dischiusa una nuova fonte, ne scaturii in quell'inverno troppi altri; i piú, amorosi; ma senza amore che li dettasse.
Per esercizio mero di lingua e di rime avea impreso a descrivere a parte a parte le bellezze palesi d'una amabilissima e leggiadra signora; né per essa io sentiva neppure la minima favilluzza nel cuore; e forse ci si parrà in quei sonetti piú descrittivi che affettuosi.
Tuttavia, siccome non mal verseggiati, ho voluto quasi che tutti conservarli, e dar loro luogo nelle mie rime; dove agli intendenti dell'arte possono forse andare additando i progressi ch'io allora andava facendo gradatamente nella difficilissima arte del dir bene, senza la quale per quanto sia ben concepito e condotto il sonetto, non può aver vita.
Alcuni evidenti progressi nel rimare, e la prosa del Sallustio ridotta a molta brevità con sufficiente chiarezza (ma priva ancora di quella variata armonia, tutta propria sua, della ben concepita prosa), mi aveano ripieno il cuore di ardenti speranze.
Ma siccome ogni altra cosa ch'io faceva, o tentava, tutte aveano sempre per primo ed allora unico scopo, di formarmi uno stile proprio ed ottimo per la tragedia, da quelle occupazioni secondarie di tempo in tempo mi riprovava a risalire alla prima.
Nell'aprile del '77 verseggiai perciò l'Antigone, ch'io, come dissi, avea ideata e stesa ad un tempo, circa un anno prima, essendo in Pisa.
La verseggiai tutta in meno di tre settimane; e parendomi aver acquistata facilità, mi tenni di aver fatto gran cosa.
Ma appena l'ebbi io letta in una società letteraria, dove quasi ogni sera ci radunavamo, ch'io ravvedutomi (benché lodato dagli altri) con mio sommo dolore mi trovai veramente lontanissimo da quel modo di dire ch'io avea tanto profondamente fitto nell'intelletto, senza pur quasi mai ritrovarmelo poi nella penna.
Le lodi di quei colti amici uditori mi persuasero che forse la tragedia quanto agli affetti e condotta ci fosse; ma i miei orecchi e intelletto mi convinsero ch'ella non c'era quanto allo stile.
E nessun altri di ciò poteva a una prima lettura esser giudice competente quanto io stesso, perché quella sospensione, commozione, e curiosità che porta con sé una non conosciuta tragedia, fa sí che l'uditore, ancorché di buon gusto dotato, non può e non vuole, né deve, soverchiamente badare alla locuzione.
Quindi tutto ciò che non è pessimo, passa inosservato, e non spiace.
Ma io che la leggeva conoscendola, fino a un puntino mi dovea avvedere ogni qual volta il pensiero o l'affetto venivano o traditi o menomati dalla non abbastanza o vera, o calda, o breve, o forte, o pomposa espressione.
Persuaso io dunque che non era al punto, e che non ci arrivava, perché in Torino viveva ancor troppo divagato, e non abbastanza solo e con l'arte, subito mi risolvei di tornare in Toscana, dove anche sempre piú mi italianizzereí il concetto.
Che se in Torino non parlava francese, con tutto ciò il nostro gergaccio piemontese ch'io sempre parlava e sentiva tutto il giorno, in nulla riusciva favorevole al pensare e scrivere italiano.
CAPITOLO QUARTO
Secondo viaggio letterario in Toscana, macchiato di stolida pompa cavallina.
Amicizia contratta col Gandellini.
Lavori fatti o ideati in Siena.
Partii nei primi di maggio, previa la consueta permissione che bisognava ottener dal re per uscire dai suoi felicissimi stati.
Il ministro a chi la domandai, mi rispose che io era stato anco l'anno innanzi in Toscana.
Soggiunsi: "E perciò mi propongo di ritornarvi quest'anno".
Ottenni il permesso; ma quella parola mi fece entrar in pensieri, e bollire nella fantasia il disegno che io poi in meno d'un anno mandai pienamente ad effetto, e per cui non mi occorse d'allora in poi mai piú di chiedere permissione nissuna.
In questo secondo viaggio, proponendomi di starvi piú tempo, e fra i miei deliri di vera gloria frammischiandone pur tuttavia non pochi di vanagloria, ci volli condur piú cavalli e piú gente, per recitare in tal guisa le due parti, che di rado si meritano insieme, di poeta e di signore.
Con un treno dunque di otto cavalli, ed il rimanente non discordante da esso, mi avviai alla volta di Genova.
Di là imbarcatomi io col bagaglio e il biroccino, mandai per la via di terra verso Lerici e Sarzana i cavalli.
Questi arrivarono felicemente avendomi preceduto.
Io nella filucca essendo già quasi alla vista di Lerici, fui rimandato indietro dal vento, e costretto di sbarcare a Rapallo, due sole poste distante da Genova.
Sbarcato quivi, e tediandomi di aspettare che il vento tornasse favorevole per ritornare a Lerici, lasciai la filucca con la roba mia, e prese alcune camicie, i miei scritti (dai quali non mi separava mai piú) ed un sol uomo, per le poste a cavallo a traverso quei rompicolli di strade del nudo Appennino me ne venni a Sarzana, dove trovai i cavalli, e dovei poi aspettar la filucca piú di otto giorni.
Ancorché io ci avessi il divertimento dei cavalli, pure non avendo altri libri che l'Orazietto e il Petrarchino di tasca, mi tediava non poco il soggiorno di Sarzana.
Da un prete fratello del mastro di posta mi feci prestare un Tito Livio, autore che (dalle scuole in poi, dove non l'avea né inteso né gustato) non m'era piú capitato alle mani.
Ancorché io smoderatamente mi fossi appassionato della brevità sallustiana, pure la sublimità dei soggetti, e la maestà delle concioni di Livio mi colpirono assai.
Lettovi il fatto di Virginia, e gl'infiammati discorsi d'Icilio, mi trasportai talmente per essi, che tosto ne ideai la tragedia; e l'avrei stesa d'un fiato, se non fossi stato sturbato dalla continua espettativa di quella maledetta filucca, il di cui arrivo mi avrebbe interrotto la composizione.
E qui per l'intelligenza del lettore mi conviene spiegare queste mie parole di cui mi vo servendo sí spesso, ideare, stendere, e verseggiare.
Questi tre respiri con cui ho sempre dato l'essere alle mie tragedie, mi hanno per lo piú procurato il beneficio del tempo, cosí necessario a ben ponderare un componimento di quella importanza; il quale se mai nasce male, difficilmente poi si raddrizza.
Ideare dunque io chiamo, il distribuire il soggetto in atti e scene, stabilire e fissare il numero dei personaggi, e in due paginucce di prosaccia farne quasi l'estratto a scena per scena di quel che diranno e faranno.
Chiamo poi stendere, qualora ripigliando quel primo foglio, a norma della traccia accennata ne riempio le scene dialogizzando in prosa come viene la tragedia intera, senza rifiutar un pensiero, qualunque ei siasi, e scrivendo con impeto quanto ne posso avere, senza punto badare al come.
Verseggiare finalmente chiamo non solamente il porre in versi quella prosa, ma col riposato intelletto assai tempo dopo scernere tra quelle lungaggini del primo getto i migliori pensieri, ridurli a poesia, e leggibili.
Segue poi come di ogni altro componimento il dover successivamente limare, levare, mutare; ma se la tragedia non v'è nell'idearla e distenderla, non si ritrova certo mai piú con le fatiche posteriori.
Questo meccanismo io l'ho osservato in tutte le mie composizioni drammatiche cominciando dal Filippo, e mi son ben convinto ch'egli è per sé stesso piú che i due terzi dell'opera.
Ed in fatti, dopo un certo intervallo, quanto bastasse a non piú ricordarmi affatto di quella prima distribuzione di scene, se io, ripreso in mano quel foglio, alla descrizione di ciascuna scena mi sentiva repentinamente affollarmisi al cuore e alla mente un tumulto di pensieri e di affetti che per cosí dire a viva forza mi spingessero a scrivere, io tosto riceveva quella prima sceneggiatura per buona, e cavata dai visceri del soggetto.
Se non mi si ridestava quell'entusiasmo, pari e maggiore di quando l'avea ideata, io la cangiava od ardeva.
Ricevuta per buona la prima idea, l'adombrarla era rapidissimo, e un atto il giorno ne scriveva, talvolta piú, raramente meno; e quasi sempre nel sesto giorno la tragedia era, non dirò fatta, ma nata.
In tal guisa, non ammettendo io altro giudice che il mio proprio sentire, tutte quelle che non ho potuto scriver cosí, di ridondanza e furore, non le ho poi finite; o, seppur finite, non le ho mai poi verseggiate.
Cosí mi avvenne di un Carlo Primo che immediatamente dopo il Filippo intrapresi di stendere in francese; nel quale abbozzo a mezzo il terz'atto mi si agghiacciò si fattamente il cuore e la mano, che non fu possibile alla penna il proseguirlo.
Cosí d'un Romeo e Giulietta, ch'io pure stesi in intero, ma con qualche stento, e con delle pause.
Onde piú mesi dopo, ripreso in mano quell'infelice abbozzo mi cagionò un tal gelo nell'animo rileggendolo, e tosto poi m'infiammò di tal ira contro me stesso, che senza altrimenti proseguirne la tediosa lettura, lo buttai sul fuoco.
Dal metodo ch'io qui ho prolissamente voluto individuare, ne è poi forse nato l'effetto seguente: che le mie tragedie prese in totalità, tra i difetti non pochi ch'io vi scorgo, e i molti che forse non vedo, elle hanno pure il pregio di essere, o di parere ai piú, fatte di getto, e di un solo attacco collegate in sé stesse, talché ogni parola e pensiero ed azione del quint'atto strettamente s'immedesima con ogni pensiero parola e disposizione del quarto risalendo sino ai primi versi del primo: cosa, che, se non altro, genera necessariamente attenzione nell'uditore, e calor nell'azione.
Quindi è, che stesa cosí la tragedia, non rimanendo poi all'autore altro pensiere che di pacatamente verseggiarla scegliendo l'oro dal piombo, la sollecitudine che suol dare alla mente il lavoro dei versi e l'incontentabile passione dell'eleganza, non può piú nuocer punto al trasporto e furore a cui bisogna ciecamente obbedire nell'ideare e creare cose d'affetto e terribili.
Se chi verrà dopo me giudicherà ch'io con questo metodo abbia ottenuto piú ch'altri efficacemente il mio intento, la presente disgressioncella potrà forse col tempo illuminare e giovare a qualcuno che professi quest'arte; ove io l'abbia sbagliato, servirà perché altri ne inventi un migliore.
Ripiglio il filo della narrazione.
Giunse finalmente a Lerici quella tanto aspettata filucca; ed io, avuta la mia roba, immediatamente partii di Sarzana alla volta di Pisa, accresciuto il mio poetico patrimonio di quella Virginia di piú; soggetto che mi andava veramente a sangue.
Già avea disegnato in me di non trattenermi questa volta in Pisa piú di due giorni; sí perché mi lusingava che per la lingua io profitterei assai piú in Siena dove si parla meglio, e vi son meno forestieri; sí perché nel soggiorno fattovi l'anno innanzi io mi vi era quasi mezzo invaghito di una bella e nobile signorina, la quale anche agiata di beni di fortuna mi sarebbe stata accordata in moglie dai suoi parenti, se io l'avessi chiesta.
Ma su tal punto io era allora d'assai migliorato di alcuni anni prima in Torino, allorché avea consentito che il mio cognato chiedesse per me quella ragazza che poi non mi volle.
Questa volta non volli io lasciar chiedere per me quella che mi avrebbe pur forse voluto, e che sí per l'indole, che per ogni altra ragione mi sarebbe convenuta, e mi piaceva anche non poco.
Ma ott'anni di piú ch'io m'aveva, e tutta l'Europa quasi ch'io avea o bene o male veduta, e l'amor della gloria che m'era entrato addosso, e, la passion dello studio, e la necessità di essere, o di farmi libero, per poter essere intrepido e veridico autore, tutti questi caldissimi sproni mi facean passar oltre, e gridavanmi ferocemente nel cuore, che nella tirannide basta bene ed è anche troppo il viverci solo, ma che mai, riflettendo, vi si può né si dee diventare marito né padre.
Perciò passai l'Arno, e mi trovai tosto in Siena.
E sempre ho benedetto quel punto in cui ci capitai, perché in codesta città combinai un crocchietto di sei o sette individui dotati di un senno, giudizio, gusto e cultura, da non credersi in cosi picciol paese.
Fra questi poi primeggiava di gran lunga il degnissimo Francesco Gori Gandellini, di cui piú d'una volta cara memoria non mi uscirà mai dal cuore.
Una certa somiglianza nei nostri caratteri, lo stesso pensare e sentire (tanto piú raro e pregevole in lui che in me, attese le di lui circostanze tanto diverse dalle mie) ed un reciproco bisogno di sfogare il cuore ridondante delle passioni stesse, ci riunirono ben tosto in vera e calda amicizia.
Questo santo legame della schietta amicizia era, ed è tuttavia, nel mio modo di pensare e di vivere un bisogno di prima necessità; ma la mia ritrosa e difficile e severa natura mi rende e renderà finch'io viva, poco atto ad inspirarla in altrui, e oltre modo ritenuto nel porre in altri la mia.
Perciò nel corso del mio vivere pochissimi amici avrò avuti; ma mi vanto di averli avuti tutti buoni e stimabili assai piú di me.
Né io mai altro ho cercato nell'amicizia se non se il reciproco sfogo delle umane debolezze, affinché il senno e amorevolezza dell'amico venisse attenuando in me e migliorando le non lodevoli e corroborando all'incontro e sublimando le poche lodevoli, e dalle quali l'uomo può trarre utile per altri ed onore per sé.
Tale è la debolezza del volersi far autore.
Ed in questa principalmente, i consigli generosi ed ardenti del Gandellini mi hanno certo prestato non piccolo soccorso ed impulso.
Il desiderio vivissimo ch'io contrassi di meritarmi la stima di codesto raro uomo, mi diede subito una quasi nuova elasticità di mente, un'alacrítà d'intelletto, che non mi lasciava trovar luogo né pace, s'io non procreava prima qualche opera che fosse o mi paresse degna di lui.
Né mai io ho goduto dell'intero esercizio delle mie facoltà intellettuali e inventive, se non se quando il mio cuore si ritrovava ripieno e appagato, e l'animo mio per cosí dire appoggiato o sorretto da un qualche altro ente gradito e stimabile.
Che all'incontro quand'io mi vedeva senza un sí fatto appoggio quasi solo nel mondo, considerandomi come inutile a tutti e caro a nessuno, gli accessi di malinconia, di disinganno e disgusto d'ogni umana cosa, eran tali e sí spessi, ch'io passava allora dei giorni interi, e anco delle settímane senza né volere né potere toccar libro né penna.
Per ottenere dunque e meritare la lode di un uomo cosí stimabile agli occhi miei quanto era il Gori, io mi posi in quell'estate a lavorare con un ardore assai maggiore di prima.
Da lui ebbi il pensiero di porre in tragedia la congiura de' Pazzi.
Il fatto m'era affatto ignoto, ed egli mi suggerí di cercarlo nel Machiavelli a preferenza di qualunque altro storico.
Cosí, per una strana combinazione, quel divino autore che dovea poi in appresso farmisi una delle mie piú care delizie, mi veniva per la seconda volta posto in mano da un altro veracissimo amico, simile in molte cose al già tanto a me caro D'Acunha, ma molto piú erudito e colto di lui.
Ed in fatti, benché il mio terreno non fosse preparato abbastanza per ricevere e fruttificare un tal seme, pure in quel luglio ne lessi di molti squarci qua e là, oltre la narrazione del fatto della congiura.
Quindi, non solo la tragedia ne ideai immediatamente, ma invasato, di quel suo dire originalissimo e sugoso, di lí a pochi giorni mi sentii costretto a lasciare ogni altro studio, e come inspirato e sforzato a scrivere d'un sol fiato i due libri della Tirannide; quasi per l'appunto quali poi molti anni appresso gli stampai.
Fu quello uno sfogo di un animo ridondante e piagato fin dall'infanzia dalle saette dell'abborrita e universale oppressione.
Se in età piú matura io avessi dovuto trattar di nuovo un tal tema, l'avrei forse trattato alquanto piú dottamente, corroborando l'opinione mia colla storia.
Ma nello stamparlo non ho però voluto, col gelo degli anni e la pedanteria del mio poco sapere, indebolire in quel libro la fiamma di gioventú e di nobile e giusto sdegno, che ad ogni pagina d'esso mi parve avvampare, senza scompagnarsi da un certo vero e incalzante raziocinio che mi vi par dominare.
Che se poi vi ho scorti degli sbagli, o delle amplificazioni, come figli d'inesperienza e non mai di mal animo, ce li ho voluti lasciare.
Nessun fine secondo, nessuna privata vendetta mi inspirò quello scritto.
Forse ch'io avrò o male, o falsamente sentito, ovvero con troppa passione.
Ma e quando mai la passione pel vero e pel retto fu troppa, allorché massimamente si tratta di immedesimarla in altrui? Non ho detto che quanto ho sentito, e forse meno che piú.
Ed in quella bollente età il giudicare e raziocinare non eran fors'altro che un puro e generoso sentire.
CAPITOLO QUINTO
Degno amore mi allaccia finalmente per sempre.
Sgravato in tal guisa l'esacerbato mio animo dal lungo e traboccante odio ingenito suo contro la tirannide, io mi sentii tosto richiamato alle opere teatrali; e quel libercoletto, dopo averlo letto all'amico, ed a pochissimi altri, sigillai e posi da parte, né piú ci pensai per molti anni.
Intanto, ripreso il coturno, rapidissimamente distesi ad un tratto l'Agamennone, l'Oreste, e la Virginia.
E circa all'Oreste, mi era nato un dubbio prima di stenderlo, ma il dubbio essendo per sé stesso picciolo e vile, mi venne in magnanima guisa disciolto dall'amico.
Questa tragedia era stata da me ideata in Pisa l'anno innanzi, e mi avea infiammato di tal soggetto la lettura del pessimo Agamennone di Seneca.
Nell'inverno poi, trovandomi io in Torino, squadernando un giorno i miei libri, mi venne aperto un volume delle tragedie del Voltaire, dove la prima parola che mi si presentò fu, Oreste tragedia.
Chiusi subito il libro, indispettito di ritrovarmi un tal competitore fra i moderni, di cui non avea mai saputo che questa tragedia esistesse.
Ne domandai allora ad alcuni, e mi dissero esser quella una delle buone tragedie di quell'autore; il che mi avea molto raffreddato nell'intenzione di dar corpo alla mia.
Trovandomi io dunque poi in Siena, come dissi, ed avendo già steso l'Agamennone, senza piú nemmeno aprire quello di Seneca, per non divenir plagiario, allorché fui sul punto di dovere stender l'Oreste, mi consigliai coll'amico raccontandogli il fatto e chiedendogli in imprestito quello del Voltaire per dargli una scorsa, e quindi o fare il mio o non farlo.
Il Gori, negandomi l'imprestito dell'Oreste francese, soggiunse: "Scriva il suo senza legger quello; e se ella è nato per fare tragedie, il suo sarà o peggiore o migliore od uguale a quell'altro Oreste, ma sarà almeno ben suo".
E cosí feci.
E quel nobile ed alto consiglio divenne d'allora in poi per me un sistema; onde, ogni qual volta mi sono accinto a trattar poi soggetti già trattati da altri moderni, non li lessi mai se non dopo avere steso e verseggiato il mio; e se li aveva visti in palco, cercai di non me ne ricordar punto; e se mal mio grado me ne ricordava, cercai di fare, dove fosse possibile, in tutto il contrario di quelli.
Dal che mi è sembrato che me ne sia ridondata in totalità una faccia ed un tragico andamento, se non buono, almeno ben mio.
Quel soggiorno di circa cinque mesi in Siena fu dunque veramente un balsamo pel mio intelletto e pel mio animo ad un tempo.
Ed oltre tutte le accennate composizioni, vi continuai anche con ostinazione e con frutto lo studio dei classici latini, tra cui Giovenale, che mi fece gran colpo, e lo rilessi poi sempre in appresso non meno di Orazio.
Ma approssimandosi l'inverno, che in Siena non è punto piacevole, e non essendo io ancora ben sanato dalla giovanile impazienza di luogo, mi determinai nell'ottobre di andare a Firenze, non ancora ben certo se vi passerei pur l'inverno, o se me ne tornerei a Torino.
Ed ecco, che appena mi vi fui collocato cosí alla peggio per provarmici un mese, nacque tale accidente, che mi vi collocò e inchiodò per molti anni; accidente, per cui determinatomi per mia buona sorte ad espatriarmi per sempre, io venni fra quelle nuove spontanee ed auree catene ad acquistare davvero la ultima mia letteraria libertà, senza la quale non avrei mai fatto nulla di buono, se pur l'ho fatto.
Fin dall'estate innanzi, ch'io avea come dissi passato intero a Firenze, mi era, senza ch'io 'l volessi, occorsa piú volte agli occhi una gentilissima e bella signora, che per esservi anch'essa forestiera e distinta, non era possibile di non vederla e osservarla; e piú ancora impossibile, che osservata e veduta non piacesse ella sommamente a ciascuno.
Con tutto ciò, ancorché gran parte dei signori di Firenze, e tutti i forestieri di nascita da lei capitassero, io immerso negli studi e nella malinconia, ritroso e selvaggio per indole, e tanto piú sempre intento a sfuggire tra il bel sesso quelle che piú aggradevoli e belle mi pareano, io perciò in quell'estate innanzi non mi feci punto introdurre nella di lei casa; ma nei teatri e spasseggi mi era accaduto di vederla spessissimo.
L'impression prima me n'era rimasta negli occhi, e nella mente ad un tempo, piacevolissima.
Un dolce focoso negli occhi nerissimi accoppiatosi (che raro adiviene) con candidissima pelle e biondi capelli, davano alla di lei bellezza un risalto, da cui difficile era di non rimanere colpito e conquiso.
Età di anni venticinque; molta propensione alle bell'arti e alle lettere; indole d'oro; e, malgrado gli agi di cui abondava, penose e dispiacevoli circostanze domestiche, che poco la lasciavano essere, come il dovea, avventurata e contenta.
Troppi pregi eran questi, per affrontarli.
In quell'autunno dunque sendomi da un mio conoscente proposto piú volte d'introdurmivi, io credutomi forte abbastanza mi arrischiai di accostarmivi; né molto andò ch'io mi trovai quasi senza avvedermene preso.
Tuttavia titubando io ancora tra il sí e il no di questa fiamma novella, nel decembre feci una scorsa a Roma per le poste a cavallo; viaggio pazzo e strapazzatissimo, che non mi fruttò altro che d'aver fatto il sonetto di Roma, pernottando in una bettolaccia di Baccano, dove non mi riuscí mai di poter chiuder occhio.
L'andare, lo stare, e il tornare, furono circa dodici giorni.
Rividi nelle due passate da Siena l'amico Gori, il quale non mi sconsigliò da quei nuovi ceppi, in cui già era piú che un mezzo allacciato; onde il ritorno in Firenze me li ribadí ben tosto per sempre.
Ma l'approssimazione di questa mia quarta ed ultima febbre del cuore si veniva felicemente per me manifestando con sintomi assai diversi dalle tre prime.
In quelle io non m'era ritrovato allora agitato da una passione dell'intelletto la quale contrapesando e frammischiandosi a quella del cuore venisse a formare (per esprimermi col poeta) un misto incognito indistinto, che meno d'alquanto impetuoso e fervente, ne riusciva però piú profondo, sentito, e durevole.
Tale fu la fiamma che da quel punto in poi si andò a poco a poco ponendo in cima d'ogni mio affetto e pensiero, e che non si spegnerà oramai piú in me se non colla vita.
Avvistomi in capo a due mesi che la mia vera donna era quella, poiché invece di ritrovare in essa, come in tutte le volgari donne, un ostacolo alla gloria letteraria, un disturbo alle utili occupazioni, ed un rimpicciolimento direi di pensieri, io ci ritrovava e sprone e conforto ed esempio ad ogni bell'opera; io, conosciuto e apprezzato un sí raro tesoro, mi diedi allora perdutissimamente a lei.
E non errai per certo, poiché piú di dodici anni dopo, mentr'io sto scrivendo queste chiacchiere, entrato oramai nella sgradita stagione dei disinganni, vieppiú sempre di essa mi accendo quanto piú vanno per legge di tempo scemando in lei quei non suoi pregi passeggieri della caduca bellezza.
Ma in lei si innalza, addolcisce, e migliorasi di giorno in giorno il mio animo; ed ardirò dire e creder lo stesso di essa, la quale in me forse appoggia e corrobora il suo.
CAPITOLO SESTO
Donazione intera di tutto il mio alla sorella.
Seconda avarizia.
Cominciai dunque allora a lavorar lietamente, cioè con animo pacato e securo, come di chi ha ritrovato al fine e scopo ed appoggio.
Già era fermo in me stesso di non mi muover piú di Firenze, fintanto almeno che ci rimarrebbe la mia donna a dimora.
Quindi mi convenne mandare ad effetto un disegno ch'io già da gran tempo avea, direi, abbozzato nella mia mente, e che poi mi si era fatto necessità assoluta dacché avea sí indissolubilmente posto il cuore in sí degno oggetto.
Mi erano sempre oltre modo pesate e spiaciute le catene della mia natia servitú; e quella tra l'altre, per cui, con privilegio non invidiabile, i nobili feudatari sono esclusivamente tenuti a chiedere licenza al re di uscire per ogni minimo tempo dagli stati suoi: e questa licenza si otteneva talvolta con qualche difficoltà, o sgarbetto, dal ministro, e sempre poi si ottenea limitata.
Quattro o cinque volte mi era accaduto di doverla chiedere, e benché sempre l'avessi ottenuta, tuttavia trovandola io ingiusta (poiché né i cadetti, né i cittadini di nessuna classe, quando non fossero stati impiegati, erano costretti di ottenerla) sempre con maggior ribrezzo mi vi era piegato, quanto piú in quel frattempo, mi si era rinforzata la barba.
L'ultima poi, che mi era, venuta chiesta, e che, come di sopra accennai mi era stata accordata con una spiacevol parola, mi era riuscita assai dura a inghiottirsi.
Crescevano, oltre ciò, di giorno in giorno i miei scritti.
La Virginia, ch'io avea distesa in quella dovuta libertà e forza che richiede il soggetto; l'avere steso quel libro della Tirannide come se io fossi nato e domiciliato in paese di giusta e verace libertà; il leggere, gustare, e sentir vivamente e Tacito e il Machiavelli, e i pochi altri simili sublimi e liberi autori; il riflettere e conoscere profondamente quale si fosse il mio vero stato, e quanta l'impossibilità di rimanere in Torino stampando, o di stampare rimanendovi; l'essere pur troppo convinto che anche con molti guai e pericoli mi sarebbe avvenuto di stampar fuori, dovunque ch'io mi trovassi, finché rimaneva pur suddito di una legge nostra, che quaggiú citerò; aggiunto poi finalmente a tutte queste non lievi e manifeste ragioni la passione che di me nuovamente si era, con tanta mia felicità ed utilità, impadronita; non dubitai punto, ciò visto, di lavorare con la maggior pertinacia ed ardore all'importante opera di spiemontizzarmi per quanto fosse possibile; ed a lasciare per sempre, ed anche a qualunque costo il mio mal sortito nido natio.
Piú d'un modo di farlo mi si presentava alla mente.
Quello di andar prolungando, d'anno in anno la licenza, chiedendola; ed era forse il piú savio, ma rimaneva anche dubbio, né mai mi vi potea pienamente affidare, dipendendo dall'arbitrio altrui.
Quello di usar sottigliezze, raggiri, e lungaggini, simulando dei debiti, con vendite clandestine, e altri simili compensi per realizzare il fatto mio, ed estrarlo da quel nobil carcere.
Ma questi mezzi eran vili, ed incerti; né mi piacevano punto, fors'anche perché estremi non erano.
Del resto, avvezzo io per carattere a sempre presupporre le cose al peggio, assolutamente voleva anticipando schiarire e decidere questo fatto, al quale mi conveniva poi a ogni modo un giorno o l'altro venirci, o rinunziare all'arte e alla gloria di indipendente e veridico autore.
Determinato dunque di appurar la cosa, e fissare se avrei potuto salvare parte del mio per campare e stampare fuor di paese, mi accinsi vigorosamente all'impresa.
E feci saviamente, ancorché giovine fossi, ed appassionato in tante maniere.
E certo, se io mai (visto il dispotico governo sotto cui mi era toccato di nascere) s'io mai mi fossi lasciato avvantaggiare dal tempo, e trovatomi nel caso di avere stampato fuori paese anche i piú innocenti scritti, la cosa diveniva assai problematica allora, e la mia sussistenza, la mia gloria, la mia libertà, rimanevano interamente ad arbitrio di quell'autorità assoluta, che necessariamente offesa dal mio pensare, scrivere, ed operare dispettosamente generoso e libero, non mi avrebbe certamente poi favorito nell'impresa di rendermi indipendente da essa.
Esisteva in quel tempo una legge in Piemonte, che dice: "Sarà pur anche proibito a chicchessia di fare stampar libri o altri scritti fuori de' nostri Stati, senza licenza de' revisori, sotto pena di scudi sessanta, od altra maggiore, ed eziandio corporale, se cosí esigesse qualche circostanza per un pubblico esempio".
Alla qual legge aggiungendo quest'altra: "I vassalli abitanti de' nostri Stati non potranno assentarsi dai medesimi senza nostra licenza in iscritto".
E fra questi due ceppi si vien facilmente a conchiudere, che io non poteva essere ad un tempo vassallo ed autore.
Io dunque prescelsi di essere autore.
E, nemicissimo com'io era d'ogni sotterfugio ed indugio, presi per disvassallarmi la piú corta e la piú piana via, di fare una interissima donazione in vita d'ogni mio stabile sí infeudato che libero (e questo era piú che i due terzi del tutto) al mio erede naturale, che era la mia sorella Giulia, maritata come dissi col conte di Cumiana.
E cosí feci nella piú solenne e irrevocabile maniera, riserbandomi una pensione annua di lire quattordici mila di Piemonte, cioè zecchini fiorentini mille quattrocento, che venivano ad essere poco piú in circa della metà della mia totale entrata d'allora.
E contentone io rimanevami di perdere l'altra metà, o di comprare con essa l'indipendenza della mia opinione, e la scelta del mio soggiorno, e la libertà dello scrivere.
Ma il dare stabile e intero compimento a codest'affare mi cagionò molte noie e disturbi, attese le molte formalità legali, che trattandosi l'affare da lontano per lettere, consumarono necessariamente assai piú tempo.
Ci vollero oltre ciò le consuete permissioni del re; che in ogni piú privata cosa in quel benedetto paese sempre c'entra, il re.
E fu d'uopo che il mio cognato, facendo per sé e per me, ottenesse dal re la licenza di accettare la mia donazione, e venisse autorizzato a corrispondermene quell'annuale prestazione in qualsivoglia paese mi fosse piaciuto dimorare.
Agli occhi pur anche dei meno accorti manifestissima cosa era, che la principal cagione della mia donazione era stata la determinazione di non abitar piú nel paese: quindi era necessarissimo di ottenerne la permissione dal governo, il quale ad arbitrio suo si sarebbe sempre potuto opporre allo sborso della pensione in paese estero.
Ma, per mia somma fortuna, il re d'allora, il quale certamente avea notizia del mio pensare (avendone io dati non pochi cenni) egli ebbe molto piú piacere di darmi l'andare che non di tenermi.
Onde egli consentí subito a quella mia spontanea spogliazione; ed ambedue fummo contentissimi: egli di perdermi, io di ritrovarmi.
Ma mi par giusto di aggiungere qui una particolarità bastantemente strana, per consolare con essa i malevoli miei, e nello stesso tempo far ridere alle spalle mie chiunque esaminando sé stesso si riconoscerà meno infermo d'animo, e meno bambino ch'io non mi fossi.
In questa particolarità, la quale in me si troverà accoppiata con gli atti di forza che io andava pure facendo, si scorgerà da chi ben osserva e riflette, che talvolta l'uomo, o almeno, che io riuniva in me, per cosí dire, il gigante ed il nano.
Fatto si è, che nel tempo stesso ch'io scriveva la Virginia, e il libro della Tirannide; nel tempo stesso ch'io scuoteva cosí robustamente e scioglieva le mie originarie catene, io continuava pure di vestire l'uniforme del re di Sardegna, essendo fuori paese, e non mi trovando piú da circa quattr'anni al servizio.
E che diran poi i saggi, quand'io confesserò candidamente la ragione perché lo portassi? Perché mi persuadeva di essere in codesto assetto assai piú snello e avvenente della persona.
Ridi, o lettore, che tu n'hai ben donde.
Ed aggiungi del tuo: che io dunque in ciò fare, puerilmente e sconclusionatamente preferiva di forse parere agli altrui occhi piú bello, all'essere stimabile ai miei.
La conclusione di quel mio affare andò frattanto in lunga dal gennaio al novembre di quell'anno '78; atteso che intavolai poi e ultimai come un secondo trattato la permuta di lire cinquemila della prestazione annuale in un capitale di lire centomila di Piemonte, da sborsarmisi dalla sorella.
E questo soffrí qualche difficoltà piú che il primo.
Ma finalmente consentí anche il re che mi fosse mandata tal somma; ed io poi con altre la collocai in uno di quei tanti insidiosi vitalizi di Francia.
Non già ch'io mi fidassi molto piú nel cristianissimo che nel sardo re; ma perché mi pareva intanto che dimezzato cosí il mio avere tra due diverse tirannidi, ne riuscirei alquanto meno precario, e che salverei in tal guisa, se non la borsa, almeno l'intelletto e la penna.
Di questo passo della donazione, epoca per me decisiva e importante (e di cui ho sempre dappoi benedetto il pensiero e l'esito), io non ne feci parte alla donna mia, se non se dopo che l'atto principale fu consolidato e perfetto.
Non volli esporre il delicato suo animo al cimento di dovermi, o biasimare di ciò, e come contrario al mio utile, impedirmelo; ovvero di lodarlo e approvarmelo, come giovevole in qualche aspetto al sempre piú dar base e durata al nostro reciproco amore; poiché questa sola determinazione mia potevami porre in grado di non la dovere abbandonare mai piú.
Quand'essa lo seppe, biasimollo con quella candida ingenuità tutta sua.
Ma non potendolo pure piú impedire, ella vi si acquetò, perdonandomi d'averglielo taciuto.
E tanto piú forse mi riamò, né mi stimò niente meno.
Frattanto, mentre io stava scrivendo lettere a Torino, e riscrivendo, e tornando a scrivere, perché si conchiudessero codeste noie e stitichezze reali, legali, e parentevoli; io, risoluto di non dar addietro, qualunque fosse per essere l'esito, avea ordinato al mio Elia che avea lasciato in Torino, di vendere tutti i mobili ed argenti.
Egli in due mesi di tempo, lavorando indefessamente a ciò mi avea messi insieme da sei e piú mila zecchini, che tosto gli ordinai di farmi sborsare per mezzo di cambiali in Firenze.
Non so per qual caso nascesse, che fra l'avermi egli scritto d'aver questa mia somma nelle mani, e l'eseguire poi l'incarico ch'io gli avea dato rispondendogli a posta corrente di mandar le cambiali, corsero piú di tre settimane in cui non ricevei piú né lettere di lui, né altro; né avviso di banchiere nessuno.
Benché io non sia per carattere molto diffidente, tuttavia poteva pur ragionevolmente entrare in qualche sospetto, vedendo in circostanze cosí urgenti una sí strana tardanza per parte d'un uomo sí sollecito ed esatto come l'Elia.
Mi entrò dunque non poca diffidenza nel cuore; e la fantasia (in me sempre ardentissima) mi fabbricò questo danno che era tra i possibili, come se veramente già mi fosse accaduto.
Onde io credei fermamente per piú di quindici giorni che i miei sei mila zecchini fossero iti all'aria insieme con l'ottima opinione ch'io mi era sempre giustamente tenuta di quell'Elia.
Ciò posto io mi trovava allora in due circostanze.
L'affare con la sorella non era sistemato ancora; e sempre ricevendo nuove cavillazioni dal cognato, che tutte le sue private obbiezioni me le andava sempre facendo in nome e autorità del re; io gli avea finalmente risposto con ira e disprezzo: che se essi non voleano Donato, pigliassero pure Pigliato; perché io a ogni modo non ci tornerei mai, e poco m'importava di essi e dei lor danari e del loro re, che si tenessero il tutto e fosse cosa finita.
Ed io era in fatti risolutissimo all'espatriazione perpetua, a costo pur anche del mendicare.
Dunque per questa parte trovandomi in dubbio d'ogni cosa, e per quella dei mobili realizzati non mi vedendo sicuro di nulla, io me la passai cosí fantasticando e vedendomi sempre la squallida povertà innanzi agli occhi, finché mi pervennero le cambiali d'Elia, e vistomi possessore di quella piccola somma non dovei piú temere per la sussistenza.
In quei deliri di fantasia, l'arte che mi si prepresentava come la piú propria per farmi campare, era quella del domacavalli, in cui sono o mi par d'essere maestro; ed è certamente una delle meno servili.
Ed anche mi sembrava che questa dovesse riuscirmi la piú combinabile con quella di poeta, potendosi assai piú facilmente scriver tragedie nella stalla che in corte.
Ma già, prima di trovarmi in queste angustie piú immaginate che vere, appena ebbi fatta la donazione, io avea congedato tutti i miei servi meno uno per me, ed uno per cucinarmi; che poco dopo anche licenziai.
E da quel punto in poi, benché io fossi già assai parco nel vitto, contrassi l'egregia e salutare abitudine di una sobrietà non comune; lasciato interamente il vino, il caffè, e simili, e ristrettomi ai semplicissimi cibi di riso, e lesso, ed arrosto, senza mai variare le specie per anni interi.
Dei cavalli, quattro ne avea rimandati a Torino perché si vendessero con quelli che ci avea lasciati partendone; ed altri quattro li regalai ciascuno a diversi signori fiorentini, i quali benché fossero semplicemente miei conoscenti e non già amici, avendo tuttavia assai meno orgoglio di me gli accettarono.
Tutti gli abiti parimenti donai al mio cameriere, ed allora poi anche sagrificai l'uniforme; e indossai l'abito nero per la sera, e un turchinaccio per la mattina, colori che non ho poi deposti mai piú, e che mi vestiranno fino alla tomba.
E cosí in ogni altro genere mi andai sempre piú restringendo anche anche grettamente al semplicissimo necessario, a tal segno ch'io mi ritrovai ad un medesimo tempo e donator d'ogni cosa ed avaro.
Dispostissimo in questa guisa a tutto ciò che mai mi potrebbe accadere di peggio, non mi tenendo aver altro che quei sei mila zecchini, che subito inabissai in uno dei vitalizi di Francia; ed essendo la mia natura sempre inclinata agli estremi, la mia economia e indipendenza andò a poco a poco tant'oltre, che ogni giorno inventandomi una nuova privazione, caddi nel sordido quasi; e dico quasi, perché pur sempre mutai la camicia ogni giorno, e non trascurai la persona; ma lo stomaco, se a lui toccasse di scrivere la mia vita, tolto ogni quasi, direbbe ch'io m'era fatto sordidissimo.
E questo fu il secondo, e crederei l'ultimo accesso di un sí fastidioso e sí turpe morbo che degrada pur tanto l'animo, e l'intelletto restringe.
Ma benché ogni giorno andassi sottilizzando per negarmi o diminuirmi una qualche cosa, io andava pure spendendo in libri, e non poco.
Raccolsi allora quasi tutti i libri nostri di lingua, ed in copia le piú belle edizioni dei classici latini.
E in tutti l'un dopo l'altro, e replicatamente li lessi, ma troppo presto e con troppa avidità, onde non mi fecero quel frutto che me ne sarebbe ridondato leggendoli pacatamente, e ingoiandomi le note.
Cosa alla quale mi son poi piegato tardissimo, avendo sempre da giovane anteposto l'indovinare i passi difficili, o il saltarli a piè pari, all'apianarmeli colla lettura e meditazione dei commenti.
Le mie composizioni frattanto nel decorso di quell'anno borsale 1778, non dirò che fossero tralasciate, ma elle si risentivano dei tanti disturbi antiletterari in cui m'era ingolfato di necessità.
E circa poi al punto principale per me, cioè la padronanza della lingua toscana, mi si era aggiunto anche un nuovo ostacolo, ed era, che la mia donna non sapendo allora quasi punto l'italiano, io mi era trovato costretto a ricader nel francese, parlandolo e sentendolo parlare continuamente in casa sua.
Nel rimanente del giorno io cercava poi il contravveleno dei gallicismi nei nostri ottimi e noiosi prosatori trecentisti, e feci su questo proposito delle fatiche niente poetiche, ma veramente da asino.
A poco a poco pure spuntai, che l'amata imparasse perfettamente l'italiano sí per leggere che per parlare; e vi riuscí quanto e piú ch'altra mai forestiera che vi si accingesse; e lo parlò anzi con una assai migliore pronunzia che non lo parlano le donne d'Italia non toscane, che tutte, o sian lombarde, o veneziane o napoletane o anche romane, lacerano quale in un modo quale nell'altro, ogni orecchio che siasi avvezzo al soavissimo, e vibratissimo accento toscano.
Ma per quanto la mia donna non parlasse tosto altra lingua con me, tuttavia la casa sua sempre ripiena di oltramontaneria era per il mio povero toscanismo un continuo martirio; talché, oltre parecchie altre, io ebbi anche questa contrarietà, di esser stato presso che tre anni allora in Firenze, e d'avervi assai piú dovuto ingoiare dei suoni francesi, che non dei toscani.
E in quasi tutto il decorso della mia vita, finora, mi è toccata in sorte questa barbaria di gallicheria; onde, se io pure sarò potuto riuscire a scrivere correttamente, puramente, e con sapore di toscanità (senza però ricercarla con affettazione e indiscrezione), ne dovrò riportar doppia lode, attesi gli ostacoli; e se riuscito non ci sono, ne meriterò ampia scusa.
CAPITOLO SETTIMO
Caldi studi in Firenze
Nell'aprile del '78, dopo aver verseggiata la Virginia, e quasi che tutto l'Agamennone, ebbi una breve ma forte malattia infiammatoria, con un'angina, che costrinse il medico a dissanguarmi; il che mi lasciò una lunga convalescenza, e fu epoca per me di un notabile indebolimento di salute in appresso.
L'agitazione, i disturbi, lo studio, e la passione di cuore mi aveano fatto infermare, e benché poi nel finir di quell'anno cessassero interamente i disturbi d'interesse domestico, lo studio e l'amore che sempre andarono crescendo, bastarono a non mi lasciar piú godere in appresso di quella robustezza d'idiota ch'io mi era andata formando in quei dieci anni di dissipazione, e di viaggi quasi continui.
Tuttavia nel venir poi dell'estate, mi riebbi, e moltissimo lavorai.
L'estate è la mia stagione favorita; e tanto piú mii si confà, quanto piú eccessiva riesce; massimamente pel comporre.
Fin dal maggio di quell'anno avea dato principio ad un poemetto in ottava rima, su la uccisione del duca Alessandro da Lorenzino de' Medici; fatto, che essendomi piaciuto molto, ma non lo trovando suscettibile di tragedia, mi si affacciò piuttosto come poema.
Lo andava lavorando a pezzi, senza averne steso abbozzo nessuno, per esercitarmi al far rime, da cui gli sciolti delle oramai già tante tragedie mi andavano deviando.
Andava anche scrivendo alcune rime d'amore, sí per lodare la mia donna, che per isfogare le tante angustie in cui, attese le di lei circostanze domestiche, mi conveniva passare molt'ore.
E hanno cominciamento le mie rime per essa, da quel sonetto (tra gli stampati da me) che dice:
Negri, vivaci, in dolce fuoco ardenti;
dopo il quale tutte le rime amorose che seguono, tutte sono per essa, e ben sue, e di lei solamente, poiché mai d'altra donna per certo non canterò.
E mi pare che in esse (siano con piú o meno felicità ed eleganza concepite e verseggiate), vi dovrebbe pure per lo piú trasparire quell'immenso affetto che mi sforzava di scriverle, e ch'io ogni giorno piú mi sentiva crescer per lei; e ciò massimamente, credo, si potrà scorgere nelle rime scritte quando poi mi trovai per gran tempo disgiunto da essa.
Torno alle occupazioni del '78.
Nel luglio distesi con una febbre frenetica di libertà la tragedia de' Pazzi; quindi immediatamente il Don Garzia.
Tosto dopo ideai e distribuii in capitoli i tre libri Del principe e delle lettere, e ne distesi i primi tre capitoli.
Poi, non mi sentendo lingua abbastanza per ben esprimere i miei pensamenti, lo differii per non averlo poi a rifonder tutto allorché ci tornerei per correggerlo.
Nell'agosto di quell'anno stesso, a suggerimento e soddisfazione dell'amata, ideai la Maria Stuarda.
Dal settembre in giú verseggiai l'Oreste, con cui terminai quell'anno per me travagliatissimo.
Passavano allora i miei giorni in una quasi perfetta calma; e sarebbe stata intera, se non fossi stato spesso angustiato del vedere la mia donna angustiata da continui dispiaceri domestici cagionatile dal querulo, sragionevole, e sempre ebro attempato marito.
Le sue pene eran mie; e vi ho successivamente patito dolori di morte.
Io non la poteva vedere se non la sera, e talvolta a pranzo da lei; ma sempre presente lo sposo, o al piú standosi egli di continuo nella camera contigua.
Non già ch'egli avesse ombra di me piú che d'altri; ma era tale il di lui sistema; ed in nove anni e piú che vissero insieme quei due coniugi, mai e poi mai e poi mai non è uscito egli di casa senza di lei, né ella senz'esso; continuità che riuscirebbe stucchevole perfino fra due coetanei amanti.
Io dunque tutto l'intero giorno me ne stava in casa studiando, dopo aver cavalcato la mattina per un par d'ore un ronzino d'affitto per mera salute.
La sera poi io trovava il sollievo della sua vista, ma amareggiato pur troppo dal vederla come dissi quasi sempre afflitta, ed oppressa.
Se io non avessi avuta la tenacissima occupazione dello studio, non mi sarei potuto piegare al vederla sí poco, e in tal modo.
Ma anche, se io non avessi avuto quell'unico sollievo della sua dolcissima vista per contravveleno all'asprezza della mia solitudine non avrei mai potuto resistere a uno studio cosí continuo, e cosí, direi, arrabbiato.
In tutto il '79 verseggiai la Congiura de' Pazzi; ideai la Rosmunda, l'Ottavia, e il Timoleone; stesi la Rosmunda, e Maria Stuarda; verseggiai il Don Garzia; terminai il primo canto del poema, e inoltrai non poco il secondo.
In mezzo a sí calde e faticose occupazioni della mente, mi trovava anche soddisfatti gli affetti del cuore, tra l'amata donna presente, e due amici lontani, con cui mi andava sfogando per lettere.
Era l'uno di questi, il Gori di Siena, il quale anche due o tre volte era venuto in Firenze a vedermi; l'altro era l'ottimo abate di Caluso, il quale verso la metà di quell'anno '79 venne poi in Firenze, chiamatovi in parte dall'intenzione di godersi per un anno quella beatissima lingua toscana, ed in parte (me ne lusingo) chiamatovi dal piacere di essere con chi gli volea tanto bene quanto io; ed anche per darsi ai suoi studi piú quetamente e liberamente che non gli veniva fatto in Torino, dove fra i suoi tanti e fratelli, e nipoti, e cugini, e indiscreti d'altro genere la di lui mansueta e condiscendente natura lo costringeva ad essere assai piú d'altri che suo.
Un anno presso che intero egli stette dunque in Firenze; ci vedevamo ogni giorno, e si passava insieme di molte ore del dopo pranzo.
Ed io nella di lui piacevole ed erudita conversazione imparai senza quasi avvedermene piú cose assai che non avrei fatto in molti anni sudando su molti libri.
E tra l'altre, quella di cui gli avrò eterna gratitudine, si è di avermi egli insegnato a gustare e sentire e discernere la bella ed immensa varietà dei versi di Virgilio, da me fin allora soltanto letti ed intesi; il che per la lettura di un poeta di tal fatta, e per l'utile che ne dee ridondare a chi legge, viene a dir quanto nulla.
Ho tentato poi (non so con quanta felicità) di trasportare nel mio verso sciolto di dialogo quella incessante varietà d'armonia, per cui raramente due versi somigliantisi si accoppino; quelle diverse sedi d'interrompimento, e quelle trasposizioni (per quanto l'indole della lingua nostra il concede), dalle quali il verseggiar di Virgilio riesce sí maraviglioso, e sí diverso da Lucano, da Ovidio, e da tutti.
Differenze difficili ad esprimersi con parole, e poco concepibili da chi dell'arte non è.
Ed era pur necessario ch'io mi andassi aiutando qua e là per far tesoro di forme e di modi, per cui il meccanismo del mio verso tragico assumesse una faccia sua propria, e si venisse a rialzare da per sé, per forza di struttura; mentre non si può in tal genere di composizione aiutare il verso, né gonfiarlo con i lunghi periodi, né con le molte immagini, né con le troppe trasposizioni, né con la soverchia pompa o stranezza dei vocaboli, né con ricercati epiteti: ma la sola semplice e dignitosa sua giacitura di parole infonde in esso la essenza del verso, senza punto fargli perdere la possibile naturalezza del dialogo.
Ma tutto questo, ch'io forse qui mal esprimo, e ch'io aveva fin d'allora, e ogni dí piú caldamente, scolpito nella mente mia non lo acquistai nella penna se non se molti anni dopo, se pur mai lo acquistai: e forse fu quando poi ristampai le tragedie in Parigi.
Che se il leggere, studiare, gustare, e discernere, e sviscerare le bellezze ed i modi del Dante e Petrarca mi poterono infonder forse la capacità di rimare sufficientemente e con qualche sapore; l'arte del verso sciolto tragico (ove ch'io mi trovassi poi d'averla o avuta o accennata) non la ripeterò da altri che da Virgilio, dal Cesarotti, e da me medesimo.
Ma intanto, prima che io pervenissi a dilucidare in me l'essenza di questo stile da crearsi, mi toccò in sorte di errare assai lungamente brancolando, e di cadere anche spesso nello stentato ed oscuro, per voler troppo sfuggire il fiacco e il triviale; del che ho ampiamente parlato altrove quando mi occorse di dare ragione del mio scrivere.
Nell'anno susseguente, 1780, verseggiai la Maria Stuarda; stesi l'Ottavia e il Timoleone; di cui, questa era frutto della lettura di Plutarco, ch'io avea anche ripigliato; quella, era figlia mera di Tacito, ch'io leggeva e rileggeva con trasporto.
Riverseggiai inoltre tutto intero il Filippo, per la terza volta, sempre scemandolo di parecchi versi; ma egli era pur sempre quello che si risentiva il piú della sua origine bastarda, pieno di tante forme straniere ed impure.
Verseggiai la Rosmunda, e gran parte dell'Ottavia, ancorché verso il finir di quell'anno la dovessi poi interrompere, attesi i fieri disturbi di cuore che mi sopravvennero.
CAPITOLO OTTAVO
Accidente per cui di nuovo rivedo Napoli, e Roma, dove mi fisso.
La donna mia (come piú volte accennai) vivevasi angustiatissima; e tanto poi crebbero quei dispiaceri domestici, e le continue vessazioni del marito si terminarono finalmente in una sí violenta scena baccanale nella notte di Sant'Andrea, ch'ella per non soccombere sotto sí orribili trattamenti fu alla per fine costretta di cercare un modo per sottrarsi a sí fatta tirannia, e salvare la salute e la vita.
Ed ecco allora, che io di bel nuovo dovei (contro la natura mia) raggirare presso i potenti di quel governo, per indurli a favorire la liberazione di quell'innocente vittima da un giogo sí barbaro e indegno.
Io, assai ben conscio a me stesso che in codesto fatto operai piú pel bene d'altri che non per il mio; conscio ch'io mai non diedi consiglio estremo alla mia donna, se non quando i mali suoi divennero estremi davvero, perché questa è sempre stata la massima ch'io ho voluta praticare negli affari altrui, e non mai ne' miei propri; e conscio finalmente ch'era cosa oramai del tutto impossibile di procedere altrimenti, non mi abbassai allora, né mi abbasserò mai, a purgarmi delle stolide e maligne imputazioni che mi si fecero in codesta occorrenza.
Mi basti il dire, che io salvai la donna mia dalla tirannide d'un irragionevole e sempre ubriaco padrone, senza che pure vi fosse in nessunissimo modo compromessa la di lei onestà, né leso nella minima parte il decoro di tutti.
Il che certamente a chiunque ha saputo o viste dappresso le circostanze particolari della prigionia durissima in cui ella di continuo ad oncia ad oncia moriva, non parrà essere stata cosa facile a ben condursi, e riuscirla, come pure riuscí a buon esito.
Da prima dunque essa entrò in un monastero in Firenze, condottavi dallo stesso marito come per visitar quel luogo, e dovutavela poi lasciare con somma di lui sorpresa, per ordine e disposizioni date da chi allora comandava in Firenze.
Statavi alcuni giorni, venne poi dal di lei cognato, chiamata in Roma, dove egli abitava; e quivi pure si ritirò in altro monastero.
E le ragioni di sí fatta rottura tra lei e il marito furono tante e sí manifeste, che la separazione fu universalmente approvata.
Partita essa dunque per Roma verso il finir di decembre, io me ne rimasi come orbo derelitto in Firenze; ed allora fui veramente convinto nell'intimo della mente e del cuore, ch'io senza di lei non rimanea neppur mezzo, trovandomi assolutamente quasi incapace d'ogni applicazione, e d'ogni bell'opera, né mi curando piú punto né della tanto ardentemente bramata gloria, né di me stesso.
In codesto affare io avea dunque sí caldamente lavorato per l'util suo, e pel danno mio; poiché niuna infelicità mi potea mai toccare maggiore, che quella di non punto vederla.
Io non potea decentemente seguitarla sí tosto in Roma.
Per altra parte non mi era possibile piú di campare in Firenze.
Vi stetti tuttavia tutto il gennaio dell'81, e mi parvero quelle settimane, degli anni, né potei poi proseguire nessun lavoro, né lettura, né altro.
Presi dunque il compenso di andarmene a Napoli; e scelsi, come ben vede ciascuno, espressamente Napoli, perché ci si va passando di Roma.
Già da un anno e piú mi si era di bel nuovo diradata la sozza caligine della seconda accennata avarizia.
Aveva collocato in due volte piú di centosessanta mila franchi nei vitalizi di Francia; il che mi facea tenere sicura oramai la sussistenza indipendentemente dal Piemonte.
Onde io era tornato ad una giusta spesa; ed avea ricomperato cavalli, ma soli quattro, che ad un poeta n'avanzano.
Il caro abate di Caluso era anche tornato a Torino da piú di sei mesi; quindi io senza nessuno sfogo d'amicizia, e privo della mia donna, non mi sentendo piú esistere, il bel primo di febbraio mi avviai bel bello a cavallo verso Siena, per abbracciarvi l'amico Gori, e sgombrarmi un po' il cuore con esso.
Indi proseguii verso Roma, la di cui approssimazione mi facea palpitare; tanto è diverso l'occhio dell'amante da tutti gli altri.
Quella regione vuota insalubre, che tre anni innanzi mi parea quel ch'era, in questo venire mi si presentava come il piú delizioso soggiorno del mondo.
Giunsi; la vidi (oh Dio, mi si spacca ancora il cuore pensandovi), la vidi prigioniera dietro una grata, meno vessata però che non l'avea vista in Firenze, ma per altra cagione non la rividi meno infelice.
Eramo in somma disgiunti; e chi potea sapere per quanto il saremmo? Ma pure, io mi appagava piangendo, ch'ella si potesse almeno a poco a poco ricuperare in salute; e pensando, ch'ella potrebbe pur respirare un'aria piú libera, dormire tranquilli i suoi sonni, non sempre tremare di quella indivisibile ombra dispettosa dell'ebro marito, ed esistere in somma; tosto mi pareano e men crudeli e men lunghi gli orribili giorni di lontananza, a cui mi era pur forza di assoggettarmi.
Pochissimi giorni mi trattenni in Roma; ed in quelli, Amore mi fece praticare infinite pieghevolezze e destrezze, ch'io non avrei poste in opera né per ottenere l'imperio dell'universo: pieghevolezze, ch'io ferocemente ricusai praticare dappoi, quando presentandomi al limitare del tempio della Gloria, ancorché molto dubbio se vi potrei ottenere l'accesso, non ne volli pur mai lusingare né incensare coloro che n'erano, o si teneano, custodi di esso.
Mi piegai allora al far visite, al corteggiare per anche il di lei cognato, dal quale soltanto dipendeva oramai la di lei futura total libertà, di cui ci andavamo entrambi lusingando.
Io non mi estenderò gran fatto sul proposito di questi due personaggi fratelli, perché furono in quel tempo notissimi a ciascheduno; e sebbene poi verisimilmente l'obblio gli avrà sepolti del tutto col tempo, a me non si aspetta di trarneli, laudare non li potendo né li volendo biasimare.
Ma intanto l'aver io umiliato il mio orgoglio a costoro, può riuscire bastante prova dell'immenso mio amore per essa.
Partii per Napoli, come promesso l'avea, e come, delicatamente operando, il dovea.
Questa separazione seconda mi riuscí ancor piú dolorosa della prima in Firenze.
E già in quella prima lontananza di circa quaranta giorni, io avea provato un saggio funesto delle amarezze che mi aspettavano in questa seconda, piú lunga ed incerta.
In Napoli la vista di quei bellissimi luoghi non essendo nuova per me, ed avendo io una sí profonda piaga nel cuore, non mi diede quel sollievo ch'io me ne riprometteva.
I libri erano quasi che nulla per me; i versi e le tragedie andavan male, o si stavano; ed in somma io non campava che di posta spedita, e di posta ricevuta, a null'altro potendo rivolger l'animo se non se alla mia donna lontana.
E me n'andava sempre solitario cavalcando per quelle amene spiagge di Posilipo e Baia, o verso Capova e Caserta, o altrove, per lo piú piangendo, e sí fattamente annichilato, che col cuore traboccante d'affetti non mi veniva con tutto ciò neppur voglia di tentare di sfogarlo con rime.
Passai in tal guisa il rimanente di febbraio, sin al mezzo maggio.
Tuttavia in certi momenti meno gravosi facendomi forza, qualche poco andai lavorando.
Terminai di verseggiare l'Ottavia; e riverseggiai piú che mezzo il Polinice, che mi parve di una pasta di verso alquanto migliorata.
Avendo finito l'anno innanzi il secondo canto del poemetto, mi volli accingere al terzo; ma non potei procedere oltre la prima stanza, essendo quello un tema troppo lieto per quel mio misero stato d'allora.
Sicché lo scrivere lettere, e il rileggere cento volte le lettere ch'io riceveva di lei, furono quasi esclusivamente le mie occupazioni di quei quattro mesi.
Gli affari della mia donna si andavano frattanto rischiarando alquanto, e verso il fin di marzo ella avea ottenuto licenza dal papa di uscire di monastero, e di starsene tacitamente come divisa dal marito in un appartamento che il cognato (abitante sempre fuori di Roma) le rilasciava nel di lui palazzo in città.
Io avrei voluto tornar a Roma, e sentiva pure benissimo che per allora non si doveva.
I contrasti che prova un cuor tenero ed onorato fra l'amore e il dovere, sono la piú terribile e mortal passione ch'uomo possa mai sopportare.
Io dunque indugiai tutto l'aprile, e tutto il maggio m'era anche proposto di strascinarlo cosí, ma verso il dodici d'esso mi ritrovai, quasi senza saperlo, in Roma.
Appena giuntovi, addottrinato ed inspirato dalla Necessità e da Amore, diedi proseguimento e compimento al già intrapreso corso di pieghevolezze e astuziole cortigianesche per pure abitare la stessa città e vedervi l'adorata donna.
Onde dopo tante smanie, fatiche, e sforzi per farmi libero, mi trovai trasformato ad un tratto in uomo visitante, riverenziante, e piaggiante in Roma, come un candidato che avrebbe postulato inoltrarsi nella prelatura.
Tutto feci, a ogni cosa mi piegai, e rimasi in Roma, tollerato da quei barbassori, e aiutato anco da quei pretacchiuoli che aveano o si pigliavano una qualche ingerenza negli affari della donna mia.
Ma buon per essa, che non dipendeva dal cognato, e dalla di lui trista sequela, se non se nelle cose di mera convenienza, e nulla poi nelle di lei sostanze, le quali essa aveva in copia per altra parte, ed assai onorevoli, e per allora sicurissime.
CAPITOLO NONO
Studi ripresi ardentemente in Roma.
Compimento delle quattordici prime tragedie.
Tosto ch'io un tal poco respirai da codesti esercizi di semiservitú, contento oltre ogni dire di un'onesta libertà per cui mi era dato di visitare ogni sera l'amata, mi restituii tutto intero agli studi.
Ripreso dunque il Polinice, terminai di riverseggiarlo; e senza piú pigliar fiato, proseguii da capo l'Antigone, poi la Virginia, e successivamente l'Agamennone, l'Oreste, i Pazzi, il Garzia; poi il Timoleone che non era stato ancor posto in versi; ed in ultimo, per la quarta volta, il renitente Filippo.
E mi andava tal volta sollevando da quella troppo continuità di far versi sciolti, proseguendo il terzo canto del poemetto; e nel decembre di quell'anno stesso composi d'un fiato le quattro prime lodi dell'America libera.
A queste m'indusse la lettura di alcune bellissime e nobili odi del Filicaia, che altamente mi piacquero.
Ed io stesi le mie quattro in sette soli giorni, e la terza intera in un giorno solo, ed esse con picciole mutazioni sono poi rimaste quali furono concepite.
Tanta è la differenza (almeno per la mia penna) che passa tra il verseggiare in rima liricamente, o il far versi sciolti di dialogo.
Nel principio dell'anno '82, vedendomi poi tanto inoltrate le tragedie, entrai in speranza, che potrei dar loro compimento in quell'anno.
Fin dalla prima io mi era proposto di non eccedere il numero di dodici; e me le trovava allora tutte concepite, e distese, e verseggiate; e riverseggiate le piú.
Senza discontinuare dunque proseguiva a riverseggiare, e limare quelle che erano rimaste; sempre progredendole successivamente nell'ordine stesso con cui elle erano state concepite, e distese.
In quel frattempo, verso il febbraio dell'82, tornatami un giorno fra le mani la Merope del Maffei per pur vedere s'io c'imparava qualche cosa quanto allo stile, leggendone qua e là degli squarci mi sentii destare improvvisamente un certo bollore d'indegnazione e di collera nel vedere la nostra Italia in tanta miseria e cecità teatrale che facessero credere o parere quella come l'ottima e sola delle tragedie, non che delle fatte fin allora (che questo lo assento anch'io), ma di quante se ne potrebber far poi in Italia.
E immediatamente mi si mostrò quasi un lampo altra tragedia dello stesso nome e fatto, assai piú semplice e calda e incalzante di quella.
Tale mi si appresentò nel farsi ella da me concepire, direi per forza.
S'ella sia poi veramente riuscita tale, lo decideranno quelli che verran dopo noi.
Se mai con qualche fondamento chi schicchera versi ha potuto dire est Deus in nobis, lo posso certo dir io, nell'atto che io ideai, distesi, e verseggiai la mia Merope, che non mi diede mai tregua né pace finch'ella non ottenesse da me l'una dopo l'altra queste tre creazioni diverse, contro il mio solito di tutte l'altre, che con lunghi intervalli riceveano sempre queste diverse mani d'opera.
E lo stesso dovrò dire pel vero, risguardo al Saulle.
Fin dal marzo di quell'anno mi era dato assai alla lettura della Bibbia, ma non però regolatamente con ordine.
Bastò nondimeno perch'io m'infiammassi del molto poetico che si può trarre da codesta lettura, e che non potessi piú stare a segno, s'io con una qualche composizione biblica non dava sfogo a quell'invasamento che n'avea ricevuto.
Ideai dunque, e distesi, e tosto poi verseggiai anche il Saulle, che fu la decimaquarta, e secondo il mio proposito d'allora l'ultima dovea essere di tutte le mie tragedie.
E in quell'anno mi bolliva talmente nella fantasia la facoltà inventrice, che se non l'avessi frenata con questo proponimento, almeno altre due tragedie bibliche mi si affacciavano prepotentemente, e mi avrebbero strascinato; ma stetti fermo al proposito, e parendomi essere le quattordici anzi troppo che poche, lí feci punto.
Ed anzi (nemico io sempre del troppo, ancorché ad ogni altro estremo la mia natura mi soglia trasportare) nello stendere la Merope e il Saulle mi facea tanto ribrezzo l'eccedere il numero che avea fissato, ch'io promisi a me stesso di non le verseggiare, se non quando avrei assolutamente finite e strafinite tutte l'altre; e se non riceveva da esse in intero l'effetto stessissimo, ed anche maggiore, che avea provato nello stenderle, promisi anche a me di non proseguirle altrimenti.
Ma che valsero e freni, e promesse, e propositi? Non potei mai far altro, né ritornar su le prime, innanzi che quelle due ultime avessero ricevuto il loro compimento.
Cosí son nate queste due; spontanee piú che tutte l'altre; dividerò con esse la gloria, s'esse l'avranno acquistata e meritata; lascierò ad esse la piú gran parte del biasimo, se lo incontreranno; poiché e nascere e frammischiarsi coll'altre a viva forza han voluto.
Né alcuna mi costò meno fatica, e men tempo di queste due.
Intanto verso il fin del settembre di quell'anno stesso '82, tutte quattordici furono dettate, ricopiate, e corrette; aggiungerei, e limate, ma in capo a pochi mesi m'avvidi e convinsi, che da ciò ell'erano ancor molto lontane.
Ma per allora il credei, e mi tenni essere il primo uomo del mondo; vedendomi avere in dieci mesi verseggiate sette tragedie; inventatene, stese, e verseggiate due nuove; e finalmente, dettatene quattordici, correggendole.
Quel mese di ottobre, per me memorabile, fu dunque dopo sí calde fatiche un riposo non men delizioso che necessario; ed alcuni giorni impiegai in un viaggetto a cavallo sino a Terni per veder quella famosa cascata.
Pieno turgido di vanagloria, non lo dicevo però ad altri mai che a me stesso, spiattellatamente, e con un qualche velame di moderazione lo accennava anche alla dolce metà di me stesso; la quale, parendo anch'essa (forse per l'affetto che mi portava) propensa a potermi tenere per un grand'uomo; essa piú ch'altra cosa sempre piú m'impegnava a tutto tentare per divenirlo.
Onde dopo un par di mesi di ebbrezza di giovenile amor proprio, da me stesso mi ravvidi nel ripigliar ad esame le mie quattordici tragedie, quanto ancora di spazio mi rimanesse a percorrere prima di giungere alla sospirata meta.
Tuttavia, trovandomi in età di non ancora trentaquattr'anni, e nell'aringo letterario trovandomi giovine di soli otto anni di studio, sperai piú fortemente di prima, che acquisterei pure una volta la palma; e di sí fatta speranza non negherò che me n'andasse tralucendo un qualche raggio sul volto, ancorché l'ascondessi in parole.
In diverse occasioni io era andato leggendo a poco a poco tutte codeste tragedie in varie società sempre miste di uomini e donne, di letterati e d'idioti, di gente accessibile ai diversi affetti e di tangheri.
Nel leggere io le mie produzioni, avea ricercato (parlando pel vero) non men che la lode il vantaggio.
Io conosceva abbastanza e gli uomini ed il bel mondo, per non mi fidare né credere stupidamente in quelle lodi del labro, che non si negano quasi mai ad un autore leggente, che non chiede nulla, e si sfiata in un ceto di persone ben educate e cortesi: onde a sí fatte lodi io dava il loro giusto valore, e non piú.
Ma molto badava, ed apprezzava le lodi ed il biasimo, ch'io per contrapposto al labro le appellerei del sedere, se non fosse sconcia espressione; cotanto ella mi par vera e calzante.
E mi spiego.
Ogniqualvolta si troveranno riuniti dodici o quindici individui, misti come dissi, lo spirito collettivo che si verrà a formare in questa varia adunanza, si accosterà e somiglierà assai al totale di una pubblica udienza teatrale.
E ancorché questi pochi non vi assistano pagando, e la civiltà voglia ch'essi vi stiano in piú composto contegno; pure, la noia ed il gelo di chi sta ascoltando non si possono mai nascondere, né (molto meno) scambiarsi con una vera attenzione, ed un caldo interesse, e viva curiosità di vedere a qual fine sia per riuscire l'azione.
Non potendo dunque l'ascoltatore né comandare al proprio suo viso, né inchiodarsi direi in su la sedia a sedere; queste due indipendenti parti dell'uomo faranno la giustissima spia al leggente autore, degli affetti e non affetti de' suoi ascoltanti.
E questo era (quasi esclusivamente) quello che io sempre osservava leggendo.
E m'era sembrato sempre (se io pure non travedeva) di avere sul totale di una intera tragedia ottenuto piú che i due terzi del tempo una immobilità e tenacità d'attenzione, ed una calda ansietà di schiarire lo scioglimento; a che mi provava bastantemente ch'egli rimaneva, anche nei piú noti soggetti di tragedia, tuttavia pendente ed incerto sino all'ultimo.
Ma confesserò parimente, che di molte lunghezze, o freddezze, che vi poteano essere qua e là, oltre che io medesimo mi era spesso tediato nel rileggerle ad altri, ne ricevei anche il sincerissimo tacito biasimo, da quei benedetti sbadigli, e involontarie tossi, e irrequieti sederi, che me ne davano, senza avvedersene, certezza ad un tempo ed avviso.
E neppur negherò, che anche degli ottimi consigli, e non pochi, mi siano stati suggeriti dopo quelle diverse letture, da uomini letterati, da uomini di mondo, e spezialmente circa gli affetti, da varie donne.
I letterati battevano su l'elocuzione e le regole dell'arte; gli uomini di mondo, su l'invenzione, la condotta e i caratteri, e perfino i giovevolissimi tangheri, col loro piú o meno russare o scontorcersi; tutti in somma, quanto a me pare, mi riuscirono di molto vantaggio.
Onde io, tutti ascoltando, di tutto ricordandomi, nulla trascurando, e non disprezzando individuo nessuno (ancorché pochissimi ne stimassi), ne trassi poi forse e per me stesso e per l'arte quel meglio che conveniva.
Aggiungerò a tutte queste confessioni per ultima, che io benissimo mi avvedeva, che quell'andar leggendo tragedie in semi-pubblico, un forestiere fra gente non sempre amica, mi poteva e doveva anzi esporre a esser messo in ridicolo.
Non me ne pento però di aver cosí fatto, se ciò poi ridondò in beneficio mio e dell'arte; il che se non fu, il ridicolo delle letture anderà poi con quello tanto maggiore, dell'averle recitate, e stampate.
CAPITOLO DECIMO
Recita dell'Antigone in Roma.
Stampa delle prime quattro tragedie.
Separazione dolorosissima.
Viaggio per la Lombardia.
Io dunque me ne stava cosí in un semiriposo, covando la mia tragica fama, ed irresoluto tuttavia se stamperei allora, o se indugierei dell'altro.
Ed ecco, che mi si presentava spontanea un'occasione di mezzo tra lo stampare e il tacermi; ed era, di farmi recitare da una eletta compagnia di dilettanti signori.
Era questa società teatrale già avviata da qualche tempo a recitare in un teatro privato esistente nel palazzo dell'ambasciatore di Spagna, allora il duca Grimaldi.
Si erano fin allora recitate delle commedie e tragedie, tutte traduzioni, e non buone, dal francese; e tra queste assistei ad una rappresentazione del Conte d'Essex di Tommaso Corneille, messa in verso italiano non so da chi, e recitata la parte di Elisabetta dalla duchessa di Zagarolo, piuttosto male.
Con tutto ciò, vedendo io questa signora essere assai bella e dignitosa di personale, ed intendere benissimo quel che diceva, argomentai che con un po' di buona scuola si sarebbe potuta assaissimo migliorare.
E cosí d'una in altra idea fantasticando, mi entrò in capo di voler provare con questi attori una delle troppe mie.
Voleva convincermi da me stesso, se potrebbe riuscire quella maniera che io avea preferita a tutt'altre; la nuda semplicità dell'azione; i pochissimi personaggi; ed il verso rotto per lo piú su diverse sedi, ed impossibile quasi a cantilenarsi.
A quest'effetto prescelsi l'Antigone, riputandola io l'una delle meno calde tra le mie, e divisando fra me e me, che se questa venisse a riuscire, tanto piú il farebbero l'altre in cui si sviluppan affetti tanto piú vari e feroci.
La proposta di provar quest'Antigone fu accettata con piacere dalla nobile compagnia; e fra quei loro attori non si trovando allora alcun altro che si sentisse capace di recitare in tragedia una parte capitale oltre il duca di Ceri, fratello della predetta duchessa di Zagarolo, mi trovai costretto di assumermi io la parte di Creonte, dando al duca di Ceri quella di Emone; e alla di lui consorte, quella di Argia: la parte principalissima dell'Antigone spettando di dritto alla maestosa duchessa di Zagarolo.
Cosí distribuite le quattro parti, si andò in scena; né altro aggiungerò circa all'esito di quelle rappresentazioni, avendo avuto occasione di parlarne assai lungamente in altri miei scritti.
Insuperbito non poco dal prospero successo della recita, verso il principio del seguente anno mi indussi a tentare per la prima volta la terribile prova dello stampare.
E per quanto già mi paresse scabrosissimo questo passo, ben altrimenti poi lo conobbi esser tale, quando imparai per esperienza cosa si fossero le letterarie inimicizie e raggiri; e gli asti librarii, e le decisioni giornalistiche, e le chiacchiere gazzettarie, e tutto in somma il tristo corredo che non mai si scompagna da chi va sotto i torchi; e tutte queste cose mi erano fin allora state interamente ignote; ed a segno, ch'io neppur sapeva che si facessero giornali letterari, con estratti e giudizi critici delle nuove opere, sí era rozzo, e novizio, e veramente purissimo di coscienza nell'arte scrivana.
Decisa dunque la stampa, e visto che in Roma le stitichezze della revisione eran troppe, scrissi all'amico in Siena, di volersi egli addossar quella briga.
Al che ardentissimamente egli in capite, con altri miei conoscenti ed amici, si prestò di vegliarvi da sé, e fare con diligenza e sollecitudine progredire la stampa.
Non volli avventurare a bella prima che sole quattro tragedie; e di quelle mandai all'amico un pulitissimo manoscritto quanto al carattere e correzione; ma quanto poi alla lindura, chiarezza, ed eleganza dello stile, mi riuscí purtroppo difettoso.
Innocentemente allora io mi credeva, che nel dare un manoscritto allo stampatore fosse terminata ogni fatica dell'autore.
Imparai poi dopo a mie spese, che allora quasi si riprincipia.
In quei due e piú mesi che durava la stampa di codeste quattro tragedie, io me ne stava molto a disagio in Roma in una continua palpitazione e quasi febbre dell'animo, e piú volte, se non fosse stata la vergogna mi sarei disdetto, ed avrei ripreso il mio manoscritto.
Ad una per volta mi pervennero finalmente tutte quattro in Roma, correttissimamente stampate, grazie all'amico; e sudicissimamente stampate, come ciascun le ha viste, grazie al tipografo: e barbaramente verseggiate (come io seppi poi), grazie all'autore.
La ragazzata di andare attorno attorno per le varie case di Roma, regalando ben rilegate quelle mie prime fatiche, affine di accattar voti, mi tenne piú giorni occupato, non senza parer risibile agli occhi miei stessi, non che agli altrui.
Le presentai, fra gli altri, al papa allora sedente Pio VI, a cui già mi era fatto introdurre fin dall'anno prima, allorché mi posi a dimora in Roma.
E qui, con mia somma confusione, dirò di qual macchia io contaminassi me stesso in quella udienza beatissima.
Io non molto stimava il papa come papa; e nulla il Braschi come uomo letterato né benemerito delle lettere, che non lo era punto.
Eppure, quell'io stesso, previa una ossequiosa presentazione del mio volume, che egli cortesemente accettava, apriva, e riponeva sul suo tavolino, molto lodandomi, e non acconsentendo ch'io procedessi al bacio del piede, egli medesimo anzi rialzandomi in piedi da genuflesso ch'io m'era; nella qual umil positura Sua Santità si compiacque di palparmi come con vezzo paterno la guancia; quell'io stesso, che mi teneva pure in corpo il mio sonetto su Roma, rispondendo allora con blandizia e cortigianeria alle lodi che il pontefice mi dava su la composizione e recita dell'Antigone, di cui egli avea udito, disse, maraviglie; io, colto il momento in cui egli mi domandava se altre tragedie farei, molto encomiando un'arte sí ingegnosa e sí nobile; gli risposi che molte altre eran fatte, e tra quelle un Saul, il quale come soggetto sacro avrei, se egli non lo sdegnava, intitolato a Sua Santità.
Il papa se ne scusò, dicendomi ch'egli non poteva accettar dedica di cose teatrali quali ch'elle si fossero; né io altra cosa replicai su ciò.
Ma qui mi convien confessare, ch'io provai due ben distinte, ed ambe meritate, mortificazioni: l'una del rifiuto ch'io m'era andato accattare spontaneamente; l'altra di essermi pur visto costretto in quel punto a stimare me medesimo di gran lunga minore del papa, poiché io avea pur avuto la viltà, o debolezza, o doppiezza (che una di queste tre fu per certo, se non tutte tre, la motrice del mio operare in quel punto) di voler tributare come segno di ossequio e di stima una mia opera ad un individuo ch'io teneva per assai minore di me in linea di vero merito.
Ma mi conviene altresí (non per mia giustificazione, ma per semplice schiarimento di tale o apparente o verace contraddizione tra il mio pensare, sentire e operare) candidamente espor la sola e verissima cagione, che m'avea indotto a prostituire cosí il coturno alla tiara.
La cagione fu dunque, che io sentendo già da qualche tempo bollir dei romori preteschi che uscivano di casa il cognato dell'amata mia donna, per cui mi era nota la scontentezza di esso e di tutta la di lui corte circa alla mia troppa frequenza in casa di essa; e questo scontentamento andando sempre crescendo; io cercai coll'adulare il sovrano di Roma, di crearmi in lui un appoggio contro alle persecuzioni ch'io già parea presentire nel cuore, e che poi in fatti circa un mese dopo mi si scatenarono contro.
E credo che quella stessa recita dell'Antigone, col far troppo parlare di me, mi suscitasse e moltiplicasse i nemici.
Io fui dunque allora e dissimulato, e vile, per forza d'amore; e ciascuno in me derida se il può, ma riconosca ad un tempo, sé stesso.
Ho voluto di questa particolarità, ch'io poteva lasciar nelle tenebre in cui si stava sepolta, fare il mio e l'altrui pro, disvelandola.
Non l'avea mai raccontata a chicchessia in voce, vergognandomene non poco.
Alla sola mia donna la raccontai qualche tempo dopo.
L'ho scritta anche in parte per consolazione dei tanti altri autori presenti e futuri, i quali per una qualche loro fatal circostanza si trovano, e si troveranno pur troppo sempre i piú, vergognosamente sforzati a disonorar le lor opere e sé stessi con dediche bugiarde; ed affinché i malevoli miei possan dire con verità e sapore, che se io non mi sono avvilito con niuna di sí fatte simulazioni non fu che un semplice effetto della sorte, la quale non mi costrinse ad esser vile o parerlo.
Nell'aprile di quell'anno 1783 infermò gravemente in Firenze il consorte della mia donna.
Il di lui fratello partí a precipizio, per ritrovarlo vivo.
Ma il male allentò con pari rapidità, ed egli lo ritrovò riavutosi, ed affatto fuor di pericolo.
Nella convalescenza, trattenendosi il di lui fratello circa quindici giorni in Firenze, si trattò fra i preti venuti con esso di Roma, ed i preti che aveano assistito il malato in Firenze, che bisognava assolutamente per parte del marito persuadere e convincere il cognato, ch'egli non poteva né dovea piú a lungo soffrire in Roma nella propria casa la condotta della di lui cognata.
E qui, non io certamente farò l'apologia della vita usuale di Roma e d'Italia tutta, quale si suole vedere di presso che tutte le donne maritate.
Dirò bensí, che la condotta di quella signora in Roma a riguardo mio era piuttosto molto al di qua, che non al di là degli usi i piú tollerati in quella città.
Aggiungerò, che i torti, e le feroci e pessime maniere del marito con essa, erano cose verissime, ed a tutti notissime.
Ma terminerò con tutto ciò, per amor del vero e del retto, col dire, che il marito, e il cognato, e i loro rispettivi preti aveano tutte le ragioni di non approvare quella mia troppa frequenza, ancorché non eccedesse i limiti dell'onesto.
Mi spiace soltanto, che quanto ai preti (i quali furono i soli motori di tutta la macchina), il loro zelo in ciò non fosse né evangelico, né puro dai secondi fini, poiché non pochi di essi coi lor tristi esempi faceano ad un tempo l'elogio della condotta mia, e la satira della loro propria.
La cosa era dunque, non figlia di vera religione e virtú, ma di vendette e raggiri.
Quindi, appena ritornò in Roma il cognato, egli per l'organo de' suoi preti intimò alla signora: che era cosa oramai indispensabile, e convenuta tra lui e il fratello, che s'interrompesse quella mia assiduità presso lei; e ch'egli non la sopporterebbe ulteriormente.
Quindi codesto personaggio, impetuoso sempre ed irriflessivo, quasi che s'intendesse con questi modi di trattare la cosa piú decorosamente, ne fece fare uno scandaloso schiamazzio per la città tutta, parlandone egli stesso con molti, e inoltrandone le doglianze sino al papa.
Corse allora grido, che il papa su questo riflesso mi avesse fatto o persuadere o ordinare di uscir di Roma; il che non fu vero; ma facilmente avrebbe potuto farlo, mercè la libertà italica.
Io però, ricordatomi allora, come tanti anni prima essendo in Accademia, e portando, com'io narrai, la parrucca, sempre aveva antivenuto i nemici sparruccandomi da me stesso, prima ch'essi me la levasser di forza; antivenni allora l'affronto dell'esser forse fatto partire, col determinarmivi spontaneamente.
A quest'effetto io fui dal ministro nostro di Sardegna, pregandolo di far partecipe il segretario di Stato, che io informato di tutto questo scandalo, troppo avendo a cuore il decoro, l'onore, e la pace di una tal donna, aveva immediatamente presa la determinazione di allontanarmene per del tempo, affine di far cessare le chiacchiere; e che verso il principio del prossimo maggio sarei partito.
Piacque al ministro, e fu approvata dal segretario di Stato, dal papa e da tutti quelli che seppero il vero, questa mia spontanea, e dolorosa risoluzione.
Onde mi preparai alla crudelissima dipartenza.
A questo passo m'indusse la trista ed orribile vita alla quale prevedeva di dover andare incontro, ove io mi fossi pure rimasto in Roma, ma senza poter continuare di vederla in casa sua, ed esponendola ad infiniti disgusti e guai, se in altri luoghi con affettata pubblicità, ovvero con inutile e indecoroso mistero, l'avessi assiduamente combinata.
Ma il rimaner poi entrambi in Roma senza punto vederci, era per me un tal supplizio, ch'io per minor male, d'accordo con essa, mi elessi la lontananza aspettando migliori tempi.
Il dí quattro di maggio dell'anno 1783, che sempre mi sarà ed è stato finora di amarissima ricordanza, io mi allontanai adunque da quella piú che metà di me stesso.
E di quattro o cinque separazioni che mi toccarono da essa, questa fu la piú terribile per me, essendo ogni speranza di rivederla pur troppo incerta e lontana.
Questo avvenimento mi tornò a scomporre il capo per forse due anni, e m'impedí, ritardò e guastò anche notabilmente sotto ogni aspetto i miei studi.
Nei due anni di Roma io aveva tratto una vita veramente bella.
La Villa Strozzi, posta alle Terme Diocleziane, mi avea prestato un delizioso ricovero.
Le lunghe intere mattinate io ve le impiegava studiando, senza muovermi punto di casa se non se un'ora o due cavalcando per quelle solitudini immense che in quel circondario disabitato di Roma invitano a riflettere, piangere, e poetare.
La sera scendeva nell'abitato, e ristorato dalle fatiche dello studio con l'amabile vista di quella per cui sola io esisteva e studiava, me ne ritornava poi contento al mio eremo, dove al piú tardi all'undici della sera io era ritirato.
Un soggiorno piú gaio e piú libero e piú rurale, nel recinto d'una gran città, non si potea mai trovare; né il piú confacente al mio umore, carattere ed occupazioni.
Me ne ricorderò, e lo desidererò, finch'io viva.
Lasciata dunque in tal modo la mia unica donna, i miei libri, la villa, la pace, e me stesso in Roma, io me n'andava dilungando in atto d'uomo quasi stupido ed insensato.
M'avviai verso Siena, per ivi lagrimare almeno liberamente per qualche giorni in compagnia dell'amico.
Né ben sapeva ancora in me stesso, dove anderei, dove mi starei, quel che mi farei.
Mi riuscí d'un grandissimo sollievo il conversar con quell'uomo incomparabile; buono, compassionevole, e con tanta altezza e ferocia di sensi, umanissimo.
Né mai si può veramente ben conoscere il pregio e l'utilità d'un amico verace, quanto nel dolore.
Io credo, che senz'esso sarei facilmente impazzato.
Ma egli, vedendo in me un eroe cosí sconciamente avvilito e minor di sé stesso; ancorché ben intendesse per prova i nomi e la sostanza di fortezza e virtú, non volle con tutto ciò crudelmente ed inopportunamente opporre ai deliri miei la di lui severa e gelata ragione; bensí seppe egli scemarmi, e non poco, il dolore, col dividerlo meco.
Oh rara, oh celeste dote davvero; chi sappia ragionare ad un tempo, e sentire!
Ma io frattanto, menomate o sopite in me tutte le mie intellettuali facoltà, altra occupazione, altro pensiero non ammetteva, che lo scrivere lettere, e in questa terza lontananza che fu la piú lunga, scrissi veramente dei volumi, né quello ch'io mi scrivessi, il saprei: io sfogava il dolore, l'amicizia, l'amore, l'ira e tutti in somma i cotanti e sí diversi, e sí indomiti affetti d'un cuor traboccante, e d'un animo mortalmente piagato.
Ogni cosa letteraria mi si andava ad un tempo stesso estinguendo nella mente, e nel cuore; a tal segno, che varie lettere ch'io avea ricevute di Toscana nel tempo de' miei disturbi in Roma, le quali mi mordeano non poco su le stampate tragedie, non mi fecero la minima impressione per allora, non piú che se delle tragedie d'un altro mi avessero favellato.
Erano queste lettere, qualcuna scritta con sale e gentilezza, le piú insulsamente e villanamente; alcune firmate, altre no; e tutte concordavano nel biasimare quasi che esclusivamente il mio stile, tacciandomelo di durissimo, oscurissimo, stravagantissimo, senza però volermi, o sapermi, individuare gran fatto il come, il dove, il perché.
Giunto poi in Toscana, l'amico per divagarmi dal mio unico pensamento, mi lesse nei foglietti di Firenze e di Pisa, chiamati Giornali, il commento delle predette lettere, che mi erano state mandate in Roma.
E furono codesti i primi cosí detti giornali letterari che in qualunque lingua mi fossero capitati mai agli orecchi né agli occhi.
E allora soltanto penetrai nei recessi di codesta rispettabile arte, che biasima o loda i diversi libri con eguale discernimento, equità, e dottrina, secondo che il giornalista è stato prima o donato, o vezzeggiato, o ignorato, o sprezzato dai rispettivi autori.
Poco m'importò, a dir vero, di codeste venali censure, avendo io allora l'animo interamente preoccupato da tutt'altro pensiero.
Dopo circa tre settimane di soggiorno in Siena, nel qual tempo non trattai né vidi altri che l'amico, la temenza di rendermi troppo molesto a lui, poiché tanto pur l'era a me stesso; l'impossibilità di occuparmi in nulla, e la solita impazienza di luogo che mi dominava tosto di bel nuovo al riapparire della noia e dell'ozio: tutte queste ragioni mi fecero risolvere di muovermi viaggiando.
Si avvicinava la festa solita dell'Ascensa in Venezia, che io avea già veduta molti anni prima; e là mi avviai.
Passai per Firenze di volo, ché troppo mi accorava l'aspetto di quei luoghi che mi aveano già fatto beato, e che ora mi rivedevano sí angustiato ed oppresso.
Il moto del cavalcare massimamente, e tutti gli altri strapazzi e divagazioni del viaggio, mi giovarono, se non altro, alla salute moltissimo, la quale molto mi era andata alterando da tre mesi in poi pe' tanti travagli d'animo, d'intelletto, e di cuore.
Di Bologna mi deviai per visitare in Ravenna il sepolcro del Poeta, e un giorno intero vi passai fantasticando, pregando, e piangendo.
In questo viaggio di Siena a Venezia mi si dischiuse veramente una nuova e copiosissima vena delle rime affettuose, e quasi ogni giorno uno o piú sonetti mi si facean fare, affacciandosi con molto impeto e spontaneità alla mia agitatissima fantasia.
In Venezia poi, allorché sentii pubblicata e assodata la pace tra gli americani e l'Inghilterra, pattuitavi la loro indipendenza totale, scrissi la quinta ode dell'America libera, con cui diedi compimento a quel lirico poemetto.
Di Venezia venuto a Padova, questa volta non trascurai come nelle due altre anteriori, di visitare la casa e la tomba del nostro sovrano maestro d'amore in Arquà.
Quivi parimente un giorno intero vi consecrai al pianto, e alle rime, per semplice sfogo del troppo ridondante mio cuore.
In Padova poi imparai a conoscere di persona il celebre Cesarotti, dei di cui modi vivaci e cortesi non rimasi niente men soddisfatto, che il fossi stato sempre della lettura de' suoi maestrevolissimi versi nell'Ossian.
Di Padova ritornai a Bologna, passando per Ferrara, affine di quivi compiere il mio quarto pellegrinaggio poetico, col visitarvi la tomba, e i manoscritti dell'Ariosto.
Quella del Tasso piú volte l'avea visitata in Roma; cosí la di lui culla in Sorrento, dove nell'ultimo viaggio di Napoli, mi era espressamente portato ad un tale effetto.
Questi quattro nostri poeti, erano allora, e sono, e sempre saranno i miei primi, e direi anche soli, di questa bellissima lingua: e sempre mi è sembrato che in essi quattro vi sia tutto quello che umanamente può dare la poesia; meno però il meccanismo del verso sciolto di dialogo, il quale si dee però trarre dalla pasta di questi quattro, fattone un tutto, e maneggiatolo in nuova maniera.
E questi quattro grandissimi, dopo sedici anni oramai ch'io li ho giornalmente alle mani, mi riescono sempre nuovi, sempre migliori nel loro ottimo, e direi anche utilissimi nel loro pessimo; ché io non asserirò con cieco fanatismo, che tutti e quattro a luoghi non abbiano e il mediocre ed il pessimo; dirò bensí che assai, ma assai, vi si può imparare anche dal loro cattivo; ma da chi ben si addentra nei loro motivi e intenzioni: cioè da chi, oltre l'intenderli pienamente e gustarli, li sente.
Di Bologna, sempre piangendo e rimando, me n'andai a Milano; e di là, trovandomi cosí vicino al mio carissimo abate di Caluso, che allora villeggiava co' suoi nipoti nel bellissimo loro castello di Masino poco distante da Vercelli, ci diedi una scorsa di cinque o sei giorni.
E in uno di quelli, trovandomi anche tanto vicino a Torino, mi vergognai di non vi dare una scorsa per abbracciar la sorella.
V'andai dunque per una notte sola coll'amico, e l'indomani sera ritornammo a Masino.
Avendo abbandonato il paese mio colla donazione, in aspetto di non lo voler piú abitare, non mi vi volea far vedere cosí presto, e massime dalla corte.
Questa fu la ragione del mio apparire e sparire in un punto.
Onde questa scorsa cosí rapida che a molti potrebbe parere bizzarra, cesserà d'esserlo saputane la ragione.
Erano già sei e piú anni, ch'io non dimorava piú in Torino; non mi vi parea essere né sicuro, né quieto, né libero; non ci voleva, né doveva, né potea rimanervi lungamente.
Di Masino, tosto ritornai a Milano, dove mi trattenni ancora quasi tutto luglio; e ci vidi assai spesso l'originalissimo autore del Mattino, vero precursore della futura satira italiana.
Da questo celebre e colto scrittore procurai d'indagare, con la massima docilità, e con sincerissima voglia d'imparare, dove consistesse principalmente il difetto del mio stile in tragedia.
E Parini con amorevolezza e bontà mi avvertí di varie cose, non molto a dir vero importanti, e che tutte insieme non poteano mai costituire la parola stile, ma alcune delle menome parti di esso.
Ma le piú, od il tutto di queste parti che doveano costituire il vero difettoso nello stile, e che io allora non sapeva ancor ben discernere da me stesso, non mi fu mai saputo o voluto additare né dal Parini, né dal Cesarotti, né da altri valenti uomini ch'io col fervore e l'umiltà d'un novizio visitai ed interrogai in quel viaggio per la Lombardia.
Onde mi convenne poi dopo il decorso di molti anni con molta fatica ed incertezza andar ritrovando dove stesse il difetto, e tentare di emendarlo da me.
Sul totale però, di qua dell'Appennino le mie tragedie erano piaciute assai piú che in Toscana; e vi s'era anche biasimato lo stile con molto minore accanimento e qualche piú lumi.
Lo stesso era accaduto in Roma ed in Napoli, presso quei pochissimi che l'aveano volute leggere.
Egli è dunque un privilegio antico della sola Toscana, di incoraggire in questa maniera gli scrittori italiani, allorché non iscrivono delle cicalate.
CAPITOLO UNDECIMO
Seconda stampa di sei altre tragedie.
Varie censure delle quattro stampate prima.
Risposta alla lettera del Calsabigi.
Verso i primi d'agosto partito di Milano, mi volli restituire in Toscana.
Ci venni per la bellissima e pittoresca via nuova di Modena, che riesce a Pistoia.
Nel far questa strada, tentai per la prima volta di sfogare anche alquanto il mio ben giusto fiele poetico, in alcuni epigrammi.
Io era intimamente persuaso, che se degli epigrammi satirici, taglienti, e mordenti, non avevamo nella nostra lingua, non era certo colpa sua; ch'ella ha ben denti, ed ugne, e saette, e feroce brevità, quanto e piú ch'altra lingua mai l'abbia, o le avesse.
I pedanti fiorentini, verso i quali io veniva scendendo a gran passi nell'avvicinarmi a Pistoia, mi prestavano un ricco soggetto per esercitarmi un pochino in quell'arte novella.
Mi trattenni alcuni giorni in Firenze, e visitai alcuni di essi, mascheratomi da agnello, per cavarne o lumi, o risate.
Ma essendo quasi impossibile il primo lucro, ne ritrassi in copia il secondo.
Modestamente quei barbassori mi lasciarono, anzi mi fecero chiaramente intendere: che se io prima di stampare avessi fatto correggere il mio manoscritto da loro, avrei scritto bene.
Ed altre sí fatte mal confettate impertinenze mi dissero.
M'informai pazientemente, se circa alla purità ed analogia delle parole, e se circa alla sacrosanta grammatica, io avessi veramente solecizzato, o barbarizzato, o smetrizzato.
Ed in questo pure, non sapendo essi pienamente l'arte loro, non mi seppero additare niuna di queste tre macchie nel mio stampato, individuandone il luogo; abbenché pur vi fossero qualche sgrammaticature; ma essi non le conoscevano.
Si appagarono dunque di appormi delle parole, dissero essi, antiquate; e dei modi insoliti, troppo brevi, ed oscuri, e duri all'orecchio.
Arricchito io in tal guisa di sí peregrine notizie, addottrinato e illuminato nell'arte tragica da sí cospicui maestri, me ne ritornai a Siena.
Quivi mi determinai, sí per occuparmi sforzatamente, che per divagarmi dai miei dolorosi pensieri, di proseguirvi sotto i miei occhi la stampa delle tragedie.
Nel riferire io poi all'amico le notizie ed i lumi ch'io era andato ricavando dai nostri diversi oracoli italiani, e massimamente dai fiorentini e pisani, noi gustammo un pocolino di commedia, prima di accingerci a far di nuovo rider coloro a spese delle nostre ulteriori tragedie.
Caldamente, ma con troppa fretta, mi avviai a stampare, onde in tutto settembre, cioè in meno di due mesi, uscirono in luce le sei tragedie in due tomi, che giunti al primo di quattro, formano il totale di quella prima edizione.
E nuova cosa mi convenne allora conoscere per dura esperienza.
Siccome pochi mesi prima io avea imparato a conoscere i giornali ed i giornalisti; allora dovei conoscere i censori di manoscritti, i revisori delle stampe, i compositori, i torcolieri, ed i proti.
Meno male di questi tre ultimi, che pagandoli si possono ammansire e dominare: ma i revisori e censori, sí spirituali che temporali, bisogna visitarli, pregarli, lusingarli, e sopportarli, che non è picciol peso.
L'amico Gori per la stampa del primo volume si era egli assunto in Siena queste noiose brighe per me.
E cosí forse avrebbe anche potuto proseguire egli per la continuazione dei du' altri volumi.
Ma io, volendo pure, per una volta almeno, aver visto un poco di tutto nel mondo, volli anche in quell'occasione aver veduto un sopracciglio censorio, ed una gravità e petulanza di revisore.
E vi sarebbe stato di cavarne delle barzellette non poche, se io mi fossi trovato in uno stato di cuore piú lieto che non era il mio.
E allora anche per la prima volta abbadai io stesso alla correzione delle prove; ma essendo il mio animo troppo oppresso, ed alieno da ogni applicazione, non emendai come avrei dovuto e potuto, e come feci poi molti anni dopo ristampando in Parigi, la locuzione di quelle tragedie; al qual effetto riescono utilissime le prove dello stampatore, dove leggendosi quegli squarci spezzatamente e isolati dal corpo dell'opera, vi si presentano piú presto all'occhio le cose non abbastanza ben dette; le oscurità; i versi mal tomiti; e tutte in somma quelle mendarelle, che moltiplicate e spesseggianti fanno poi macchia.
Sul totale però queste sei tragedie stampate seconde, riuscirono, anche al dir dei malevoli, assai piú piane che le quattro prime.
Stimai bene per allora di non aggiungere alle dieci stampate le quattro altre tragedie che mi rimanevano, tra le quali sí la Congiura de' Pazzi, che la Maria Stuarda, potevano in quelle circostanze accrescere a me dei disturbi, ed a chi assai piú mi premea che me stesso.
Ma intanto quel penoso lavoro del riveder le prove, e sí affollatamente tante in sí poco spazio di tempo, e per lo piú rivedendole subito dopo pranzo, mi cagionò un accesso di podagra assai gagliardetto, che mi tenne da quindici giorni zoppo e angustiato, non avendo voluto covarla in letto.
Quest'era il secondo accesso; il primo l'avea avuto in Roma un anno e piú innanzi, ma leggerissimo.
Con questo secondo mi accertai, che mi toccherebbe quel passatempo assai spesso per lo rimanente della mia vita.
Il dolor d'animo, e il troppo lavoro di mente erano in me i due fonti di quell'incommodo; ma l'estrema sobrietà nel vitto l'andò sempre poi vittoriosamente combattendo; tal che finora pochi e non forti sono sempre stati gli assalti della mia mal pasciuta podagra.
Mentr'io stava quasi per finire la stampa, ricevei dal Calsabigi di Napoli una lunghissima lettera, piena zeppa di citazioni in tutte le lingue, ma bastantemente ragionata, su le mie prime quattro tragedie.
Immediatamente, ricevutala, mi posi a rispondergli, sí perché quello scritto mi pareva essere stato fin allora il solo che uscisse da una mente sanamente critica e giusta ed illuminata; sí perché con quell'occasione io poteva sviluppare le mie ragioni, e investigando io medesimo il come e il perché fossi caduto in errore, insegnare ad un tempo a tutti i tant'altri inetti miei critici a criticare con frutto e discernimento, o tacersi.
Quello scritto mio, che dal ritrovarmi io allora pienissimo di quel soggetto, non mi costò quasi punto fatica, poteva poi anche col tempo servire come di prefazione a tutte le tragedie, allorché l'avessi tutte stampate; ma me lo tenni in corpo per allora, e non lo volli apporre alla stampa di Siena, la quale non dovendo essere altro per me che un semplice tentativo, io voleva uscire del tutto nudo d'ogni scusa, e ricevere cosí da ogni parte e d'ogni sorte saette; lusingandomi forse che n'avrei cosí ricevuto piú vita che morte; niuna cosa piú ravvivando un autore, che il criticarlo inettamente.
Né questo mio orgoglietto avrei dovuto rivelare, s'io non avessi fin dal principio di queste chiacchiere impreso e promesso di non tacer quasi che nulla del mio, o di non dare almeno mai ragione del mio operare, la quale non fosse, la schiettissima verità.
Finita la stampa, verso il principio d'ottobre pubblicai il secondo volume; e riserbai il terzo a sostener nuova guerra, tosto che fosse sfogata e chiarita la seconda.
Ma intanto, ciò che mi premeva allora sopra ogni cosa, il rivedere la donna mia, non potendosi assolutamente effettuare per quell'entrante inverno, io disperatissimo di tal cosa, e non ritrovando mai pace, né luogo che mi contenesse, pensai di fare un lungo viaggio in Francia ed in Inghilterra, non già che me ne fosse rimasto né desiderio né curiosità, che me n'era saziato d'entrambi dal secondo viaggio, ma per andare; che altro rimedio o sollievo al dolore non ho saputo ritrovar mai.
Coll'occasione di questo nuovo viaggio mi proponeva poi anche di comprare dei cavalli inglesi quanti piú potrei.
Questa era, ed è tuttavia, la mia passione terza; ma sí fattamente sfacciata ed audace, e sí spesso rinascente, che i bei destrieri hanno molte volte osato combattere, e vinto anche talvolta, sí i libri che i versi; ed in quel punto di scontentezza di cuore, le Muse aveano pochissimo imperio su la mente mia.
Onde di poeta ripristinatomi cavallaio, me ne partii per Londra con la fantasia ripiena ed accesa di belle teste, be' petti, altere incollature, ampie groppe, o nulla o poco pensando oramai alle uscite e non uscite tragedie.
Ed in sí fatte inezie consumai ben otto e piú mesi, non facendo piú nulla, né studiando, né quasi pure leggendo, se non se a squarcetti i miei quattro poeti, che or l'uno or l'altro io mi andava a vicenda intascando, compagni indivisibili miei nelle tante e tante miglia ch'io faceva; e non pensando ad altro che alla lontana mia donna, per cui di tempo in tempo alcune rime di piagnisteo andava pur anche raccozzando alla meglio.
CAPITOLO DUODECIMO
Terzo viaggio in Inghilterra, unicamente per comperarvi cavalli.
Verso la metà d'ottobre lasciai dunque Siena, e partendo alla volta di Genova, per Pisa e Lerici, l'amico Gori mi fece compagnia sino a Genova.
Quivi dopo due o tre giorni ci separammo; egli ripartí per la Toscana, io m'imbarcai per Antibo.
Rapidissimamente e con qualche pericolo feci quel tragitto in poco piú di diciott'ore.
Né senza un qualche timore passai quella notte.
La filucca era piccola; c'aveva imbarcata la carrozza, la quale faceva squilibrio; il vento ed il mare gagliardissimi; ci stetti assai male.
Sbarcato, ripartii per Aix, dove non mi trattenni, né mi arrestai sino in Avignone, dove mi portai con trasporto a visitare la magica solitudine di Valchiusa, e Sorga ebbe assai delle mie lagrime, non simulate e imitative, ma veramente di cuore e caldissime.
Feci in quel giorno nell'andare e tornare di Valchiusa in Avignone quattro sonetti; e fu quello per me l'un dei giorni i piú beati e nello stesso tempo dolorosi, ch'io passassi mai.
Partito d'Avignone volli visitare la celebre Certosa di Grenoble, e per tutto spargendo lagrime andava raccogliendo rime non poche, tanto ch'io pervenni per la terza volta in Parigi; e sempre lo stessissimo effetto mi fece questa immensissima fogna; ira e dolore.
Statovi circa un mese, che mi parve un secolo, ancorché vi avessi recate varie lettere per molti letterati d'ogni genere, mi disposi nel decembre a passare in Inghilterra.
I letterati francesi son quasi tutti presso che interamente digiuni della nostra letteratura italiana, né oltrepassano l'intelligenza del Metastasio.
Ed io poi non intendendo nulla né volendo saper della loro, non avea luogo discorso tra noi.
Bensí arrabbiatissimo io in me stesso di essermi rimesso nel caso di dover riudire e riparlare quell'antitoscanissimo gergo nasale, affrettai quanto piú potei il momento di allontanarmene.
Il fanatismo ebdomadario di quel poco tempo ch'io mi vi trattenni, era allora il pallon volante; e vidi due delle prime e piú felici esperienze delle due sorti di esso, l'uno di aria rarefatta ripieno; l'altro, d'aria infiammabile ed entrambi portanti per aria due persone ciascuno.
Spettacolo grandioso e mirabile; tema piú assai poetico che storico, e scoperta, a cui per ottenere il titolo di sublime, altro non manca finora che la possibilità o verisimiglianza di essere adattata ad una qualche utilità.
Giunto in Londra, non trascorsero otto giorni, ch'io cominciai a comprar dei cavalli; prima un di corsa, poi due di sella, poi un altro, poi sei da tiro, e successivamente essendomene o andati male o morti vari polledri, ricomprandone due per un che morisse, in tutto il marzo dell'anno '84, me ne trovai rimanere quattordici.
Questa rabidissima passione, che in me avea covato sotto cenere oramai quasi sei anni, mi si era per quella lunga privazione totale, o parziale, sí dispettosamente riaccesa nel cuore e nella fantasia, che recalcitrando contro gli ostacoli, e vedendo che di dieci compratine, cinque mi eran venuti meno in sí poco tempo, arrivai a quattordici; come pure a quattordici avea spinte le tragedie, non ne volendo da prima che sole dodici.
Queste mi spossarono la mente; quelli la borsa; ma la divagazione dei molti cavalli mi restituí la salute e l'ardire di fare poi in appresso altre tragedie ed altr'opere.
Furono dunque benissimo spesi quei molti danari, poiché ricomprai anche con essi il mio impeto e brio, che a piedi languivano.
E tanto piú feci bene di buttar quei danari, poiché me li trovava aver sonanti.
Dalla donazione in poi, avendo io vissuti i primi quasi tre anni con sordidezza, ed i tre ultimi con decente ma moderata spesa; mi ritrovava allora una buona somma di risparmio, tutti i frutti dei vitalizi di Francia, cui non avea mai toccati.
Quei quattordici amici me ne consumarono gran parte nel farsi comprare e trasferire in Italia; ed il rimanente poi me ne consumarono in cinque anni consecutivi nel farsi mantenere; che usciti una volta dalla loro isola, non vollero piú morire nessuno, ed io affezionatomi ad essi non ne volli vender nessuno.
Incavallatomi dunque sí pomposamente, dolente nell'animo per la mia lontananza dalla sola motrice d'ogni mio savio ed alto operare, io non trattava né cercava mai nessuno; o me ne stava co' miei cavalli, o scrivendo lettere su lettere su lettere.
In questo modo passai circa quattro mesi in Londra; né alle tragedie pensava altrimenti che se non l'avessi né pure ideate mai.
Soltanto mi si affacciava spesso fra me e me quel bizzarro rapporto di numeri fra esse e le mie bestie: e ridendo mi dicea: "Tu ti sei guadagnato un cavallo per ogni tragedia"; pensando ai cavalli che a suono di sferza ci somministrano i nostri Orbili pedagogi, quando facciamo nelle scuole una qualche trista composizione.
Cosí vissi io vergognosamente in un ozio vilissimo per mesi e mesi; smettendo ogni dí piú anche il leggere i soliti poeti, e insterilita anco affatto la vena delle rime; tal che in tutto il soggiorno di Londra non feci che un solo sonetto, e due poi al partire.
Avviatomi nell'aprile con quella numerosa carovana, venni a Calais, poi a Parigi di nuovo, poi per Lione e Torino mi restituii in Siena.
Ma molto è piú facile e breve il dire per iscritto tal gita, che non l'eseguirla con tante bestie.
Io provava ogni giorno, ad ogni passo, e disturbi e amarezze, che troppo mi avvelenavano il piacere che avrei avuto della mia cavalleria.
Ora questo tossiva, or quello non volea mangiare: l'uno zoppicava, all'altro si gonfiavan le gambe, all'altro si sgretolavan gli zoccoli, e che so io; egli era un oceano continuo di guai, ed io n'era il primo martire.
E quel passo di mare, per trasportarli di Douvres, vedermeli tutti come pecore in branco posti per zavorra della nave, avviliti, sudicissimi da non piú si distinguere neppure il bell'oro dei loro vistosi mantelli castagni; e tolte via alcune tavole che li facean da tetto, vederli poi in Calais, prima che si sbarcassero, servire i loro dossi di tavole ai grossolani marinai che camminavan sopra di loro come se non fossero stati vivi corpi, ma una vile continuazione di pavimento; e poi vederli tratti per aria da una fune con le quattro gambe spenzolate, e quindi calati nel mare, perché stante la marea non poteva la nave approdare sino alla susseguente mattina; e se non si sbarcavano cosí quella sera, conveniva lasciarli poi tutta la notte in quella sí scomoda positura imbarcati; insomma vi patii pene continue di morte.
Ma pure tanta fu la sollecitudine, e l'antivedere, e il rimediare, e l'ostinatamente sempre badarci da me, che fra tante vicende, e pericoli, ed incommoducci, li condussi senza malanni importanti tutti salvi a buon porto.
Confesserò anche pel vero, che io passionatissimo su questo fatto, ci aveva anche posta una non meno stolta che stravagante vanità; talché quando in Amiens, in Parigi, in Lione, in Torino, e altrove que' miei cavalli erano trovati belli dai conoscitori, io me ne rimpettiva e teneva come se li avessi fatti io.
Ma la piú ardua ed epica impresa mia con quella carovana fu il passo dell'Alpi fra Laneborgo, e la Novalesa.
Molta fatica durai nel ben ordinare ed eseguire la marcia loro, affinché non succedesse disgrazia nessuna a bestie sí grosse, e piuttosto gravi, in una strettezza e malagevolezza sí grande di quei rompicolli di strade.
E siccome assai mi compiacqui nell'ordinarla, mi permetta anco il lettore ch'io mi compiaccia alquanto in descriverla.
Chi non la vuole, la passi; e chi la vorrà pur leggere, badi un po' s'io meglio sapessi distribuire la marcia di quattordici bestie fra quelle Termopili, che non i cinque atti d'una tragedia.
Erano que' miei cavalli, attesa la lor giovinezza, e le mie cure paterne, e la moderata fatica, vivaci e briosi oltre modo; onde tanto piú scabro riusciva il guidarli illesi per quelle scale.
Io presi dunque in Laneborgo un uomo per ciascun cavallo, che lo guidasse a piedi per la briglia cortissimo.
Ad ogni tre cavalli, che l'uno accodato all'altro salivano il monte bel bello, coi loro uomini, ci avea interposto uno dei miei palafrenieri che cavalcando un muletto invigilava su i suoi tre che lo precedevano.
E cosí via via di tre in tre.
In mezzo poi della marcia stava il maniscalco di Laneborgo con chiodi e martello, e ferri e scarpe posticce per rimediare ai piedi che si venissero a sferrare, che era il maggior pericolo in quei sassacci.
Io poi, come capo dell'espedizione, veniva ultimo, cavalcando il piú piccolo e il piú leggiero de' miei cavalli, Frontino, e, mi tenea alle due staffe due aiutanti di strada, pedoni sveltissimi, ch'io mandava dalla coda al mezzo o alla testa, portatori de' miei comandi.
Giunti in tal guisa felicissimamente in cima del Monsenigi, quando poi fummo allo scendere in Italia, mossa in cui sempre i cavalli si sogliono rallegrare, e affrettare il passo, e sconsideratamente anco saltellare, io mutai di posto, e sceso di cavallo mi posi in testa di tutti, a piedi, scendendo ad oncia ad oncia; e per maggiormente anche ritardare la scesa, avea posti in testa i cavalli i piú gravi e piú grossi; e gli aiutanti correano intanto su e giú per tenerli tutti insieme senza intervallo nessuno; altro che la dovuta distanza.
Con tutte queste diligenze mi si sferrarono nondimeno tre piedi a diversi cavalli, ma le disposizioni eran sí esatte, che immediatamente il maniscalco li poté rimediare, e tutti giunsero sani e salvi alla Novalesa, coi piedi in ottimo essere, e nessunissimo zoppo.
Queste mie chiacchiere potranno servire di norma a chi dovesse passare o quell'Alpe, o altra simile, con molti cavalli.
Io, quant'a me, avendo sí felicemente diretto codesto passo, me ne teneva poco meno che Annibale per averci un poco piú verso il mezzogiorno fatto traghettare i suoi schiavi ed elefanti.
Ma se a lui costò molt'aceto, a me costò del vino non poco, che tutti coloro, e guide, e maniscalchi, e palafrenieri, e aiutanti, si tracannarono.
Col capo ripieno traboccante di queste inezie cavalline, e molto scemo di ogni utile e lodevole pensamento, arrivai in Torino in fin di maggio, dove soggiornai circa tre settimane, dopo sette e piú anni che vi avea smesso il domicilio.
Ma i cavalli, che per la troppa continuità cominciavano talvolta a tediarmi, dopo sei, o otto giorni di riposo, li spedii innanzi alla volta della Toscana, dove li avrei raggiunti.
Ed intanto voleva un poco respirare da tante brighe, e fatiche, e puerilità, poco in vero convenevoli ad un autor tragico in età di anni trentacinque suonati.
Con tutto ciò quella divagazione, quel moto, quell'interruzione totale d'ogni studio mi aveva singolarmente giovato alla salute; ed io mi trovava rinvigorito, e ringiovenito di corpo, come pur troppo ringiovenito anche di sapere e di senno, i cavalli mi aveano a gran passi ricondotto all'asino mio primitivo.
E tanto mi era già di bel nuovo irrugginita la mente, ch'io mi riputava ora mai nella totale impossibilità di nulla piú ideare, né scrivere.
CAPITOLO DECIMOTERZO
Breve soggiorno in Torino.
Recita uditavi della Virginia.
In Torino ebbi alcuni piaceri, e alcuni piú dispiaceri.
Il rivedere gli amici della prima gioventú, ed i luoghi che primi si son conosciuti, ed ogni pianta, ogni sasso, in somma ogni oggetto di quelle idee e passioni primitive, ell'è dolcissima cosa.
Per altra parte poi, l'avere io ritrovati non pochi di quei compagnoni d'adolescenza, i quali vedendomi ora venire per una via, di quanto potean piú lontano mi scantonavano; ovvero, presi alle strette, gelidamente appena mi salutavano, od anche voltavano il viso altrove; gente, a cui io non aveva fatto mai nulla, se non se amicizia e cordialità; questo mi amareggiò non poco; e piú mi avrebbe amareggiato, se non mi fosse stato detto da altri pochi e benevoli, che gli uni mi trattavan cosí perché io aveva scritto tragedie; gli altri, perché avea viaggiato tanto; gli altri, perché ora io era ricomparito in paese con troppi cavalli: piccolezze in somma; scusabili però, e scusabilissime presso chiunque conosce l'uomo esaminando imparzialmente sé stesso: ma cose da scansarsi per quanto è possibile, col non abitare fra i suoi nazionali, allorché non si vuol fare quel che essi fanno o non fanno; allorché il paese è piccolo, ed oziosi gli abitanti; ed allorché finalmente si è venuto ad offenderli involontariamente, anche col solo tentare di farsi dappiú di loro, qualunque sia il genere e il modo in cui l'uomo abbia tentato tal cosa.
Un altro amarissimo boccone che mi convenne inghiottire in Torino, fu di dovermi indispensabilmente presentare al re, il quale per certo si teneva offeso da me, per averlo io tacitamente rinnegato coll'espatriazione perpetua.
Eppure, visti gli usi del paese, e le mie stesse circostanze, io non mi poteva assolvere dal fargli riverenza, ed ossequio, senza riportarne la giusta taccia di stravagante e insolente e scortese.
Appena io giunsi in Torino, che il mio buon cognato, allora primo gentiluomo di camera, ansiosamente subito mi tastò per vedere se io mi presenterei a corte, o no.
Ma io immediatamente lo acquetai e racconsolai col dirgli positivamente di sí; ed egli insistendo sul quando, non volli differire.
Fui il giorno dopo dal ministro.
Il mio cognato già mi avea prevenuto, che in quel punto le disposizioni di quel governo erano ottime per me; onde sarei molto ben ricevuto; ed aggiunse anco che si avea voglia d'impiegarmi.
Questo non meritato né aspettato favore mi fece tremare; ma l'avviso mi serví assai, per tener tal contegno e discorso da non mi fare né prendere né invitare.
Io dissi dunque al ministro, che passando per Torino credeva del mio dovere di visitare lui ministro, e di richiedere per mezzo suo di rassegnarmi al re, semplicemente per inchinarmegli.
Il ministro con blande maniere mi accolse, e direi quasi che mi festeggiò.
E di una parola in un'altra mi venne lasciato travedere da prima, e poi mi disse apertamente: che al re piacerebbe ch'io mi volessi fissare in patria; che si varrebbe volentieri di me; ch'io mi sarei potuto distinguere; e simili frasche.
Tagliai a dirittura nel vivo, e senza punto tergiversare risposi: che io ritornava in Toscana per ivi proseguire le mie stampe e i miei studi; ch'io mi trovava avere trentacinque anni, età in cui non si dee oramai piú cangiare di proposito; che avendo io abbracciata l'arte delle lettere, o bene o male la praticherei per tutto il rimanente di vita mia.
Egli soggiunse: che le lettere erano belle e buone, ma che esistevano delle occupazioni piú grandi e piú importanti, di cui io era e mi dovea sentir ben capace.
Ringraziai cortesemente, ma persistei nel no; ed ebbi anche la moderazione e la generosità di non dare a quel buon galantuomo l'inutile mortificazione, ch'egli si sarebbe pur meritata; di lasciargli cioè intendere, che i loro dispacci e diplomazie mi pareano, ed eran per certo, assai meno importante ed alta cosa che non le tragedie mie o le altrui.
Ma questa specie di gente è, e dev'essere, inconvertibile.
Ed io, per natura mia, non disputo mai, se non se raramente con quelli con cui concordiamo di massima; agli altri ogni cosa io la do vinta alla prima.
Mi contentai dunque di non acconsentire.
Questa mia resistenza negativa verisimilmente poi passò sino al re pel canal del ministro; onde il giorno dopo, ch'io vi fui a inchinarlo, il re non mi parlò punto di questo, e del rimanente mi accolse colla massima affabilità e cortesia, che gli è propria.
Questi era (ed ancora regna) Vittorio Amedeo II, figlio di Carlo Emanuele, sotto il cui regno io nacqui.
Ancorché io non ami punto i re in genere, e meno i piú arbitrari, debbo pur dire ingenuamente che la razza di questi nostri principi è ottima sul totale, e massime paragonandola a quasi tutte l'altre presenti d'Europa.
Ed io mi sentiva nell'intimo del cuore piuttosto affetto per essi, che non avversione; stante che sí questo re che il di lui predecessore, sono di ottime intenzioni, di buona e costumata ed esemplarissima indole e fanno al paese loro piú bene che male.
Con tutto ciò quando si pensa e vivamente si sente che il loro giovare o nuocere pendono dal loro assoluto volere, bisogna fremere, e fuggire.
E cosí feci io dopo alcuni giorni, quanti bastarono per rivedere i miei parenti e conoscenti in Torino, e trattenermi piacevolmente e utilmente per me le piú ore di quei pochi giorni coll'incomparabile amico, l'abate di Caluso, che un cotal poco mi riassestò anche il capo, e mi riscosse dal letargo in cui la stalla mi avea precipitato, e quasi che sepellito.
Nel trattenermi in Torino mi toccò di assistere (senza ch'io n'avessi gran voglia) ad una recita pubblica della mia Virginia, che fu fatta su lo stesso teatro, nove anni dopo quella della Cleopatra, da attori a un bel circa della stessa abilità.
Un mio amico già d'Accademia avea preparata questa recita già prima ch'io arrivassi a Torino, e senza sapere ch'io ci capiterei.
Egli mi chiese di volermi adoprare nell'addestrare un tal poco gli attori; come avea fatto già per la Cleopatra.
Ma io, cresciuto forse alquanto di mezzi, e molto piú di orgoglio, non mi ci volli prestare in nulla, conoscendo benissimo quel che siano finora ed i nostri attori, e le nostre platee.
Non mi volli dunque far complice a nessun patto della loro incapacità, che senza averli sentiti ella mi era già cosa dimostratissima.
Sapeva, che avrebbe bisognato cominciare dall'impossibile; cioè dall'insegnar loro a parlare e pronunziar italiano, e non veneziano; a recitar essi, e non il rammentatore; ad intendere (troppo sarebbe pretendere, s'io dicessi a sentire), ma ad intendere semplicemente quello che volean far intendere all'uditorio.
Non era poi dunque sí irragionevole il mio niego, né si indiscreto il mio orgoglio.
Lasciai dunque che l'amico ci pensasse da sé, e condiscesi soltanto col promettergli a mal mio grado d'assistervi.
Ed in fatti ci fui, già ben convinto in me stesso, che di vivente mio non v'era da raccogliere per me in nessunissimo teatro d'Italia, né lode né biasimo.
La Virginia ottenne per l'appunto la stessa attenzione, e lo stessissimo esito che avea già ottenuta la Cleopatra; e fu richiesta per la sera dopo, né piú né meno di quella; ed io, come si può credere, non ci tornai.
Ma da quel giorno cominciò in gran parte quel mio disinganno di gloria, in cui mi vo di giorno in giorno sempre piú confermando.
Con tutto ciò non mi rimoverò io dall'abbracciato proposito di tentare ancora per altri dieci o quindici anni all'incirca, sin sotto ai sessanta cioè, di scrivere in due o tre altri generi delle nuove composizioni, quanto piú accuratamente e meglio il saprò; per avere, morendo o invecchiando, la intima consolazione di aver soddisfatto a me stesso, ed all'arte quant'era in me.
Che quanto ai giudizi degli uomini presenti, atteso lo stato in cui si trova l'arte critica in Italia, ripeto piangendo, che non v'è da sperare né ottenere per ora, né lode né biasimo.
Che io non reputo lode, quella che non discerne, e motivando sé stessa inanima l'autore; né biasimo chiamo, quello che non t'insegna a far meglio.
Io patii morte a codesta recita della Virginia, piú ancora che a quella di Cleopatra, ma per ragioni troppo diverse.
Né piú esattamente le voglio allegare ora qui; poiché a chi ha ed il gusto e l'orgoglio dell'arte, elle già sono notissime; per chi non l'ha, elle riuscirebbero inutili ed inconcepibili.
Partito di Torino, mi trattenni tre giorni in Asti presso l'ottima rispettabilissima mia madre.
Ci separammo poi con gran lagrime, presagendo ambedue che verisimilmente non ci saremmo piú riveduti.
Io non dirò che mi sentissi per lei quanto affetto avrei potuto e dovuto; atteso che dall'età di nov'anni in poi non mi era mai piú trovato con essa, se non se alla sfuggita per ore.
Ma la mia stima, gratitudine, e venerazione per essa e per le di lei virtú è stata sempre somma, e lo sarà finch'io vivo.
Il Cielo le accordi lunga vita, poich'ella sí bene la impiega in edificazione e vantaggio di tutta la sua città.
Essa poi è oltre ogni dire sviscerata per me, piú assai ch'io non abbia mai meritato.
Perciò il di lei vero ed immenso dolore nell'atto della nostra dipartenza grandemente mi accorò, ed accora.
Appena uscito io poi dagli stati del re sardo, mi sentii come allargato il respiro: cotanto mi pesava tuttavia tacitamente sul collo anche l'avanzo stesso di quel mio giogo natio, ancorché infranto lo avessi.
Talché il poco tempo ch'io vi stetti, ogni qualvolta mi dovei trovare con alcuno dei barbassori governanti di quel paese, io mi vi teneva piuttosto in aspetto di liberto che non d'uomo libero; sempre rammentandomi quel bellissimo detto di Pompeo nello scendere in Egitto alla discrezione ed arbitrio d'un Fotino: "Chi entra in casa del tiranno, s'egli schiavo non era si fa".
Cosí, chi per mero ozio e vaghezza rientra nel già disertato suo carcere, vi si può benissimo ritrovar chiuso all'uscirne, finché pur carcerieri rimangonvi.
Inoltrandomi intanto verso Modena, le nuove ch'io avea ricevute dalla mia donna mi andavano riempiendo or di dolore, ora di speranza, e sempre di molta incertezza.
Ma l'ultime ricevute in Piacenza mi annunziavano finalmente la di lei liberazione di Roma, il che mi empiva d'allegrezza; poiché Roma era per allora il sol luogo dove non l'avrei potuta vedere, ma per altra parte la convenienza con catene di piombo mi vietava assolutamente, anche in quel punto, di seguitarla.
Ella aveva con mille stenti, e con dei sacrifici pecuniari non piccioli verso il marito, ottenuto finalmente dal cognato, e dal papa, la licenza di portarsi negli Svizzeri all'acque di Baden; trovandosi per i molti disgusti la di lei salute considerabilmente alterata.
In quel giugno dunque dell'anno 1784 ell'erasi partita di Roma, e bel bello lungo la spiaggia dell'Adriatico, per Bologna e Mantova e Trento, si avviava verso il Tirolo, nel tempo stesso che io partitomi di Torino, per Piacenza, Modena e Pistoia me ne ritornava a Siena.
Questo pensiero, di essere allora cosí vicino a lei, per tosto poi di bel nuovo rimanere cosí disgiunti e lontani, mi riusciva ad un tempo e piacevole e doloroso.
Avrei benissimo potuto mandar per la diritta in Toscana il mio legno e la mia gente, ed io a traverso per le poste a cavallo soletto l'avrei potuta presto raggiungere, e almen l'avrei vista.
Desiderava, temeva, sperava, voleva, disvoleva: vicende tutte ben note ai pochi e veraci amatori; ma vinse pur finalmente il dovere, e l'amore di essa e del di lei decoro, piú che di me.
Onde, bestemmiando e piangendo, non mi scartai punto dalla strada mia.
Cosí sotto il peso gravissimo di questa mia dolorosa vittoria giunsi in Siena dopo dieci mesi in circa di viaggio; e ritrovai nell'amico Gori l'usato mio necessarissimo conforto, onde andarvi pure strascinando la vita, e stancando oramai le speranze.
CAPITOLO DECIMOQUARTO
Viaggio in Alsazia.
Rivedo la donna mia.
Ideate tre nuove tragedie.
Morte inaspettata dell'amico Gori in Siena.
Erano frattanto giunti in Siena pochi giorni dopo di me i miei quattordici cavalli, ed il decimoquinto ve l'avea lasciato io in custodia all'amico; ed era il mio bel falbo, il Fido; quello stesso che in Roma avea piú volte portato il dolce peso della donna mia, e che perciò mi era egli solo piú caro assai che tutta la nuova brigata.
Tutte queste bestie mi tenevano scioperato e divagato ad un tempo; aggiuntavi poi la scontentezza di cuore, io andava invano tentando di ripigliare le occupazioni letterarie.
Parte di giugno, e tutto luglio ch'io stetti senza muovermi di Siena, mi si consumarono cosí, senza ch'io facessi altro che qualche rime.
Feci anche alcune stanze che mancavano a terminare il terzo canto del poemetto, e vi cominciai il quarto ed ultimo.
Quell'opera, benché lavorata con tante interruzioni, in cosí lungo tempo, e sempre alla spezzata, e senza ch'io avessi alcun piano scritto, mi stava con tutto ciò assai fortemente fitta nel capo; e l'avvertenza ch'io vi osservava il piú, era di non l'allungare di soverchio; il che, se io mi fossi lasciato andare agli episodi o ad altri ornamenti, mi sarebbe riuscito pur troppo facile.
Ma a volerla far cosa originale e frizzante d'un agrodolce terribile, il pregio di cui piú abbisognava si era la brevità.
Perciò da prima io l'aveva ideata di tre soli canti; ma la rassegna dei consiglieri mi avea rubato quasi che un canto, perciò furon quattro.
Non sono però ben certo in me stesso che quei tanti interrompimenti non abbiano influito sul totale del poema, dandogli un non so che di sconnesso.
Mentre io stava dunque tentando di proseguire quel quarto canto, io andava sempre ricevendo e scrivendo gran lettere; queste a poco a poco mi riempirono di speranza, e vieppiú m'infiammarono del desiderio di rivederla tra breve.
E tanto andò crescendo questa possibilità, che un bel giorno non potendo io piú stare a segno, detto al solo amico Gori dove io fossi per andare, e finto di fare una scorsa a Venezia, io mi avviai verso la Germania il dí quattro d'agosto.
Giorno, oimè, di sempre amara ricordanza per me.
Che mentre io baldo e pieno di gioia mi avviava verso la metà di me stesso, non sapeva io che nell'abbracciare quel caro e raro amico, che per sei settimane sole mi credea di lasciarlo, io lo lascerei per l'eternità.
Cosa, di cui non posso parlare, né pur pensarci, senza prorompere in pianto, anche molti anni dopo.
Ma tacerò di questo pianto, poiché altrove quanto meglio il seppi v'ho dato sfogo.
Eccomi dunque da capo per viaggio.
Per la solita mia dilettissima e assai poetica strada di Pistoia a Modena, me ne vo rapidissimamente a Mantova, Trento, Inspruck, e quindi per la Soavia a Colmar, città dell'Alsazia superiore alla sinistra del Reno.
Quivi presso ritrovai finalmente quella ch'io andava sempre chiamando e cercando, orbo di lei da piú di sedici mesi.
Io feci tutto questo cammino in dodici giorni né mai mi pareva di muovermi, per quanto i' corressi.
Mi si riaprí in quel viaggio piú abbondante che mai si fosse la vena delle rime, e chi potea in me piú di me mi facea comporre sino a tre e piú sonetti quasi ogni giorno; essendo quasi fuor di me dal trasporto di calcare per tutta quella strada le di lei orme stesse, e per tutto informandomi, e rilevando ch'ella vi era passata circa due mesi innanzi.
E col cuore alle volte gioioso, mi rivolsi anche al poetare festevole; onde scrissi cammin facendo un capitolo al Gori, per dargli le istruzioni necessarie per la custodia degli amati cavalli, che pure non erano in me che la passione terza: troppo mi vergognerei se avessi detto, seconda; dovendo, come è di ragione, al Pegaso preceder le Muse.
Quel mio lunghetto capitolo, che poi ho collocato fra le rime, fu la prima e quasi che la sola poesia ch'io mai scrivessi in quel genere bernesco, di cui, ancorché non sia quello al quale la natura m'inclini il piú, tuttavia pure mi par di sentire tutte le grazie e il lepore.
Ma non sempre il sentirle basta ad esprimerle.
Ho fatto come ho saputo.
Giunto il dí 16 agosto presso la mia donna, due mesi in circa mi vi sfuggirono quasi un baleno.
Ritrovatomi cosí di bel nuovo interissimo di animo di cuore e di mente, non erano ancor passati quindici giorni dal dí ch'io era ritornato alla vita rivedendola, che quell'istesso io il quale da due anni non avea mai piú neppure sognato di scrivere oramai altre tragedie; quell'io, che anzi avendo appeso il coturno al Saul, mi era fermamente proposto di non lo spiccare mai piú; mi ritrovai allora, senza accorgermene quasi, ideate per forza altre tre tragedie ad un parto: Agide, Sofonisba, e Mirra.
Le due prime, mi erano cadute in mente altre volte, e sempre l'avea discacciate; ma questa volta poi mi si erano talmente rifitte nella fantasia, che mi fu forza di gettarne in carta l'abbozzo, credendomi pure e sperando che non le potrei poi distendere.
A Mirra non avea pensato mai; ed anzi, essa non meno che Bibli, e cosí ogni altro incestuoso amore, mi si erano sempre mostrate come soggetti non tragediabili.
Mi capitò alle mani nelle Metamorfosi di Ovidio quella caldissima e veramente divina allocuzione di Mirra alla di lei nutrice, la quale mi fece prorompere in lagrime, e quasi un subitaneo lampo mi destò l'idea di porla in tragedia; e mi parve che toccantissima ed originalissima tragedia potrebbe riuscire, ogni qual volta potesse venir fatto all'autore di maneggiarla in tal modo che lo spettatore scoprisse da sé stesso a poco a poco tutte le orribili tempeste del cuore infuocato ad un tempo e purissimo della piú assai infelice che non colpevole Mirra, senza che ella neppure la metà ne accennasse, non confessando quasi a sé medesima, non che ad altra persona nessuna, un sí nefando amore.
In somma l'ideai a bella prima, ch'ella dovesse nella mia tragedia operare quelle cose stesse, ch'ella in Ovidio descrive; ma operarle tacendole.
Sentii fin da quel punto l'immensa difficoltà ch'io incontrerei nel dover far durare questa scabrosissima fluttuazione dell'animo di Mirra per tutti gl'interi cinque atti, senza accidenti accattati d'altrove.
E questa difficoltà che allora vieppiú m'infiammò, e quindi poi nello stenderla, verseggiarla, e stamparla sempre piú mi fu sprone a tentare di vincerla, io tuttavia dopo averla fatta, la conosco e la temo quant'ella s'è; lasciando giudicar poi dagli altri s'io l'abbia saputa superare nell'intero, od in parte, od in nulla.
Questi tre nuovi parti tragici mi raccesero l'amor della gloria, la quale io non desiderava per altro fine oramai, se non se per dividerla con chi mi era piú caro di essa.
Io dunque allora da circa un mese stava passando i miei giorni beati, e occupati, e da nessunissima amarezza sturbati, fuorché dall'anticipato orribile pensiero che al piú al piú fra un altro mesetto era indispensabile il separarci di nuovo.
Ma, quasi che questo sovrastante timore non fosse bastato egli solo a mescermi infinita amarezza al poco dolce brevissimo ch'io assaporava, la fortuna nemica me ne volle aggiungere una dose non piccola per farmi a caro prezzo scontare quel passeggero sollievo.
Lettere di Siena mi portarono nello spazio di otto giorni, prima la nuova della morte del fratello minore del mio Gori, e la malattia non indifferente di esso; successivamente le prossime nuove mi portarono pur anche la morte di esso in sei soli giorni di malattia.
Se io non mi fossi trovato con la mia donna al ricevere questo colpo sí rapido ed inaspettato, gli effetti del mio giusto dolore sarebbero stati assai piú fieri e terribili.
Ma l'aver con chi piangere menoma il pianto d'assai.
La mia donna conosceva essa pure e moltissimo amava quel mio Francesco Gori; il quale l'anno innanzi, dopo avermi accompagnato, come dissi, a Genova, tornato poi in Toscana erasi quindi portato a Roma quasi a posta per conoscerla, e soggiornatovi alcuni mesi l'aveva continuamente trattata, ed aveala giornalmente accompagnata nel visitare i tanti prodotti delle bell'arti di cui egli era caldissimo amatore e sagace conoscitore.
Essa perciò nel piangerlo meco non lo pianse soltanto per me, ma anche per sé medesima, conoscendone per recente prova tutto il valore.
Questa disgrazia turbò oltre modo il rimanente del breve tempo che si stette insieme; ed approssimandosi poi il termine, tanto piú amara ed orribile ci riuscí questa separazione seconda.
Venuto il temuto giorno, bisognò obbedire alla sorte, ed io dovei rientrare in ben altre tenebre, rimanendo questa volta disgiunto dalla mia donna senza sapere per quanto, e privo dell'amico colla funesta certezza ch'io l'era per sempre.
Ogni passo di quella stessa via, che al venire mi era andato sgombrando il dolore ed i tetri pensieri, me li facea raddoppiati ritrovare al ritorno.
Vinto dal dolore, poche rime feci, ed un continuo piangere sino a Siena dove mi restituii ai primi di novembre.
Alcuni amici dell'amico, che mi amavano di rimbalzo, ed io cosí loro, mi accrebbero in quei primi giorni smisuratamente il dolore troppo bene servendomi nel mio desiderio di sapere ogni particolarità di quel funesto accidente; ed io tremando pur sempre e sfuggendo di udirle, le andava pur domandando.
Non tornai piú ad alloggio (come ben si può credere) in quella casa del pianto, che anzi non l'ho rivista mai piú.
Fin da quando io era tornato di Milano l'anno innanzi, io avea accettato dall'ottimo cuor dell'amico un molto gaio e solitario quartierino nella di lui casa, e ci vivevamo come fratelli.
Ma il soggiorno di Siena senza il mio Gori, mi si fece immediatamente insoffribile.
Volli tentare di indebolirne alquanto il dolore senza punto scemarmene la memoria, col cangiare e luoghi ed oggetti.
Mi trasferii perciò nel novembre in Pisa, risolutomi di starvi quell'inverno; ed aspettando che un miglior destino mi restituisse a me stesso; che privo d'ogni pascolo del cuore, veramente non mi potea riputar vivo.
CAPITOLO DECIMOQUINTO
Soggiorno in Pisa.
Scrittovi il Panegirico a Traiano ed altre cose.
La mia donna frattanto era per le Alpi della Savoia rientrata 1785 anch'essa in Italia; e per la via di Torino venuta a Genova, quindi a Bologna, in quest'ultima città si propose di passare l'inverno; combinandosi in questo modo per lei di stare negli Stati Pontificii, senza pure rimettersi in Roma nell'usato carcere.
Sotto il pretesto dunque della stagione troppo inoltrata, sendo giunta a Bologna in decembre, non ne partí altrimenti.
Eccoci dunque, io a Pisa, ed essa in Bologna, col solo Apennino di mezzo, per quasi cinque mesi, di nuovo disgiunti e pur vicinissimi.
Questo m'era ad un tempo stesso una consolazione e un martirio; ne ricevea le nuove freschissime ogni tre o quattro giorni, e non potea pure né doveva in niun modo tentar di vederla, atteso il gran pettegolezzo delle città piccole d'Italia, dove chi nulla nulla esce dal volgo, è sempre minutamente osservato dai molti oziosi e maligni.
Io mi passai dunque in Pisa quel lunghissimo inverno, col solo sollievo delle di lei spessissime lettere, e perdendo al solito il mio tempo fra i molti cavalli, e quasi nulla servendomi dei pochi ma fidi miei libri.
Sforzato pure dalla noia, e nell'ore che cavalcare ed aurigare non si poteva, tanto e tanto qualcosa andava pur leggicchiando, massime la mattina in letto, appena sveglio.
In queste semiletture avea scorse le lettere di Plinio il Minore, e molto mi avean dilettato sí per la loro eleganza, sí per le molte notizie su le cose e costumi romani che vi si imparano; oltre poi il purissimo animo, e la bella ed amabile indole che vi va sviluppando l'autore.
Finite l'epistole, impresi di leggere il Panegirico a Traiano, opera che mi era nota per fama, ma di cui non avea mai letta parola.
Inoltratomi per alcune pagine, e non vi ritrovando quell'uomo stesso dell'epistole, e molto meno un amico di Tacito, qual egli si professava, io sentii nel mio intimo un certo tal moto d'indegnazione; e tosto, buttato là il libro saltai a sedere sul letto, dov'io giaceva nel leggere; ed impugnata con ira la penna, ad alta voce gridando dissi a me stesso: "Plinio mio, se tu eri davvero e l'amico, e l'emulo, e l'ammiratore di Tacito, ecco come avresti dovuto parlare a Traiano".
E senza piú aspettare, né riflettere, scrissi d'impeto, quasi forsennato, cosí come la penna buttava, circa quattro gran pagine del mio minutissimo scritto; finché stanco, e disebriato dallo sfogo delle versate parole, lasciai di scrivere, e quel giorno non vi pensai piú.
La mattina dopo, ripigliato il mio Plinio, o per dir meglio, quel Plinio che tanto mi era scaduto di grazia nel giorno innanzi, volli continuar di leggere il di lui Panegirico.
Alcune poche pagine piú, facendomi gran forza, ne lessi; poi non mi fu possibile di proseguire, Allora volli un po' rileggere quello squarcione del mio Panegirico, ch'io avea scritto delirando la mattina innanzi.
Lettolo, e piaciutomi, e rinfiammato piú di prima, d'una burla ne feci, o credei farne, una cosa serissima; e distribuito e diviso alla meglio il mio tema, senza piú ripigliar fiato, scrivendone ogni mattina quanto ne potevan gli occhi, che dopo un par d'ore di entusiastico lavoro non mi fanno piú luce; e pensandovi poi e ruminandone tutto l'intero giorno, come sempre mi accade allorché non so chi mi dà questa febbre del concepire e comporre; me lo trovai tutto steso nella quinta mattina, dal dí 13 al 17 di marzo! e, con pochissima varietà, toltone l'opera della lima, da quello che va dattorno stampato.
Codesto lavoro mi avea riacceso l'intelletto, ed una qualche tregua avea pur anche data ai miei tanti dolori.
Ed allora mi convinsi per esperienza, che a voler tollerare quelle mie angustie d'animo, ed aspettarne il fine senza soccombere, mi era piú che necessario di farmi forza, e costringer la mente ad un qualche lavoro.
Ma siccome la mente mia, piú libera e piú indipendente di me, non mi vuole a niun conto obbedire; tal che, se io mi fossi proposto, prima di leggere il Plinio, di voler fare un panegirico a Traiano, non avrebbe essa forse voluto raccozzar due idee; per ingannare ad un tempo e il dolore e la mente, trovai il compenso di violentarmi in una qualche opera di pazienza, e di schiena come si suol dire.
Perciò tornatomi fra mani quel Sallustio che circa dieci anni prima aveva tradotto in Torino per semplice studio, lo feci ricopiare col testo accanto, e mi posi seriamente a correggerlo, coll'intenzione e speranza ch'egli riuscisse una cosa.
Ma neppure per questo pacifico lavoro io sentiva il mio animo capace di continua e tranquilla applicazione; onde non lo migliorai di gran fatto, anzi mi avvidi, che nel bollore e deliri d'un cuore preoccupato e scontento, riesce forse piú possibile il concepire e creare una cosa breve e focosa, che non il freddamente limare una cosa già fatta.
La lima è un tedio, onde facilmente si pensa ad altro, adoprandola.
La creazione è una febbre, durante l'accesso, non si sente altro che lei.
Lasciato dunque il Sallustio a tempi piú lieti, mi rivolsi a continuar quella prosa Del principe e delle lettere, da me ideata, e distribuita piú anni prima in Firenze.
Ne scrissi allora tutto il primo libro, e due o tre capitoli del secondo.
Fin dall'estate antecedente, al mio tornare d'Inghilterra in Siena, io aveva pubblicato il terzo volume delle tragedie, e mandatolo, come a molti altri valentuomini d'Italia, anche all'egregio Cesarotti, pregandolo di darmi un qualche lume sovra il mio stile e composizione e condotta.
Ne ricevei in quell'aprile una lettera critica su le tre tragedie del terzo volume, alla quale risposi allora brevemente, ringraziandolo, e notando le cose che mi pareano da potersi ribattere; e ripregandolo di indicarmi o darmi egli un qualche modello di verso tragico.
E da notarsi su ciò, che quello stesso Cesarotti, il quale aveva concepiti ed eseguiti con tanta maestria i sublimi versi dell'Ossian, essendo stato richiesto da me, quasi due anni prima, di volermi indicare un qualche modello di verso sciolto di dialogo, egli non si vergognò di parlarmi d'alcune sue traduzioni dal francese, della Semiramide e del Maometto di Voltaire, stampate già da molti anni; e di tacitamente propormele per modello.
Queste traduzioni del Cesarotti essendo in mano di chiunque le vorrà leggere, non occorre ch'io aggiunga riflessioni su questo particolare; ognuno se ne può far giudice e paragonare quei versi tragici con i miei; e paragonarli anche con i versi epici dello stesso Cesarotti nell'Ossian, e vedere se paíano della stessa officina.
Ma questo fatto servirà pure a dimostrare quanto miserabil cosa siamo noi tutti uomini, e noi autori massimamente, che sempre abbiam fra le mani e tavolozza e pennello per dipingere altrui, ma non mai lo specchio per ben rimirarci noi stessi e conoscerci.
Il giornalista di Pisa, dovendo poi dare o inserire nel suo giornale un giudizio critico su quel mio terzo tomo delle tragedie, stimò piú breve e piú facil cosa il trascrivere a dirittura quella lettera del Cesarotti, con le mie note che le servono di risposta.
Io mi trattenni in Pisa sino a tutto l'agosto di quell'anno 1785; e non vi feci piú nulla da quelle prose in poi, fuorché far ricopiare le dieci tragedie stampate, ed apporvi in margine molte mutazioni, che allora mi parvero soverchie; ma quando poi venni a ristamparle in Parigi, elle mi vi parvero piú che insufficienti, e bisognò per lo meno quadruplicarle.
Nel maggio di quell'anno godei in Pisa del divertimento del Giuoco del Ponte, spettacolo bellissimo, che riunisce un non so che di antico e d'eroico.
Vi si aggiunse anco un'altra festa bellissima d'un altro genere, la luminara di tutta la detta città, come si costuma ogni due anni per la festa di San Ranieri.
Queste feste si fecero allora riunitamente, all'occasione della venuta del re e regina di Napoli in Toscana per visitarvi il gran duca Leopoldo, cognato del suddetto re.
La mia vanaglorietta in quelle feste rimase bastantemente soddisfatta, essendomi io fatto molto osservare a cagione de' miei be' cavalli inglesi, che vincevano in mole, bellezza e brio quanti altri mai cavalli vi fossero capitati in codest'occasione.
Ma in mezzo a quel mio fallace e pueril godimento, mi convinsi con sommo dolore ad un tempo stesso, che nella fetida e morta Italia ella era assai piú facil cosa il farsi additare per via di cavalli, che non per via di tragedie.
CAPITOLO DECIMOSESTO
Secondo viaggio in Alsazia, dove mi fisso.
Ideativi, e stesi i due Bruti, e l'Abele.
Studi caldamente ripigliati.
In questo frattempo era ripartita di Bologna la mia donna, ed avviatasi verso Parigi nel mese di aprile.
Non volendo essa tornare a Roma, in nessun altro luogo ella potea piú convenientemente fissarsi che in Francia, dove avea parenti, aderenze, e interessi.
Trattenutasi in Parigi sino all'agosto inoltrato, ella ritornò in Alsazia in quella stessa villa dove c'eramo incontrati l'anno innanzi.
Onde io ai primi di settembre con infinita gioia e premura mi vi avviai per la solita strada dell'Alpi tirolesi.
Ma l'aver perduto l'amico di Siena, e l'essersi oramai la mia donna traspiantata fuori d'Italia, mi fece anche risolvere di non dimorarci piú neppur io.
E benché per allora né volessi, né convenisse ch'io mi fissassi a dimora dove ella, io cercai pure di starle il meno lontano ch'io potessi, e di toglierci almeno l'Alpi di mezzo.
Feci dunque muovere anche tutta la mia cavalleria, che sana e salva arrivò un mese dopo di me in Alsazia, dove allora ebbi raccolto ogni mia cosa, fuorché i libri, che i piú gli avea lasciati in Roma.
Ma la mia felicità derivata da questa seconda riunione non durò né potea durare altro che due mesi in circa, dovendosi la mia donna restituire in Parigi nell'inverno.
Nel decembre l'accompagnai sino a Strasborgo, dove, con mio sommo dolore costretto di lasciarla, me ne separai per la terza volta; ella continuò la sua strada per Parigi, io ritornai nella nostra villa.
Ancorché io fossi scontento, pure la mia afflizione riusciva ora assai minore della passata, trovandoci piú vicini, Potendo senza ostacolo, e senza pericolo di nuocerle dare una scorsa per vederla, ed avendo in somma fra noi la certezza di rivederci nella prossima estate.
Tutte queste speranze mi posero un tal balsamo in corpo, e mi rischiarirono talmente l'intelletto, che di bel nuovo intieramente mi diedi in braccio alle Muse.
In quel solo inverno, nella quiete e libertà della villa, feci assai piú lavoro che non avessi fatto mai in cosí breve spazio di tempo; cotanto la continuità del pensare ad una stessa cosa, e a non aver divagazioni né dispiaceri, abbreviandoci l'ore ad un tempo ce le moltiplica.
Appena tornato nel mio ritiro, da prima finii di stendere l'Agide, che fin dal decembre precedente avea cominciato in Pisa; poi infastidito del lavoro (cosa che non mi accadeva mai nel creare) non lo avea piú potuto proseguire.
Finitolo ora felicemente, senza pigliar piú respiro stesi in quello stesso decembre la Sofonisba e la Mirra.
Quindi in gennaio finii interamente di stendere il secondo e terzo libro Del principe e delle lettere; ideai e stesi il dialogo Della virtú sconosciuta; tributo che da gran tempo mi rimproverava di non aver pagato alla adorata memoria del degnissimo amico Gori; e ideai inoltre, e distesi tutta, e verseggiai la parte lirica dell'Abele tramelogedia; genere di cui mi occorrerà di parlare in appresso, se avrò vita e mente e mezzi da effettuare quanto mi propongo di eseguire.
Postomi quindi al far versi, non abbandonai piú quel mio poemetto ch'io non l'avessi interamente terminato col quarto canto; e quindi dettati, ricorretti, e riannestati insieme i tre altri, che nello spazio di dieci anni essendo stati scritti a pezzi, aveano (e forse tuttora serbano) un non so che di sconnesso; il che tra i miei molti difetti non suole però avvenirmi nelle altre composizioni.
Appena era finito il poema, mi accadde che in una delle tante e sempre a me graditissime lettere della mia donna, essa come a caso mi accennava di aver assistito in teatro ad una recita del Bruto di Voltaire, e che codesta tragedia le era sommamente piaciuta.
Io, che l'aveva veduta recitare forse dieci anni prima, e che non me ne ricordava punto, riempiutomi istantaneamente di una rabida e disdegnosa emulazione sí il cuor che la mente, dissi fra me: "Che Bruti, che Bruti di un Voltaire? io ne farò dei Bruti, e li farò tutt'e due: il tempo dimostrerà poi, se tali soggetti di tragedia si addicessero meglio a me, o ad un francese nato plebeo, e sottoscrittosi nelle sue firme per lo spazio di settanta e piú anni: Voltaire gentiluomo ordinario del re".
Né altro dissi, né di questo toccai pur parola nel rispondere alla mia donna; ma subitamente d'un lampo ideai ad un parto i due Bruti, quali poi li ho eseguiti.
In questo modo uscii per la terza volta dal mio proposito di non far piú tragedie; e da dodici ch'essere doveano, son arrivate a diciannove.
Su l'ultimo Bruto rinnovai poi il giuramento ad Apolline piú solenne ch'io non l'avessi fatto mai, e questo io son quasi certo di non l'aver piú ad infrangere.
Gli anni che mi si vanno ammontando sul tergo me n'entrano quasi mallevadori; e le tante altre cose di altro genere che mi restan da fare, se pure farle potrò e saprò.
Dopo aver passati cinque e piú mesi in villa in un continuo bollore di mente, poiché appena sveglio la mattina per tempissimo io scriveva cinque o sei pagine alla mia donna; poi lavorava fino alle due o le tre dopo mezzogiorno; poi andando o a cavallo, o in biroccio per un par d'ore, in vece di divagarmi e riposarmi, pel continuo pensare ora a quel verso, ora a quel personaggio, ora ad altro, mi affaticava assai piú l'intelletto che non lo sollevassi; mi ritrovai perciò nell'aprile una fierissima podagra a ridosso, la quale m'inchiodò per la prima volta in letto, e mi vi tenne immobile e addoloratissimo per quindici giorni almeno, e pose cosí una spiacevole interruzione ai miei studi sí caldamente avviati.
Ma troppo avea impreso, di vivere solitario e occupato, né ci avrei potuto resistere senza i cavalli che tanto mi sforzavano a pigliar l'aria aperta, e far moto.
Ma anche coi cavalli, non la potei durare quella perpetua incessante tensione delle fibre del cervello; e se la gotta, piú savia di me, non mi vi facea dar tregua, avrei finito o col delirar d'intelletto, o col soccombere delle forze fisiche, sendomi ridotto a quasi nulla cibarmi, e pochissimo dormire.
Nel maggio tuttavia, mercè la gran dieta, e il riposo, mi trovai bastantemente riavuto di forze; ma alcune circostanze particolari avendo impedito per allora la mia donna di venire in villa, e dovendo differire la consolazione unica per me, del vederla; entrai in un turbamento di spirito, che mi offuscò per piú di tre mesi la mente, talché poco e male lavorai, fino al fin d'agosto, quanto al riapparire dell'aspettata donna tutti questi miei mali di accesa e scontenta fantasia sparirono.
Appena riavutomi di mente e di corpo, dati all'oblio i dolori di questa lontananza, che per mia buona sorte fu l'ultima, tosto mi rimisi al lavoro con ardore e furore.
A segno che verso il mezzo decembre, che si partí poi insieme per Parigi, io mi trovai aver verseggiate l'Agide, la Sofonisba, e la Mirra; mi trovai stesi i due Bruti; e scritta la prima satira.
Questo nuovo genere, di cui avea già ideato e distribuiti i soggetti fin da nove anni prima in Firenze, l'aveva anche tentato allora in esecuzione; ma scarso ancora troppo di lingua e di padronanza di rima, mi ci era rotto le corna; talché dubbio del potervi riuscire quanto allo stile e verseggiatura, ne avea quasi deposto il pensiere.
Ma il raggio vivificante della donna mia, mi ebbe allora restituito l'ardire e baldanza necessari da ciò; e postomi al tentativo, mi vi parve esser riuscito, a principiare almeno l'aringo, se non a percorrerlo.
E cosí pure, avendo prima di partir per Parigi fatta una rassegna delle mie rime, e dettate e limate gran parte, me ne trovai in buon numero, e forse troppe.
CAPITOLO DECIMOSETTIMO
Viaggio a Parigi.
Ritorno in Alsazia, dopo aver fissato col Didot in Parigi la stampa di tutte le diciannove tragedie.
Malattia fierissima in Alsazia, dove l'amico Caluso era venuto per passare l'estate con noi.
Dopo quattordici e piú mesi non interrotti di soggiorno in Alsazia, partii insieme con la signora alla volta di Parigi; luogo a me per natura sua e mia sempre spiacevolissimo, ma che mi si facea allor paradiso poiché lo abitava la mia donna.
Tuttavia, essendo incerto se vi rimarrei lungamente, lasciai gli amati cavalli nella villa di Alsazia, e munito soltanto di alcuni libri, e di tutti i miei scritti mi ritrovai in Parigi.
Alla prima, il rumore e la puzza di quel caos dopo una sí lunga villeggiatura, mi rattristarono assai.
La combinazione poi del ritrovarmi alloggiato assai lontano dalla mia donna, oltre mill'altre cose che di quella Babilonia mi dispiaceano sommamente, mi avrebbero fatto ripartirne ben tosto se io avessi vissuto in me stesso e per me; ma ciò non essendo da tanti anni oramai, con molta malinconia mi adattai alla necessità; e cercai di cavarne almeno qualche utile coll'impararvi qualche cosa.
Ma quanto all'arte del verseggiare non v'essendo in Parigi nessuno dei letterati che intenda piú che mediocremente la lingua nostra, non c'era niente da impararvi per me; quanto poi all'arte drammatica in massa, ancorché i francesi vi si accordino essi stessi esclusivamente il primato, tuttavia i miei principî non essendo gli stessi che han praticato i loro autori tragici, molta e troppa flemma mi ci volea per sentirmi dettare magistralmente continue sentenze, di cui molte vere, ma assai male eseguite da essi.
Pure, essendo il mio metodo di poco contradire, e non mai disputare, e moltissimo e tutti ascoltare, e non credere poi quasiché mai in nessuno; io tanto e tanto imparava da quei ciarlieri la sublime arte del tacere.
Quel primo soggiorno, di sei e piú mesi in Parigi, mi giovò, se non altro, alla salute moltissimo.
Prima del mezzo giugno si ripartí per la villa d'Alsazia.
Ma intanto stando in Parigi avea verseggiato il Bruto primo, e per un accidente assai comico mi era toccato di rimpasticciare tutta intera la Sofonisba.
La volli leggere ad un francese già mio conoscente in Torino, dove aveva soggiornato degli anni; persona intelligente di cose drammatiche; e che piú anni prima mi avea ben consigliato sul Filippo, quando glie lo aveva letto in prosa francese, di trasporvi il consiglio dal quarto atto dov'era, nel terzo dove poi è rimasto, e dove nuoce assai meno alla progressione dell'azione, di quel che dianzi nuoceva nel quarto.
Sicché leggendo io quella Sofonisba ad un giudice competente, mi immedesimava in lui quant'io piú poteva, per argomentare dal di lui contegno piú che dai di lui detti, qual fosse il suo schietto parere.
Egli mi stava ascoltando senza batter palpebra; ma io, che altresí mi stava ascoltando per due, incominciai da mezzo il second'atto a sentirmi assalire da una certa freddezza, che talmente mi andò crescendo nel terzo ch'io non lo potei pur finire; e preso da un impeto irresistibile la buttai sul fuoco, ché stavamo al camminetto noi due solissimi; e parea che quel fuoco mi fosse come un tacito invito a quella severa e pronta giustizia.
L'amico, sorpreso di quell'inaspettata stranezza (stante che io non avea neppur detto una parola fino a quel punto, che l'accennasse neppure), si buttò colle mani su lo scartario per estrarlo dal fuoco, ma io già colle molle che aveva rapidissimamente impugnate, inchiodai sí stizzosamente la povera Sofonisba fra i due o tre pezzi che ardevano, che le convenne ardere anch'essa; né abbandonai, da esperto carnefice, le molle, se non se quando la vidi ben avvampante e abbronzita andarsi sparpagliando su per la gola del camminetto.
Questo moto frenetico fu fratello carnale di quello di Madrid contro il povero Elia, ma ne arrossisco assai meno, e mi riuscí d'un qualche utile.
Mi confermai allora nell'opinione ch'io aveva piú volte concepita su quel soggetto di tragedia; ch'egli era sgradito, traditore, appresentante alla prima un falso aspetto tragico, e non lo mantenendo poi saldo; e feci quasi proposito di non vi pensar altrimenti.
Ma i propositi d'autore son come gli sdegni materni.
Mi ricadde due mesi dopo quell'infelice prosa della giustiziata Sofonisba fra mani, e rilettala, trovandovi pure qualche cosa di buono, la ripigliai a verseggiare, abbreviandola assai, e tentando con lo stile di supplire e mascherare le mende inerenti al soggetto.
E benché io sapessi, e sappia, ch'ella non era né sarebbe mai tragedia di prim'ordine, non ebbi con tutto ciò il coraggio di porla da parte, perché era il solo soggetto in cui si potessero opportunamente sviluppare gli altri sensi delle sublimi Cartagine e Roma.
Onde di varie scene di quella debole tragedia, io mi pregio non poco.
Ma la totalità delle mie tragedie parendomi a quell'epoca essersi fatta oramai cosa matura per una stampa generale, mi proposi allora di voler almeno cavar questo frutto dal mio soggiorno che sarei per fissare d'allora in poi in Parigi, di farne una edizione bella, accurata, a bell'agio, senza risparmio nessuno né di spesa né di fatica.
Prima dunque di decidermi per questo o per quello degli stampatori volli fare una prova dei caratteri, e proti, e maneggi tipografici parigini, trattandosi di una lingua forestiera.
Trovandomi sin dall'anno innanzi dettato e corretto il Panegirico a Traiano, lo stampai a quest'effetto, ed essendo cosa breve, in un mesetto fu terminato.
E saviamente feci di tentar quella prova, avendo poi cambiato lo stampatore assai in meglio per tutti i versi.
Onde, accordatomi con Didot Maggiore, uomo intendentissimo ed appassionato dell'arte sua, ed oltre ciò accurato molto, e sufficientemente esperto nella lingua italiana, io cominciai sin dal maggio di quell'anno 1787 a stampare il primo volume delle tragedie.
Ma incominciai per impegnare me e lui, piú che per altro; sapendo benissimo, che dovendo io partire nel giugno per trattenermi in Alsazia fino all'inverno, la stampa in quel frattempo non progredirebbe gran fatto; ancorché si prendessero le misure per farmi avere settimanalmente le prove da correggersi in Alsazia, e rimandarsi in Parigi.
In questo modo io mi legai da me stesso doppiamente a dover ritornare l'inverno in Parigi, cosa alla quale sentiva ripugnanza non poca; volli perciò, che mi vi dovessero costringere parimente e la gloria e l'amore.
Lasciai al Didot il manoscritto delle prose che precedono, e quello delle tre prime tragedie, ch'io stupidamente credei ridotte, limate, e accurate quanto potessero essere; me n'avvidi poi, quando fu posto mano a stamparle, quanto io mi fossi ingannato.
Oltre l'amor della quiete, l'amenità della villa, l'essere quivi piú lungamente con la mia donna, alloggiato sotto lo stesso tetto; l'avervi i miei libri, e gli amati cavalli; tutti questi oggetti erano caldissimi sproni al farmi ritornare con delizia in Alsazia.
Ma un'altra ragione vi si aggiunse anche allora, che me ne dovea duplicare il diletto.
L'amico Caluso mi aveva insperanzito, ch'egli verrebbe in Alsazia a passar quell'estate con noi; ed era questi l'ottimo degli uomini da me conosciuti, e 1'ultimo amico rimastomi dopo la morte del Gori.
Dopo alcune settimane del nostro arrivo in Alsazia, verso il fin di luglio la mia donna ed io partimmo dunque espressamente per andare ad incontrare l'amico fino a Ginevra; indi ce ne ritornammo con esso per tutta la Svizzera sino alla nostra villa presso a Colmar; dove ebbi allora riunite tutte le mie piú care cose.
Il primo discorso ch'io ebbi a tener con l'amico, fu, oltre ogni mia aspettazione, di affari domestici.
Egli avea avuto dalla mia ottima madre un'incombenza assai strana, visto l'età mia, ed occupazioni, e il pensare mio.
Quest'era una proposizione di matrimonio.
Egli me la fece ridendo; ed io pure ridendo gliela negai: e si combinò la risposta da farsi alla mia amorosissima madre, che ci scusasse ambedue.
Ma per dare un saggio dell'affetto e semplice costume di quella rispettabil donna, porrò qui in fondo di pagina(11) la di lei lettera su questo soggetto.
Finito il trattato del matrimonio, ci sfogammo reciprocamente a cuore, l'amico ed io, coi discorsi delle amatissime lettere.
Io mi sentiva veramente necessità di conversare su l'arte, di parlar italiano, e di cose italiane; tutte privazioni che da due anni mi si faceano sentire non poco; e ciò con assai grande mio scapito, nell'arte principalmente del verseggiare.
E certo, se questi ultimi famosi uomini francesi, come Voltaire e Rousseau, avessero dovuto gran parte della loro vita andarsene erranti in diversi paesi in cui la loro lingua fosse stata ignota o negletta, e non avessero neppur trovato con chi parlarla, essi non avrebbero forse avuto la imperturbabilità e la tenace costanza di scrivere per semplice amor dell'arte e per mero sfogo, come faceva io, ed ho fatto poi per tanti anni consecutivi, costretto dalle circostanze di vivere e conversare sempre con barbari; che tale si può francamente denominare tutta l'Europa da noi, quanto alla letteratura italiana; come lo è pur troppo tuttavia, e non poco, una gran parte della stessa Italia, sui nescia.
Che se si vuole anche per gl'italiani scrivere egregiamente, e che si tentino versi in cui spiri l'arte del Petrarca e di Dante, chi oramai in Italia, chi è che veramente e legga ed intenda e gusti e vivamente senta Dante e il Petrarca? Uno in mille, a dir molto.
Con tutto ciò, io immobile nella persuasione del vero e del bello, antepongo d'assai (ed afferro ogni occasione di far tal protesta) di gran lunga antepongo di scrivere in una lingua quasi che morta, e per un popolo morto, e di vedermi anche sepolto prima di morire, allo scrivere in codeste lingue sorde e mute, francese ed inglese, ancorché dai loro cannoni ed eserciti elle si vadano ponendo in moda.
Piuttosto versi italiani (purché ben torniti) i quali rimangano per ora ignorati, non intesi, o scherniti; che non versi francesi mai, od inglesi, o d'altro simil gergo prepotente, quando anche ne dovessi immediatamente esser letto, applaudito, ed ammirato da tutti.
Troppa è la differenza dal suonare la nobile e soave arpa ai propri orecchi, ancorché nessuno ti ascolti, al suonare la vil cornamusa, ancorché un volgo intero di orecchiuti ascoltanti ti faccia pur plauso solenne.
Torno all'amico, con cui di questi e simili sfoghi mi occorreva spesso di fare, il che mi riusciva di sommo sollievo.
Ma poco durò quella mia nuova ed intera felicità, di passare quei beati giorni tra cosí amate e degne persone.
Un accidente occorso all'amico venne a sturbare la nostra quiete.
Cavalcando egli meco fece una caduta, in cui si slogò il pugno.
Da prima credei rotto il braccio, e anche peggio; onde me ne rimescolai fortemente, e tosto al di lui male si aggiunse il mio proprio, ma di gran lunga maggiore.
Mi assalí due giorni dopo una dissenteria ferocissima, che andò sí ostinatamente crescendo, che al decimoquinto giorno, non essendo piú entrato nel mio stomaco altro che acqua gelata, e le pestilenziali evacuazioni oltrepassando il numero di ottanta nelle ventiquattro ore, mi ritrovai ridotto presso che in fine, senza pure aver quasi punto febbre.
La mancanza del calor naturale era tale, che certe fomente di vino aromatizzato che mi facevano su lo stomaco e ventricolo per rendere una qualche attività a quelle parti spossate, ancor che esse fomente fossero bollenti a segno che i famigliari nel maneggiarle vi si pelassero le mani, ed io il corpo nell'applicarmele, con tutto ciò che mi parean sempre pochissimo calde, e d'altro non mi doleva che della loro freddezza.
Non v'era piú vita nel mio individuo, altro che nel capo, il quale indebolito sí, ma chiarissimo rimanevami.
Dopo i quindici giorni il male allentò e adagio adagio retrocedendo, verso il trentesimo giorno le evacuazioni erano però ancora oltre venti nelle ventiquattro ore.
Mi trovai finalmente libero dopo sei settimane, ma ischeletrito e annichilato in tal modo, che per altre quattro settimane in circa, quando mi si dovea rifar il letto, mi levavano di peso per traspormi in un altro finché fossi riportato nel primo.
Io veramente non credei di poterla superare.
Doleami assai di morire, lasciando la mia donna, l'amico, ed appena per cosí dire abbozzata quella gloria, per cui da dieci e piú anni io aveva tanto delirato, e sudato; che io benissimo sentiva che di tutti quegli scritti ch'io lascierei in quel punto, nessuno era fatto e finito come mi parea di poterlo fare e finire, avendone il dovuto tempo.
Mi confortava per altra parte non poco, giacché morir pur dovea, di morire almen libero, e fra le due piú amate persone ch'io m'avessi, di cui mi pareva d'avere e di meritare l'amore e la stima, e di morir finalmente innanzi di aver provato tanti altri mali sí fisici che morali, a cui si va incontro invecchiando.
Io aveva comunicato all'amico tutte le mie intenzioni circa alla stampa già avviata delle tragedie, e le avrebbe fatte continuare egli in mia vece.
Mi sono poi ben convinto in appresso, quando io fui all'atto pratico di quella stampa che durò poi quasi tre anni, che atteso l'assiduo, e lunghissimo, e tediosissimo lavoro che mi vi convenne di farvi sopra le prove, se poco era il fatto sino a quel punto, ove fossi mancato io, quello che lasciava sarebbe veramente stato un nulla, ed ogni fatica precedente a quella dello stampare era intieramente perduta, se quest'ultima non sopravveniva per convalidarla.
Cotanto il colorito e la lima si fanno parte assolutamente integrante d'ogni qualunque poesia.
Piacque al destino, ch'io scampassi per allora, e che le mie tragedie ricevessero da me poi quel compimento ch'io era in grado di dar loro; e di cui forse (s'elle hanno gratitudine) potranno contraccambiarmi col tempo non lasciando totalmente perire il mio nome.
Guarii, come dissi, ma a stento; e rimasi cosí indebolito anche della mente, che tutte le prove delle tre prime tragedie, che successivamente nello spazio di circa quattro mesi in quell'anno mi passarono sotto gli occhi, non ricevettero da me né la decima parte delle emendazioni ch'avrei dovuto farvi.
Il che fu poi in gran parte cagione, che due anni dopo, finito di stamparle tutte, ricominciai da capo a ristampar quelle prime tre; a solo fine di soddisfare all'arte e a me stesso; e forse a me solo; che pochissimi al certo vorranno o sapranno badare alle mutazíoni fattevi quanto allo stile; le quali, ciascuna per sé sono inezie; tutte insieme, son molte e importanti, se non per ora, col tempo.
CAPITOLO DECIMOTTAVO
Soggiorno di tre e piú anni in Parigi.
Stampa di tutte le tragedie.
Stampa nel tempo stesso di molte altre opere in Kehl
Appena io cominciava alquanto a riavermi, che l'amico (anch'egli molto prima guarito della slogatura del pugno), avendo delle occupazioni letterarie in Torino, dove era segretario dell'Accademia delle Scienze, volle far una scorsa a Strasborgo prima di ripartir per l'Italia.
Io, benché ancora infermiccio, per goder piú lungamente di lui ce lo volli accompagnare.
Ed anche la signora ci venne, e fu nell'ottobre.
Si andò fra l'altre cose a vedere la famosa tipografia stabilita in Kehl grandiosamente dal signor di Beaumarchais, coi caratteri di Baskerville comprati da esso, e destinato il tutto alle molte e varie edizioni di tutte l'opere di Voltaire.
La bellezza di quei caratteri, la diligenza degli artefici, e l'opportunità che mi somministrava l'essere io molto conoscente del suddetto Beaumarchais dimorante in Parigi, m'invogliarono di prevalermene per colà stampare tutte l'altre mie opere che tragedie non erano; ed alle quali avrebbero potuto essere d'intoppo le solite stitichezze censorie, le quali esistevano allora anche in Francia, e non picciole.
Sempre ha ripugnato moltissimo all'indole mia di dover subire revisione per poi stampare.
Non già ch'io creda, né voglia, che s'abbia a stampare ogni cosa; ma per me ho adottata nell'intero la legge d'Inghilterra, ed a quella mi attengo; né fo mai nessuno scritto, che non potesse liberissimamente e senza biasimo nessuno dell'autore essere stampato nella beata e veramente sola libera Inghilterra.
Opinioni, quante se ne vuole; individui offesi, nessuni; costumi, rispettati sempre.
Queste sono state, e saran sempre le sole mie leggi; né altre se ne può ragionevolmente ammettere, né rispettare.
Ottenuta io dunque direttamente dal Beaumarchais di Parigi la permissione di prevalermi in Kehl della di lui ammirabile stamperia, con quell'occasione d'esservi capitato io stesso, lasciai a que' suoi ministri il manoscritto delle mie cinque odi, che intitolate avea L'America libera, affine che quest'operetta mi servisse come di saggio.
Ed in fatti ne riuscí cosí bella e corretta la stampa, ch'io poi per due e piú anni consecutivi vi andai successivamente stampando tutte quelle altre opere, che si son viste o che si vedranno.
E le prove me ne venivano settimanalmente spedite a rivedere in Parigi; ed io continuamente andava sempre mutando e rimutando i bei versi interi; a ciò invitandomi, oltre la smisurata voglia del far meglio, anche la singolare compiacenza e docilità di quei proti di Kehl, dei quali non mai abbastanza mi potrei lodare; diversissimi in ciò dai proti, compositori, e torcolieri del Didot in Parigi, che mi hanno sí lungamente fatto fare il sangue verde, e cotanto mi hanno taglieggiato nelle borsa, facendomi a peso d'oro arbitrariamente ricomprare ogni mutazion di parola ch'io facessi; tal che se si suole talvolta nella vita ottenere ricompensa dell'emendarsi, io ho dovuto all'incontro pagare per emendare i miei spropositi, o per barattarli.
Si tornò d'Argentina nella villa di Colmar, e pochi giorni dopo, verso il finir d'ottobre, l'amico se ne partí per Torino, lasciandomi sempre piú desiderio di sé, e della sua dotta e piacevole compagnia.
Si stette ancora tutto il novembre, e parte del decembre in villa, nel qual tempo mi andai rimettendo adagino della grande scossa avuta negli intestini; e cosí mezzo impotente tanto verseggiai alla meglio, o alla peggio, il Bruto secondo che dovea esser l'ultima tragedia ch'io mai farei; e quindi dovendo venir l'ultima a stamparsi, non mi potea mancar poi tempo di limarla e ridurla a bene.
Arrivati in Parigi, dove atteso l'impegno della intrapresa stampa, era indispensabile ch'io mi fissassi a dimora, cercai casa, ed ebbi la sorte di trovarne una molto lieta e tranquilla, posta isolata sul baluardo nuovo nel sobborgo di San-Germano, in cima d'una strada detta del Monte Parnasso luogo di bellissima vista, d'ottima aria, e solitario come in una villa; compagno della villa di Roma ch'io aveva abitata due anni alle Terme.
Si portò con noi a Parigi tutti i cavalli, di cui presso che metà cedei alla signora, sí, pel di lei servizio, che per diminuirne a me la troppa spesa e divagazione.
Cosí collocatomi, a bell'agio potei attendere a quella difficile e noiosa briga dello stampare; occupazione in cui rimasi sepolto per quasi tre anni consecutivi.
Venuto intanto il febbraio del 1788, la mia donna ricevé la nuova della morte del di lei marito seguita in Roma, dove egli da piú di due anni si era ritirato, lasciando Firenze.
E benché questa morte fosse preveduta già da un pezzo, attesi i replicati accidenti che da piú mesi l'aveano percosso; e lasciasse la vedova interamente libera di sé, e non venisse a perdere nel marito un amico; con tutto ciò io fui con mia maraviglia testimonio oculare, ch'ella ne fu non poco compunta, e di dolore certamente non finto, né esagerato; che nessun'arte mai entrava in quella schiettissima ed impareggiabile indole.
E certo quel suo marito, malgrado la molta disparità degli anni, avrebbe trovato in lei un'ottima compagna, ed un'amica se non un'amante donna, soltanto che non l'avesse esacerbata con le continue acerbe e rozze ed ebre maniere.
Io doveva questa testimonianza alla pura verità.
Continuata tutto l'88 la stampa, e vedendomi oramai al 1789 fine del quarto volume, io stesi allora il mio parere su tutte le tragedie, per poi inserirlo in fine dell'edizione.
Mi trovai in quell'anno stesso finito di stampare in Kehl le odi, il dialogo, l'Etruria e le Rime.
Onde ostinato sempre piú nel lavoro, e per vedermene una volta libero, nel susseguente anno continuai con maggior fervore, e verso l'agosto il tutto fu terminato, sí in Parigi i sei volumi delle tragedie, che in Kehl le due prose, del Principe e delle lettere, e della Tirannide, che fu l'ultima cosa ch'io vi stampassi.
Ed essendomi in quell'anno tornato sotto gli occhi il Panegirico prima stampato nell'87, e trovatovi molte piccole cose che potrei emendare, lo volli ristampare; anche per aver tutte le opere egualmente ben stampate.
Con gli stessi caratteri ed opera del Didot lo feci dunque eseguire; e v'aggiunsi l'ode di Parigi sbastigliato, fatta per essermi trovato testimonio oculare del principio di quei torbidi, e tutto il volumetto terminai con una favoluccia, adattata alle correnti peripezie.
E cosí, vuotato il sacco, mi tacqui; nessuna altra mia opera avendo tralasciato di stampare, fuorché la tramelogedia d'Abele, perché in questo nuovo genere facea disegno di eseguirne varie altre; e la traduzion di Sallustio, perché non mi pensava mai di entrare nel disastroso e inestricabile labirinto del traduttore.
CAPITOLO DECIMONONO
Principio dei tumulti di Francia, i quali sturbandomi in piú maniere, di autore mi trasformano in ciarlatore.
Opinione mia sulle cose presenti e future di questo regno.
Dall'aprile dell'anno 1789 in appresso, io era vissuto in molte angustie d'animo, temendo ogni giorno che un qualche di quei tanti tumulti che insorgevano ogni giorno in Parigi dopo la convocazione degli Stati Generali, non mi impedisse di terminare tutte quelle mie edizioni tratte quasi al fine, e che non dovessi dopo tante e sí improbe spese e fatiche affondare alla vista del porto.
Mi affrettava quanto piú poteva; ma cosí non facevano gli artefici della tipografia del Didot, che tutti travestitisi in politici e liberi uomini, le giornate intere si consumavano a leggere gazzette e far leggi, in vece di comporre, correggere, e tirare le dovute stampe.
Credei d'impazzarvi di rimbalzo.
Fu dunque immensa la mia soddisfazione, quando pure arrivò quel giorno, in cui finite, imballate, e spedite sí in Italia che altrove, furono le tanto sudate tragedie.
Ma non fu lunga quella contentezza, perché le cose andando sempre peggio, scemando ogni giorno la sicurezza e la quiete in questa Babilonia, e accrescendosi ogni giorno il dubbio, e i sinistri presagi per l'avvenire, chi ci ha che fare con questi scimiotti, come disgraziatamente siamo nel caso sí la mia donna che io, è costretto di temer sempre, non potendo mai finir bene.
Io dunque oramai da piú d'un anno vo tacitamente vedendo e osservando il progresso di tutti i lagrimevoli effetti della dotta imperizia di questa nazione, che di tutto può sufficientemente chiacchierare, ma nulla può mai condurre a buon esito, perché nulla intende il maneggio degli uomini pratico; come acutamente osservò già e disse il nostro profeta politico, Machiavelli.
Laonde io addolorato profondamente, sí perché vedo continuamente la sacra e sublime causa della libertà in tal modo tradita, scambiata, e posta in discredito da questi semifilosofi; stomacato del vedere ogni giorno tanti mezzi lumi, tanti mezzi delitti, e nulla in somma d'intero se non se l'imperizia d'ogni parte; atterrito finalmente dal vedere la prepotenza militare, e la licenza e insolenza avvocatesca posate stupidamente per basi di libertà; io null'altro oramai desidererei, che di poter uscire per sempre di questo fetente spedale, che riunisce gli incurabili e i pazzi.
E già fuor ne sarei, se la miglior parte di me stesso non vi si trovasse disgraziatamente per lei intralciata dalle sue circostanze.
Istupidito dunque io pure dal perenne dubitare e temere, da quasi un anno che son finite le tragedie, piuttosto vegetando che vivendo, strascino assai male i miei giorni; ed isterilitomi anche non poco il cervello con quasi tre anni di continuo correggere e stampare, a nessuna lodevole occupazione mi so, né posso rivolgere.
Ho intanto ricevuto, e vo ricevendo da molte parti notizia, esservi giunta l'edizione delle mie tragedie; e pare che trovino smercio, e non dispiacciano.
Ma siccome le nuove mi sono date da persone piuttosto amiche mie, o benevole, non me ne lusingo gran fatto.
Ed in fine mi sono proposto fra me e me, di non accettare né lode, né biasimo, se non mi recano e l'uno e l'altro il loro perché; e voglio dei perché luminosi, che ridondino in utile dell'arte mia e di me.
Ma di questi perché pur troppo pochi se ne raccapezza, e nessuno finora me n'è pervenuto.
Onde tutto il rimanente reputo per non accaduto.
Queste cose, benché io le sapessi già prima benissimo, non mi hanno però fatto mai risparmiare né la fatica, né il tempo, per fare il meglio quant'era in me.
Tanto piú lode ne riceveranno forse le mie ossa col tempo, poiché io con tale tristo disinganno innanzi agli occhi, ho pure sí ostinatamente persistito a far bene piú assai che a far presto, non mi piegando a corteggiare mai altri che il vero.
Quanto poi alle sei mie diverse opere stampate in Kehl, non voglio pubblicare per ora altro che le due prime, cioè l'America libera, e la Virtú sconosciuta; riserbando l'altre a tempi men burrascosi, ed in cui non mi possa esser data la vile taccia, che non mi par meritare, di aver io fatto coro con i ribaldi, dicendo quel ch'essi dicono, e che pur mai non fanno, né fare saprebbero né potrebbero.
Con tutto ciò ho stampate quelle opere, perché l'occasione, come dissi, mi v'invitò; e perché son convinto, che chi lascia dei manoscritti non lascia mai libri, nessun libro essendo veramente fatto e compiuto s'egli non è con somma diligenza stampato, riveduto, e limato sotto il torchio, direi, dall'autore medesimo.
Il libro può anche non esser fatto né compito, a dispetto di tutte queste diligenze; pur troppo è cosí; ma non lo può certo essere veramente, senz'esse.
Il non aver dunque per ora altro che fare; l'aver molti tristi presentimenti; e il credermi (lo confesserò ingenuamente) di avere pur fatto qualche cosa in questi quattordici anni; mi hanno determinato di scrivere questa mia vita, alla quale per ora fo punto in Parigi, dove l'ho stesa in età di quarantuno e mesi, e ne termino il presente squarcio, che sarà certo il maggiore, il dí 27 maggio dell'anno 1790.
Né penso di rileggere piú né guardare queste mie ciarle, fin presso agli anni sessanta, se ci arriverò, età in cui avrò certamente terminata la mia carriera letteraria.
Ed allora, con quella freddezza maggiore che portano seco i molti anni, rivedrò poi questo scritto, e vi aggiungerò il conto di quei dieci o quindici anni all'incirca, che avrò forse ancora impiegati in comporre, o applicare.
Se io verrò ad eseguire i due o tre diversi generi in cui fo disegno di provare le mie ultime forze, aggiungerò allora quegli anni in ciò impiegati, a questa quarta epoca della virilità; se no, nel ripigliare questa mia confession generale, incomincierò da quegli anni miei sterili la quinta epoca; della mia vecchiaia e rimbambimento, la quale, se punto avrò senno ancora e giudizio, brevissimamente, siccome cosa inutile sotto ogni aspetto, la scriverò.
Ma se io poi in questo frattempo venissi a morire, che è il piú verisimile; io prego fin d'ora un qualche mio benevolo, nelle cui mani venisse a capitar questo scritto, di farne quell'uso che glie ne parrà meglio.
S'egli lo stamperà tal quale, vi si vedrà, spero, l'impeto della veracità e della fretta ad un tempo; cose che portan seco del pari la semplicità e l'ineleganza nello stile.
Né, per finire la mia vita, quell'amico vi dovrà aggiunger altro di suo, se non se il tempo il luogo ed il modo in cui sarò morto.
E quanto alle disposizioni dell'animo mio in quel punto, l'amico potrà accertare arditamente in mio nome il lettore, che troppo conoscendo questo fallace e vuoto mondo, nessuna altra pena avrò provato lasciandolo, se non se quella di abbandonarvi la donna mia; come altresí fin ch'io vivo, in lei sola e per lei sola vivendo oramai, nessun pensiero veramente mi scuote e atterrisce, fuorché il timore di perderla: né d'altra cosa io supplico il cielo, che di farmi uscir primo di queste mondane miserie.
Ma se poi l'amico qualunque a cui capitasse questo scritto, stimasse bene di arderlo, egli farà anche bene.
Soltanto prego, che se diverso da quel ch'io l'ho scritto gli piacesse di farlo pubblico, egli lo raccorcisca e lo muti pure a suo piacimento quanto all'eleganza e lo stile, ma dei fatti non ne aggiunga nessuni, né in verun modo alteri i già descritti da me.
Se io, nello stendere questa mia vita, non avessi avuto per primo scopo l'impresa non volgarissima di favellar di me con me stesso, di specchiarmi qual sono in gran parte, e di mostrarmi seminudo a quei pochi che mi voleano o vorranno conoscere veramente; avrei saputo verisimilmente anch'io restringere il sugo, se alcun ve n'ha, di questi miei quarantun anni di vita in due o tre pagine al piú, con istudiata brevità ed orgoglioso finto disprezzo di me medesimo taciteggiando.
Ma io allora avrei voluto in ciò piú assai ostentare il mio ingegno, che non disvelare il mio cuore, e costumi.
Siccome dunque all'ingegno mio (o vero o supposto ch'ei sia) ho ritrovato bastante sfogo in tante altre mie opere, in questa mi son compiaciuto di darne uno piú semplice, ma non meno importante, al cuor mio, diffusamente a guisa di vecchio su me medesimo, e di rimbalzo su gli uomini quali soglion mostrarsi in privato, chiacchierando.
Parte seconda
Continuazione della quarta epoca
PROEMIETTO
Avendo riletto circa tredici anni dopo, trovandomi fisso in Firenze, tutto quello ch'io aveva scritto in Parigi concernente la mia vita sino all'età di anni quarantuno, a poco a poco lo andai ricopiando, e un pocolino ripulendo, perché riuscisse chiaro e pianissimo lo stile.
Dopo averlo ricopiato, giacché mi trovava ingolfato nel parlar di me, pensai di continuare a descrivere questi tredici anni, nei quali mi pare anche di aver fatto pur qualche cosa che meriti d'essere saputa.
E siccome gli anni crescono, le forze fisiche e morali scemano, e verisimilmente oramai ho finito di fare, mi lusingo che questa seconda parte, che sarà assai piú breve della prima, sarà anche l'ultima; poiché entrato nella vecchiaia, di cui i miei cinquantacinque anni vicini mi hanno già introdotto nel limitare, e atteso il gran logoro che ho fatto di corpo e di spirito, ancorché io viva dell'altro, nulla oramai facendo, pochissimo mi si presterà da dire.
CAPITOLO VIGESIMO
Finita interamente la prima mandata delle stampe, mi do a tradurre Virgilio e Terenzio; e con qual fine il facessi.
Continuando dunque la quarta epoca, dico che ritrovandomi in Parigi, come io dissi, ozioso e angustiato, ed incapace di crear nulla, benché molte cose mi rimanessero, che avea disegnato di fare; verso il giugno del 1790 cominciai cosí per balocco a tradurre qua e là degli squarci dell'Eneide, quelli che piú mi rapivano; poi vedendo che mi riusciva utilissimo studio, e dilettevole, lo cominciai da capo, per mantenermi anche nell'uso del verso sciolto.
Ma tediandomi di lavorare ogni giorno la stessa cosa, per variare e rompere, e sempre piú imparar bene il latino, pigliai anche a tradurre il Terenzio da capo; aggiuntovi lo scopo di tentare su quel purissimo modello di crearmi un verso comico, per poi scrivere (come da gran tempo disegnava) delle commedie di mio; e comparire anche in quelle con uno stile originale e ben mio, come mi pareva di aver fatto nelle tragedie.
Alternando dunque, un giorno l'Eneide, l'altro il Terenzio, in quell'anno '90, e fino all'aprile del '91, che partii di Parigi, ne ebbi tradotto dell'Eneide i primi quattro libri; e di Terenzio, l'Andria, l'Eunuco, e l'Eautontimoromeno.
Oltre ciò, per sempre piú divagarmi dai funesti pensieri, che mi cagionavano le circostanze, volli disrugginirmi di nuovo la memoria, che nel comporre e stampare avea trasandata affatto, e m'inondai di squarci d'Orazio, Virgilio, Giovenale, e di nuovo dei Dante, Petrarca, Tasso, e Ariosto, talché migliaia e migliaia di versi altrui mi collocai nel cervello.
E queste occupazioni di second'ordine sempre piú mi insterilirono il cervello, e mi tolsero di non far piú nulla del mio.
Talché, di quelle tramelogedie, di cui doveano essere sei almeno, non vi potei mai aggiungere nulla alla prima, l'Abele; e sviato poi da tante cose, perdei il tempo, la gioventú, e il bollore necessario per una tal creazione, e non lo ritrovai poi mai piú.
Sicché in quell'ultimo anno, ch'io stetti allora in Parigi, e cosí poi nei due e piú seguenti altrove, null'altro piú scrissi del mio, fuorché qualche epigrammi e sonetti, per isfogare la mia giustissima ira contro gli schiavi padroni, e dar pascolo alla mia malinconia.
E tentai anche di scrivere un Conte Ugolino, dramma misto, e da unirsi poi anche alle tramelogedie, se l'avessi eseguite.
Ma dopo averlo ideato, lo lasciai, né vi potei piú pensare, non che lo stendessi.
L'Abele in tanto era finito, ma non limato.
Nell'ottobre di quell'anno stesso '90, si fece con la mia donna un viaggietto di quindici giorni nella Normandia sino a Caen, L'Havre, e Roano; bellissima e ricca provincia, ch'io non conosceva; e ne rimasi molto soddisfatto, ed anche un poco sollevato.
Perché quei tre anni fissi di stampa, e di guai continui, mi aveano veramente prosciugato il corpo e l'intelletto.
L'aprile poi vedendo sempre piú imbrogliarsi le cose in Francia, e volendo almeno tentare se piú pace e sicurezza si potrebbe altrove trovare; oltreciò la mia donna spirandosi di vedere l'Inghilterra, quella sola terra un po' libera, e tanto diversa dall'altre tutte, ci determinammo di andarvi.
CAPITOLO VIGESIMOPRIMO
Quarto viaggio in Inghilterra e in Olanda.
Ritorno a Parigi dove ci fissiamo davvero, costrettivi dalle dure circostanze.
Si partí dunque verso il fine d'aprile del '91, ed avendo intenzione di starvi del tempo, ci portammo i nostri cavalli, e si licenziò la casa in Parigi.
Vi si arrivò in pochi giorni, e il paese piacque molto alla mia donna per certi lati, per altri no.
Io invecchiato non poco dalle due prime volte in poi che ci era stato, lo ammirai ancora (ma un poco meno), quanto agli effetti morali del governo, ma me ne spiacque sommamente, e piú che nel terzo viaggio, sí il clima, che il modo corrotto di vivere; sempre a tavola, vegliare fin alle due o tre della mattina; vita in tutto opposta alle lettere, all'ingegno, e alla salute.
Passata dunque la novità degli oggetti per la mia donna, ed io tormentatovi molto dalla gotta vagante, che in quella benedetta isola è veramente indigena, presto ci tediammo dí essere in Inghilterra.
Succedé nel giugno di quell'anno la famosa fuga del re di Francia, che ripreso in Varennes, come ciascun seppe, fu ricondotto piú che mai prigioniero in Parigi.
Quest'avvenimento abbuiò sempre piú gli affari di Francia; e noi vi ci trovavamo impicciatissimi per la parte pecuniaria, avendo l'uno e l'altro i due terzi delle nostre entrate in Francia, dove la moneta sparita, e datovi luogo alla carta ideale, e sfiduciata ogni dí piú, settimanalmente uno si vedeva scemare in mano il suo avere, che prima d'un terzo, poi mezzo, poi due terzi, andava di carriera verso il bel nulla.
Contristati ambedue e costretti da questa necessità irrimediabile, ci determinammo di obbedirvi, e di ritornare in Francia, dove solo con la nostra cartaccia potevamo campare, per allora; ma con la trista perspettiva del peggio.
Nell'agosto dunque, prima di lasciar l'Inghilterra, si fece un giro per l'isola a Bath, Bristol, e Oxford, e tornati a Londra, pochi giorni dopo ci rimbarcammo a Douvres.
Quivi mi accadde un accidente veramente di romanzo, che brevemente narrerò.
Nel mio terzo viaggio in Inghilterra nell'83 e '84 non aveva punto piú saputo né cercato nulla di quella famosa signora, che nel mio secondo viaggio mi avea fatto pericolare per tanti versi.
Solamente sentii dire ch'ella non abitava piú Londra, che il marito, da cui s'era divorziata, era morto, e che si credeva ne avesse sposato un altro, oscuro ed ignoto.
In questo quarto viaggio, nei quattro e piú mesi ch'io era stato a Londra non ne avea mai sentito far parola né cercatone notizia, e non sapeva neppure s'ella fosse ancor viva, o no.
Nell'atto di imbarcarmi a Douvres, precedendo io la donna mia di forse un quarto d'ora alla nave, per vedere se il tutto era in ordine, ecco, che nell'atto, che dal molo stava per entrare nella nave, alzati gli occhi alla spiaggia dove era un certo numero di persone, la prima che i miei occhi incontrano, e distinguono benissimo per la molta prossimità, si è quella signora; ancora bellissima, e quasi nulla mutata da quella ch'io l'avea lasciata vent'anni prima appunto nel 1771.
Credei a prima di sognare, guardai meglio, e un sorriso ch'ella mi schiuse guardandomi, mi certificò della cosa.
Non posso esprimere tutti i moti, e diversi affetti contrari che mi cagionò questa vista.
Tuttavia non le dissi parola, entrai nella nave, né piú ne uscii; e nella nave aspettai la mia donna, che un quarto d'ora dopo giuntavi, si salpò.
Essa mi disse, che dei signori, che l'accompagnarono alla nave, gli avean indicata quella signora; e nominategliela, e aggiuntovi un compendiuccio della di lei vita passata e presente.
Io le raccontai come mi era occorsa agli occhi, e come andò il fatto.
Tra noi non v'era mai né finzione, né diffidenza, né disistima, né querele.
Si arrivò a Calais; di dove io molto colpito di quella vista cosí inaspettata, le volli scrivere per isfogo del cuore, e mandai la mia lettera al banchiere di Douvres, che glie la rimettesse in proprie mani, e me ne trasmettesse poi la risposta a Bruxelles, dove sarei stato fra pochi giorni.
La mia lettera, di cui mi spiace di non aver serbato copia, era certamente piena d'affetti; non già d'amore, ma di una vera e profonda commozione di vederla ancora menare una vita errante e sí poco decorosa al suo stato e nascita, e il dolore, ch'io ne sentiva tanto piú, pensando di esserne io stato, ancorché innocentemente, o la cagione o il pretesto.
Che senza lo scandalo succeduto per causa mia, forse avrebbe potuto occultare o tutto o gran parte le sue dissolutezze, e cogli anni poi emendarsene.
Ritrovai poi in Brusselles circa quattro settimane dopo la di lei risposta, che fedelmente trascrivo qui in fondo di pagina(12), per dare un'idea del di lei nuovo, ed ostinato mal inclinato carattere, che in quel grado ella è cosa assai rara, massime nel bel sesso.
Ma tutto serve al grande studio della specie bizzarra degli uomini.
Intanto dunque noi imbarcati per Francia, sbarcati a Calais, prima di rimprigionarci in Parigi, pensammo di fare un giro in Olanda, perché la donna mia vedesse quel raro monumento d'industria, occasione, che forse non se le presenterebbe poi piú.
Si andò dunque per la spiaggia fino a Bruges e Ostenda, di là per Anversa e Rotterdam, Amsterdamo, la Haia, e la Nort-Hollanda, in circa tre settimane, e in fin di settembre fummo di ritorno in Brusselles, dove la signora avendovi le sorelle e la madre, ci si stette qualche settimana; e finalmente dentro l'ottobre, verso il fine, fummo rientrati nella cloaca massima, dove le dure nostre circostanze ci ritraevano malgrado nostro; e ti costrinsero a pensare seriamente di fissarvici la nostra permanenza.
CAPITOLO VIGESIMOSECONDO
Fuga di Parigi, donde per le Fiandre e tutta la Germania tornati in Italia ci fissiamo in Firenze.
Impiegati, o perduti circa due mesi in cercare, ed ammobiliare una nuova casa, nel principio del '92 ci tornammo ad abitare; ed era bellissima e comodissima.
Si sperava ogni giorno, che verrebbe quello di un qualche sistema di cose soffribile; ma piú spesso ancora si disperava che omai sorgesse un tal giorno.
In questo stato di titubazione, la mia donna ed io (come anche tutti, quanti n'erano allora in Parigi ed in Francia, o ci aveano che fare pe' loro interessi), andavamo strascinando il tempo.
Io fin da due anni e piú innanzi, avea fatto venir di Roma tutti i miei libri lasciativi nell'83, e da allora in poi li avea anche molto accresciuti sí in Parigi, che in quest'ultimo viaggio di Inghilterra, e d'Olanda.
Onde per questa parte poco mi mancava ad avere ampiamente tutti i libri, che mi potessero esser utili o necessari nella ristretta mia sfera letteraria.
Onde tra i libri, e la cara compagna, nessuna consolazione domestica mi mancava; solamente mancavaci la speranza viva, e la verisimiglianza che ciò potesse durare.
Questo pensiero mi sturbava da ogni occupazione, e mi tiravo innanzi per traduttore nel Virgilio e Terenzio, non potendo far altro.
Frattanto, né in quest'ultimo, né all'anteriore mio soggiorno in Parigi io non volli mai né trattare, né conoscere pur di vista nessuno di quei tanti facitori di falsa libertà, per cui mi sentiva la piú invincibile ripugnanza, e ne aveva il piú alto disprezzo.
Quindi anche sino a questo punto, in cui scrivo da piú di quattordici anni che dura questa tragica farsa, io mi posso gloriare di esser vergine di lingua di orecchi, e d'occhi perfino, non avendo mai né visto, né udito, né parlato con qualunque di codesti schiavi dominanti francesi, né con nessuno dei loro schiavi serventi.
Nel marzo di quell'anno ricevei lettere di mia madre, che furon l'ultime: ella vi esprimeva con caldo e cristiano affetto molta sollecitudine di vedermi, diceva, "in paese, dove sono tanti torbidi; dove non è piú libero l'esercizio della cattolica religione, e dove tutti tremano sempre, ed aspettano continui disordini e disgrazie".
Pur troppo bene diceva, e presto si avverò; ma quando mi ravviai verso l'Italia, la degnissima e veneranda matrona non esisteva, piú.
Passò di questa vita il di 23 aprile 1792, in età di anni settanta compiuti.
Erasi frattanto rotta la guerra coll'imperatore, che poi divenne generale e funesta.
Venuto il giugno, in cui si tentò già di abbattere intieramente il nome del re, che altro piú non rimaneva; la congiura di quel giorno 20 giugno essendo andata fallita, le cose strascinarono ancora malamente sino al famoso dieci d'agosto, in cui la cosa scoppiò come ognuno sa.
Accaduto quest'avvenimento, io non indugiai piú neppure un giorno, e il mio primo ed unico pensiero essendo di togliere da ogni pericolo la mia donna, già dal dí 12 feci in fretta in fretta tutti i preparativi per la nostra partenza.
Rimaneva la somma difficoltà dell'ottenere passaporti per uscir di Parigi, e del regno.
Tanto c'industriammo in quei due o tre giorni, che il dí 15, o 16, già gli avevamo ottenuti come forestieri, prima dai ministri di Venezia io, e di Danimarca la signora, che erano quasi che i soli ministri, esteri rimasti presso quel simulacro di re.
Poi con molto piú stento si ottenne dalla sezione nostra comunitativa detta du Montblanc degli altri passaporti, uno per ciascheduno individuo, sí per noi due, che ogni servitore, e cameriera, con la pittura di ciascuno, di statura, pelo, età, sesso, e che so io.
Muniti cosí di tutte queste schiavesche patenti, avevamo fissato la partenza nostra pel lunedí 20 agosto; ma un giusto presentimento, trovandoci allestiti, mi fece anticipare, e si parti il dí 18, sabato, nel dopo pranzo.
Appena giunti alla Barrière Blanche, che era la nostra uscita la piú prossima per pigliar la via di San Dionigi per Calais, dove ci avviavamo per uscire al piú presto di quell'infelice paese; vi ritrovammo tre o quattro soli soldati di guardie nazionali, con un uffiziale, che visti i nostri passaporti, si disponeva ad aprirci il cancello di quell'immensa prigione, e lasciarci ire a buon viaggio.
Ma v'era accanto alla Barriera una bettolaccia, di dove sbucarono fuori ad un tratto una trentina forse di manigoldi della plebe, scamisciati, ubriachi, e furiosi.
Costoro, viste due carrozze che tante n'avevamo, molto cariche di bauli, e imperiali, ed una comitiva di due donne di servizio, e tre uomini, gridarono che tutti i ricchi se ne voleano fuggir di Parigi, e portar via tutti i loro tesori, e lasciarli essi nella miseria e nei guai.
Quindi ad altercare quelle poche e tristi guardie con quei molti e tristi birbi, esse per farci uscire, questi per ritenerci.
Ed io balzai di carrozza fra quelle turbe, munito di tutti quei sette passaporti, ad altercare, e gridare, e schiamazzar piú di loro; mezzo col quale sempre si vien a capo dei francesi.
Ad uno ad uno si leggevano, e facevano leggere da chi di quelli legger sapeva, le descrizioni delle nostre rispettive figure.
Io pieno di stizza e furore, non conoscendo in quel punto, o per passione sprezzando l'immenso pericolo, che ci soprastava, fino a tre volte ripresi in mano il mio passaporto, e replicai ad alta voce: "Vedete, sentite; Alfieri è il mio nome; italiano e non francese; grande, magro, sbiancato; capelli rossi, son io quello, guardatemi; ho il passaporto; l'abbiamo avuto in regola da chi lo può dare; e vogliamo passare, e passeremo per Dio".
Durò piú di mezz'ora questa piazzata, mostrai buon contegno, e quello ci salvò.
Si era frattanto ammassata piú gente intorno alle due carrozze, e molti gridavano: "Diamogli il fuoco a codesti legni".
Altri: "Pigliamoli a sassate".
Altri: "Questi fuggono; son dei nobili e ricchi, portiamoli indietro al Palazzo della Città, che se ne faccia giustizia".
Ma insomma il debole aiuto delle quattro guardie nazionali, che tanto qualcosa diceano per noi, ed il mio molto schiamazzare, e con voce di banditore replicare e mostrare i passaporti, e piú di tutto la mezz'ora e piú di tempo, in cui quei scimiotigri si stancarono di contrastare, rallentò l'insistenza loro; e le guardie accennatomi di salire in carrozza, dove avea lasciato la signora, si può credere in quale stato, io rientratovi, rimontati i postiglioni a cavallo si aprí il cancello, e di corsa si uscí, accompagnati da fischiate, insulti e maledizioni di codesta genia.
E buon per noi che non prevalse di essere ricondotti al Palazzo di Città, che arrivando cosí due carrozze in pompa stracariche, con la taccia di fuggitivi, in mezzo a quella plebaglia si rischiava molto; e saliti poi innanzi ai birbi della Municipalità, si era certi di non poter piú partire, d'andare anzi prigioni, dove se ci trovavano nelle carceri il dí 2 settembre, cioè quindici giorni dopo, ci era fatta la festa insieme con tanti altri galantuomini che crudelmente vi furono trucidati.
Sfuggiti di un tale inferno, in due giorni e mezzo arrivammo a Calais, mostrando forse quaranta e piú volte i nostri passaporti; ed abbiamo saputo poi che noi eramo stati i primi forestieri usciti di Parigi, e del regno dopo la catastrofe del 10 agosto.
Ad ogni Municipalità per istrada dove ci conveniva andare e mostrare i nostri passaporti, quei che li leggevano, rimanevano stupefatti ed attoniti alla prima occhiata che ci buttavan sopra, essendo quelli stampati, e cassatovi il nome del re.
Poco, e male erano informati di quel che fosse accaduto in Parigi, e tutti tremavano.
Sono questi gli auspici, sotto cui finalmente uscii della Francia, con la speranza, ed il proponimento di non capitarvi piú mai.
Giunti a Calais, dove non ci fecero difficoltà di proseguire sino alle frontiere della Fiandra per Gravelina, preferimmo di non c'imbarcare, e di renderci subito a Brusselles.
Ci eramo diretti a Calais, perché non essendo ancora guerra cogli inglesi, si pensò che si potea piú facilmente andare in Inghilterra, che in Fiandra dove la guerra si facea vivamente.
Giunti a Brusselles, la signora volle rimettersi un poco dalle paure sofferte con lo stare un mesetto in villa colla sorella, e il degnissimo suo cognato.
Là poi si ricevettero lettere di Parigi dalla nostra gente lasciatavi, che quello stesso lunedí che avevamo destinato al partire, 20 agosto, ma che io fortunatamente avea anticipato due giorni, era venuta in corpo quella nostra stessa sezione che ci avea dati i passaporti (vedi stupidità, e pazzia), per arrestare la signora e condurla in prigione.
Già si sa, perché era nobile, ricca, ed illibata.
A me, che sempre ho valuto meno di essa, non faceano per allora quell'onore.
Ma insomma, non ci ritrovando aveano confiscato i nostri cavalli, mobili, libri, e ogni cosa.
Poi sequestrate le entrate, e dichiaratici amendue emigrati.
E cosí pure poi ci fu scritta la catastrofe e gli orrori ecc.
seguiti in Parigi il di 2 settembre, e si ringraziò e benedí la Provvidenza che ce n'avea scampati.
Visto poi sempre piú oscurarsi il cielo di quel paese, e nata nel terrore e nel sangue quella sedicente repubblica, noi saviamente ascrivendo a guadagno tutto quello che ci potea rimanere altrove, ci posimo in via per l'Italia il dí 1° ottobre; e per Aquisgrana, Francfort, Augusta ed Inspruch, venuti all'Alpi e lietamente varcatele, ci parve di rinascere il dí che ci ritrovammo nel bel paese qui dove il sí suona.
Il piacere di esser fuori di carcere, e di ricalcare con la mia donna quelle stesse vie, che piú volte avea fatte per gire a trovarla; la soddisfazione di potere liberamente godere la sua santa compagnia, e sotto l'ombra sua di potere ripigliare i miei cari studi, mi tranquillizzarono, e serenarono a segno, che da Augusta sino in Toscana mi si riaprí la fonte delle rime, e ne venni seminando e raccogliendo in gran copia.
Si arrivò finalmente il dí 3 novembre in Firenze, di donde non ci siamo piú mossi, e dove ritrovai il vivo tesoro della lingua, che non poco mi compensò delle tante perdite d'ogni sorte che dovei sopportare in Francia.
CAPITOLO VIGESIMOTERZO
A poco a poco mi vo rimettendo allo studio.
Finisco le traduzioni.
Ricomincio a scrivere qualche coserella di mio, trovo casa piacentissima in Firenze; e mi do al recitare.
Appena giunto in Firenze, ancorché per quasi un anno non vi si potesse trovar casa che ci convenisse, tuttavia il sentir di nuovo parlare quella sí bella, e a me sí preziosa lingua, il trovar gente qua e là che mi andava parlando delle mie tragedie, il vederle qua e là (benché male), pure frequentemente recitate, mi ridestò qualche spirito letterario, che nei due ultimi decorsi anni mi si era presso che spento nel core.
La prima coserella, che mi venne ideata e fatta di mio (dopo quasi tre anni che non avea piú composto nulla fuorché qualche rime) fu l'Apologia del re Luigi XVI, che scrissi nel decembre di quell'anno.
Successivamente poi riprese caldamente, le due traduzioni che sempre camminavan di fronte, il Terenzio e l'Eneide, nel seguente anno '93 le portai al fine, non però limate, né perfette.
Ma il Sallustio, che era stata quasi che la sola cosa a cui un pochino avessi atteso nel viaggio d'Inghilterra e d'Olanda (oltre tutte le opere di Cicerone, che avea caldamente lette, e rilette), e che avea moltissimo corretto e limato, lo volli anche ricopiare intero in quell'anno '93, e cosí mi credei avergli dato l'ultimo pulimento.
Stesi anche una prosa storico-satirica su gli affari in Francia, compendiatamente, la quale poi, ritrovatomi un diluvio di composizioni poetiche, sonetti, ed epigrammi su quelle risibili e dolorose vertenze, ed a tutti que' membri sparsi volendo dar corpo e sussistenza, volli che quella prosa servisse come di prefazione all'opera che intitolerei Il misogallo; e verrebbe essa a dare quasi ragione dell'opera.
Ravviatomi cosí a poco a poco allo studio, ancorché forte spennacchiati nell'avere, sí la mia donna che io, tuttavia rimanendoci pur da campare decentemente; ed amandola io sempre piú, e quanto piú bersagliata dalla sorte, tanto piú riuscendomi ella una cosa e carissima e sacra, il mio animo si andava acquetando, e piú ardente che mai l'amor del sapere mi ribolliva nella mente.
Ma allo studio vero quale avrei voluto intraprendere, mi mancavano i libri, avendo definitivamente perduti tutti i miei in Parigi, né mai piú pure richiestili a chi che si fosse, e salvatine soli un 150 volumi circa di picciole edizioncelle di classici che portai meco.
Quanto poi al comporre, benché io avessi il mio piano ideato per altre cinque almeno tramelogedie, sorelle dell'Abele, attese le passate ed anche le presenti angustie dell'animo, mi si era spento il bollore giovenile inventivo, la fantasia accasciata, e gli anni preziosi ultimi della gioventú spuntati ed ottusi, direi, dalla stampa ed i guai che per piú di cinque anni mi avean sepolto l'animo, non me la sentivo piú; ed in fatti dovei abbandonarne il pensiero, non mi trovando piú il robusto furore necessario ad un tale pazzo genere.
Smessa dunque quell'idea, che pur tanto mi era stata cara, mi volli rivolgere alle satire, di cui fatto avea sol la prima che poi serve all'altre di prologo; bastantemente mi era andato esercitando ín quest'arte negli squarci diversi del Misogallo, onde non disperava di riuscirvi; e ne scrissi la seconda, ed in parte la terza; ma non era ancora abbastanza raccolto in me stesso; male alloggiato, senza libri, non avea quasi il cuore a nulla.
Questo mi fece entrare in un nuovo perditempo, quello del recitare.
Trovati in Firenze alcuni giovani, e una signora, che mostravano genio e capacità da ciò, si imparò il Saul, e si recitò in casa privata, e senza palco, a ristrettissima udienza, con molto incontro, nella primavera del '93.
In fine poi di quell'anno, si ritrovò presso il Ponte Santa Trinità una casa graziosissima benché piccola, posta al Lung'Arno di mezzogiorno, casa dei Gianfigliazzi, dove tornammo in novembre, e dove ancora mi trovo, e verisimilmente, se non mi saetta altrove la sorte, ci morrò.
L'aria, la vista, ed il comodo di questa casa mi restituí gran parte delle mie facoltà intellettuali e creative, meno le tramelogedie, cui non mi fu piú possibile mai d'innalzarmi.
Tuttavia, avviatomi l'anno prima al balocco del recitare, volli ancora perdere in questa primavera del '94 altri tre buoni mesi; e si recitò da capo in casa mia, il Saul, di cui io faceva la parte; poi il Bruto primo, di cui pure faceva la parte.
Tutti dicevano, e pareva anche a me di andar facendo dei progressi non piccoli in quell'arte difficilissima del recitare; e se avessi avuto piú gioventú, e nessun altro pensiero, mi parea di sentire in me crescere ogni volta ch'io recitava, la capacità, e l'ardire, e la riflessione e la gradazione dei tuoni, e la importantissima varietà continua dei presto e adagio, piano e forte, pacato e risentito, che alternate sempre a seconda delle parole vengono a colorir la parola, e scolpire direi il personaggio, ed incidere in bronzo le cose ch'ei dice.
Parimente la compagnia addestrata al mio modo migliorava di giorno in giorno; e tenni allora per cosa piú che certa, che se io avessi avuto danari tempo e salute da sprecare, avrei in tre o quattr'anni potuto formare una compagnia di tragici, se non ottima, almeno assai e del tutto diversa da quelle che in Italia si van chiamando tali, e ben diretta su la via del vero e dell'ottimo.
Questo perditempo mi tenne ancora molto indietro nelle mie occupazioni per tutto quell'anno, e quasi anche il seguente, in cui poi feci la mia ultima strionata, recitando in casa mia il Filippo, in cui feci alternativamente le due cosí diverse parti di Filippo, e di Carlo; e poi da capo il Saul, che era il mio personaggio piú caro, perché in esso vi è di tutto, di tutto assolutamente.
Ed essendovi in Pisa in casa particolare di signori una altra compagnia di dilettanti, che vi recitavano pure il Saul, io invitato da essi di andarvi per la luminara, ebbi la pueril vanagloria di andarvi, e là recitai per una sola volta, e per l'ultima la mia diletta parte del Saul, e là rimasi, quanto al teatro, morto da re.
Intanto, nel decorso di quei due e piú anni ch'io era già stato in Toscana, mi era dato a poco a poco a ricomprar libri, e riacquistati quasi che tutti i libri di lingua toscana che già aveva avuti, e riacquistati ed accresciuti anche di molto tutti i classici latini, vi aggiunsi anche, non so allora perché, tutti i classici greci di edizioni ottime greco-latine tanto per averli, e saperne se non altro i nomi.
CAPITOLO VIGESIMOQUARTO
La curiosità e la vergogna mi spingono a leggere Omero, ed i tragici greci nelle traduzioni letterali.
Proseguimento tepido delle satire, ed altre cosarelle.
Meglio tardi che mai.
Trovandomi dunque in età di anni quarantasei ben suonati, ed aver bene o male da venti esercitata e professata l'arte di poeta lirico e tragico, e non aver pure mai letto né i tragici greci, né Omero, né Pindaro, né nulla insomma, una certa vergogna mi assalí, e nello stesso tempo anche una lodevole curiosità di vedere un po' cosa aveano detto quei padri dell'arte.
E tanto piú cedei volentieri a questa curiosità e vergogna, quanto da piú e piú anni, mediante i viaggi, i cavalli, la stampa, la lima, le angustie d'animo, e il tradurre, mi trovava rinminchionito a tal segno, che avrei ben potuto oramai aspirare all'erudito, che non è poi insomma altro che buona memoria di suo, e roba d'altri.
Ma disgraziatamente anche la memoria, ch'io avea già avuta ottima, mi si era assai indebolita.
Con tutto ciò per isfuggire l'ozio, cavarmi dallo strione ed uscire un pocolin piú dall'asino, mi accinsi all'impresa.
E successivamente Omero, Esiodo, i tre tragici, Aristofane, ed Anacreonte lessi ad oncia ad oncia studiandoli nelle traduzioni letterali latine, che sogliono porsi a colonna col testo.
Quanto a Pindaro, vidi ch'egli era tempo perduto; perché le alzate liriche tradotte letteralmente troppo bestial cosa riuscivano; e non potendolo leggere nel testo, lo lasciai stare.
Cosí in questo assiduo studio ingratissimo, e di poco utile oramai per me, che spossato non producea piú quasi nulla, c'impiegai quasi che un anno e mezzo.
Alcune rime intanto andava anche scrivendo, e le satire crebbero in tutto il '96, fino a sette di numero.
Quell'anno '96 funesto all'Italia per la finalmente eseguita invasione dei francesi che da tre anni tentavano, mi abbuiò sempre piú l'intelletto, vedendomi rombar sovra il capo la miseria e la servitú.
Il Piemonte straziato, già già mi vedea andare in fumo l'ultima mia sussistenza rimastami.
Tuttavia preparato a tutto, e ben risoluto in me stesso di non accattar mai né servire, tutto il di meno di queste due cose lo sopportava con forte animo, e tanto piú mi ostinava allo studio, come sola degna diversione a sí sozzi e noiosi fastidi.
Nel Misogallo, che sempre andava crescendo, e che anche ornai d'altre prose, io aveva riposto la mia vendetta e quella della mia Italia; e porto tuttavia ferma speranza, che quel libricciuolo col tempo gioverà all'Italia, e nuocerà alla Francia non poco.
Sogni e ridicolezze d'autore, finché non hanno effetto; profezie di inspirato vate; allorché poi l'ottengono.
CAPITOLO VIGESIMOQUINTO
Per qual ragione, in qual modo, e con quale scopo mi risolvessi finalmente a studiare da radice seriamente da me stesso la lingua greca.
Fin dall'anno 1778, quando si trovava meco in Firenze il carissimo amico Caluso, io cosí, per ozio, e curiosità leggierissima, mi era fatto scrivere da lui sur un foglio volante il semplice alfabeto greco, maiuscolo, e minuscolo, e cosí alla peggio imparato a conoscere le lettere, ed anche a nominarle, e non altro.
Non ci avea poi badato mai piú per tanti anni.
Ora due anni addietro, quando mi posi a leggere le traduzioni letterali, come dissi, ripescai quel mio alfabeto fra i fogli e trovatolo, mi rimisi a raffigurar quelle lettere, e dirne il nome; col solo pensiero di gettare di quando in quando gli occhi, su la colonna del greco, e vedere se mi veniva fatto di raccapezzare il suono di una qualche parola, di quelle che per essere composte e straordinarie, dalla traduzione letterale mi destavano curiosità del testo.
Ed io veramente guardava di tempo in tempo quei caratteri posti a colonna, con occhio bieco, e fremente, appunto come la volpe della favola guardava i proibiti grappoli invano sospirati.
Mi si aggiungeva un fortissimo ostacolo fisico; che le mie pupille non volean saper niente di quel maledetto carattere; e foss'egli grande o piccolo, sciolto o legato, mi venivano le traveggole tosto ch'io lo fissava, e con molta pena compitando ne portava via una parola per volta, delle brevi; ma un verso intero non lo potea né leggere, né fissare, né pronunziare, né molto meno ritenerne materialmente la romba a memoria.
Oltre ciò, per natura nemico e non dotato di nessuna facilità per le lingue (avendo tentato due volte e tre l'inglese, né mai venutone a capo; ed ultimamente in Parigi nel '90 prima d'ire in Inghilterra la quarta volta; e tradussi allora di Pope il Windsor e cominciai il Saggio su l'uomo) non assuefatto, e oramai incapace di applicazione servile di occhio e di mente grammaticale; venuto a tale età senza aver mai saputa una grammatica qualunque, neppur l'italiana, nella quale non errava forse oramai, ma per abitudine del leggere non per poter dare né ragione né nomi dell'operato; con questo bel corredo d'impedimenti fisici e morali, tediato dal leggere quelle traduzioni, presi con me stesso l'impegno di voler tentare di superarli da me; ma non ne volli parlare con chi che sia, neppure con la mia donna, che è tutto dire.
Consumati avendo dunque già due anni su i confini della Grecia, senza mai essermivi potuto introdurre altro che colla coda dell'occhio, mi irritai, e la volli vincere.
Comprate dunque grammatiche a iosa, prima nelle greco-latine, poi nelle greche sole, per far due studi in uno, intendendo e non intendendo, ripetendo tutti i giorni il tupto, e i verbi circonflessi, e i verbi in mi (il che presto svelò il mio arcano alla signora, che vedendomi sempre susurrar fra le labbra, volle finalmente sapere, e seppe quel ch'era); ostinandomi sempre piú, sforzando e gli occhi, e la mente, e la lingua, pervenni in fine dell'anno 1797 a poter fissare qualunque pagina di greco, qualunque carattere prosa o verso, senza che gli occhi mi traballassero piú; ad intendere sempre benissimo il testo, facendo il contrario su la colonna latina, di quel che avea fatto dianzi sul greco, cioè gittando rapidamente l'occhio su la parola latina corrispondente alla greca, se non l'avea mai vista prima, o se me ne fossi scordato; e finalmente a leggere ad alta voce speditamente, con pronunzia sufficiente, rigorosa per gli spiriti, e accenti, e dittonghi come sta scritto, e non come stupidamente pronunziano i greci moderni, che si son fatti senza avvedersene un alfabeto con cinque iota, talché quel loro greco è un continuo iotacismo, un nitrir di cavalli piú che un parlare del piú armonico popolo che già vi fosse.
Ed aveva vinto questa difficoltà del leggere, e pronunziare, col mettermi in gola, ed abbaiare ad alta voce, oltre la lezione giornaliera di quel classico che studiava, anche ad altre ore, per due ore continue, ma senza intendere quasi che nulla, attesa la rapidità della lettura, e la romba della sonante alta pronunzia, tutto Erodoto, due volte Tucidide con lo scoliaste suo, Senofonte, tutti gli oratori minori, e due volte il Proclo sovra il Timeo di Platone, non per altra ragione, fuorché per essere di stampa piú scabra a leggersi, piena di abbreviature.
Né una tale improba fatica mi debilitò come avrei creduto e temuto, l'intelletto.
Che anzi ella mi fece per cosí dire, risorgere dal letargo di tanti anni precedenti.
In quell'anno '97, portai le satire al numero di diciassette come sono.
Feci una nuova rassegna delle molte e troppe rime, che fatte ricopiare limai.
E finalmente, cominciatomi ad invaghire del greco quanto piú mi pareva d'andarlo intendicchiando, cominciai anche a tradurre; prima l'Alceste d'Euripide, poi il Filottete di Sofocle, poi i Persiani di Eschilo, ed in ultimo per avere, o dare un saggio di tutti, le Rane di Aristofane.
Né trascurai il latino, perché del greco, che anzi in quell'anno stesso '97 lessi e studiai Lucrezio e Plauto, e lessi il Terenzio, il quale per una bizzarra combinazione io mi trovava aver tradotto tutte le sei commedie a minuto, senza però averne mai letta una intera.
Onde se sarà poi vero ch'io l'abbia tradotto, potrò barzellettare col vero, dicendo d'averlo tradotto, prima d'averlo letto, o senza averlo letto.
Imparai anche oltre ciò i metri diversi d'Orazio, spinto dalla vergogna di averlo letto, studiato, e saputo direi a memoria, senza saper nulla de' suoi metri; e cosí parimente presi una sufficiente idea dei metri greci nei cori, e di quei di Pindaro, e d'Anacreonte.
Insomma in quell'anno '97, mi raccorcii le orecchie di un buon palmo almeno ciascuna; né altro scopo m'era prefisso da tanta fatica, che di scuriosirmi, disasinirmi, e tormi il tedio dei pensieri dei Galli, cioè disceltizzarmi.
CAPITOLO VIGESIMOSESTO
Frutto da non aspettarsi dallo studio serotino della lingua greca: io scrivo (spergiuro per l'ultima volta ad Apollo) l'Alceste seconda.
Non aspettando dunque, né desiderando altro frutto che i sopraddetti, ecco, che il buon padre Apollo me ne volle egli spontaneamente pure accordar uno, e non piccolo, per quanto mi pare.
Fin dal '96 quando stava leggendo, com'io dissi, le traduzioni letterali, avendo già letto tutto Omero, ed Eschilo, e Sofocle, e cinque tragedie di Euripide, giunto finalmente all'Alceste, di cui non avea avuta mai notizia nessuna, fui sí colpito, e intenerito, e avvampato dai tanti affetti di quel sublime soggetto, che dopo averla ben letta, scrissi su un fogliolino, che serbo, le seguenti parole.
"Firenze 18 gennaio 1796.
Se io non avessi giurato a me stesso di non piú mai comporre tragedie, la lettura di questa Alceste di Euripide mi ha talmente toccato e infiammato che cosí su due piedi mi accingerei caldo caldo a distendere la sceneggiatura d'una nuova Alceste, in cui mi prevarrei di tutto il buono del greco, accrescendolo se sapessi, e scarterei tutto il risibile che non è poco nel testo.
E da prima cosí creerei i personaggi diminuendoli." E vi aggiunsi i nomi dei personaggi quali poi vi ho posto; né piú pensai a quel foglio.
E proseguii tutte l'altre di Euripide, di cui non piú che le precedenti, nessuna mi destò quasi che niun affetto.
Tornando poi in volta l'Euripide da rileggersi, come praticava di leggere ogni cosa due volte almeno, venuta l'Alceste, stesso effetto, stesso trasporto, stesso desiderio, e nel settembre dell'anno stesso '96 ne stesi la sceneggiatura, coll'intenzione di non farla mai.
Ma intanto aveva intrapresa a tradurre la prima di Euripide, ed in tutto il '97 l'ebbi condotta a termine: ma non intendendo allora, come dissi, punto il greco, l'ebbi per allora tradotta dal latino.
Tuttavia quell'aver tanto che fare con codesta Alceste nel tradurla, sempre di nuovo mi andava accendendo di farla di mio; finalmente venne quel giorno, nel maggio '98, in cui mi si accese talmente la fantasia su questo soggetto che giunto a casa dalla passeggiata, mi posi a stenderla, e scrissi d'un fiato il primo atto, e ci scrissi in margine: "Steso con furore maniaco, e lagrime molte"; e nei giorni susseguenti stesi con eguale impeto gli altri quattr'atti, e l'abbozzo dei cori, ed anche quella prosa che serve di schiarimento, e il tutto fu terminato il dí 26 maggio, e cosí sgravatomi di quel sí lungo e sí ostinato parto, ebbi pace; ma non per questo disegnava io di verseggiarla, né di ridurla a termine.
Ma nel settembre del '98 continuando, come dissi, lo studio vero del greco, con molto fervore, mi venne pensiero di andare sul testo riscontrando la mia traduzione dell'Alceste prima, per cosí rettificarla, e sempre imparar qualche cosa di quella lingua, che nulla insegna quanto il tradurre, a chi s'ostina di rendere, o di almeno accennare ogni parola, imagine, e figura del testo.
Rimpelagatomi dunque nell'Alceste prima, mi si riaccese per la quarta volta il furor della mia, e presala, e rilettala, e pianto assai, e piaciutami, il dí 30 settembre '98 ne cominciai i versi, e furon finiti anche coi cori verso il di 21 ottobre.
Ed ecco in qual modo io mi spergiurai dopo dieci anni di silenzio.
Ma tuttavia, non volendo io essere né plagiario né ingrato, e riconoscendo questa tragedia esser pur sempre tutta di Euripide, e non mia, fra le traduzioni l'ho collocata, e là dee starsi, sotto il titolo di Alceste seconda, al fianco inseparabile dell'Alceste prima sua madre.
Di questo mio spergiuro non avea parlato con chi che sia, neppure alla metà di me stesso.
Onde mi volli prendere un divertimento, e nel decembre invitate alcune persone la lessi come traduzione di quella di Euripide, e chi non l'avea ben presente, ci fu colto fin passato il terz'atto; ma poi chi se la rammentava svelò la celia, e cominciatasi la lettura in Euripide, si terminò in me.
La tragedia piacque; ed a me come cosa postuma non dispiacque; benché molto ci vedessi da torre e limare.
Lungamente ho narrato questo fatto, perché se quell'Alceste sarà col tempo tenuta per buona, si studi in questo fatto la natura spontanea dei poeti d'impeto, e come succede che quel che vorrebbero fare talvolta non riescono, e quel che non vorrebbero si fa fare e riesce.
Tanto è da valutarsi e da obbedirsi l'impulso naturale febeo.
Se poi non è buona, riderà il lettore doppiamente a mie spese sí nella Vita che nell'Alceste, e terrà questo capitolo come un'anticipazione su l'epoca quinta da togliersi alla virilità, e regalarsi alla vecchiaia.
Queste due Alcesti saputesi da alcuni in Firenze, svelarono anche il mio studio di greco, che avea sempre occultato a tutti; perfino all'amico Caluso; ma egli lo venne a sapere nel modo che dirò.
Aveva mandato verso il maggio di quest'anno un mio ritratto, bel quadro molto ben dipinto dal pittore Saverio Fabre, nato in Montpalieri, ma non perciò punto francese.
Dietro a quel mio ritratto, che mandava in dono alla sorella, aveva scritto due versetti di Pindaro.
Ricevuto il ritratto, graditolo molto, visitatolo per tutti i lati, e visti da mia sorella que' due scarabocchini greci, fece chiamare l'amico anche suo Caluso, che glie li interpretasse.
L'abate conobbe da ciò che io aveva almeno imparato a formare i caratteri; ma pensò bene che non avrei fatta quella boriosa pedanteria e impostura di scrivere un'epigrafe che non intendessi.
Onde subito mi scrisse per tacciarmi di dissimulatore, di non gli aver mai parlato di questo mio nuovo studio.
Ed io allora replicai con una letterina in lingua greca, che da me solo mi venne raccozzata alla meglio, di cui darò qui sotto il testo e la traduzione(13), e ch'egli non trovò cattiva per uno studente di cinquant'anni, che da un anno e mezzo circa s'era posto alla grammatica; ed accompagnai con la epistoluzza greca, quattro squarci delle mie quattro traduzioni, per saggio degli studi fatti sin a quel punto.
Ricevuto cosí da lui un po' di lode, mi confortai a proseguire sempre piú caldamente.
E mi posi all'ottimo esercizio, che tanto mi avea insegnato sí il latino che l'italiano, di imparare delle centinaia di versi di piú autori a memoria.
Ma in quello stess'anno '98, mi toccò in sorte di ricevere e scrivere qualche lettera da persona ben diversa in tutto dall'amico Caluso.
Era, come dissi, e come ognun sa, invasa la Lombardia dai francesi, fin dal '96, il Piemonte vacillava, una trista tregua sotto nome di pace avea fatta l'imperatore a Campoformio col dittator francese; il papa era traballato, ed occupata e schiavi-democrizzata la sua Roma; tutto d'ogni intorno spirava miseria, indegnazione, ed orrore.
Era allora ambasciatore di Francia in Torino, un Ginguené, della classe, o mestiere dei letterati in Parigi, il quale lavorava in Torino sordamente alla sublime impresa di rovesciare un re vinto e disarmato.
Di costui ricevei inaspettatamente una lettera, con mio grande stupore, e rammarico; sí la proposta che la risposta; e la replica e controreplica inserisco qui a guisa di nota(14), affinché sempre piú si veda, chi ne volesse dubitare, quanto siano state e pure e rette le mie intenzioni ed azioni in tutte codeste rivoluzioni di schiaveria.
Pare dall'andamento di queste due lettere del Ginguené che avendo egli ordine dai suoi despoti di asservire alla libertà francese il Piemonte, e cercando di sí fatta iniquità dei vili ministri, egli mi volesse tastar me per vedere se mi potevan anco disonorare, come mi aveano impoverito.
Ma i beni mondani stanno a posta della tirannide, e l'onore sta a posta di ciascuno individuo che ne sia possessore.
Quindi dopo la mia seconda replica non ne sentii piú parlare; ma credo che costui si servisse poi della notizia che l'abate Caluso gli diede per parte mia, circa alle balle mie di libri non pubblicati, per farne ricerca, e valersene come in appresso si vedrà.
La nota dei miei libri ch'egli dicea volermi far restituire e ch'io credo che già tutti se li fosse appropriati a sé, sarebbe risibile se io qui la mostrassi.
Ella era di circa cento volumi di tutti gli scarti delle piú infime opere italiane; e questa era la mia raccolta lasciata in Parigi sei anni prima, di circa mille seicento volumi almeno; scelti tutti i classici italiani, e latini.
Ma nessuno se ne stupirebbe di una tal nota, quando sapesse ch'ella dovea essere una restituzione francese.
CAPITOLO VIGESIMOSETTIMO
Misogallo finito.
Rime chiuse colla Teleutodia.
L'Abele ridotto; cosí le due Alcesti, e l'Ammonimento.
Distribuzione ebdomadaria di studi.
Preparato cosí, e munito delle lapidi sepolcrali, aspetto l'invasion dei francesi, che segue nel marzo '99.
Cresceva frattanto ogni dí piú il pericolo della Toscana, stante la leale amicizia che le professavano i francesi.
Già fin dal decembre del '98 aveano essi fatta la splendida conquista di Lucca, e di là minacciavano continuamente Firenze, onde ai primi del '99 parea imminente l'occupazione.
Io dunque volli preparare tutte le cose mie, ad ogni qualunque accidente fosse per succedere.
Fin dall'anno prima avea posto fine per tedio al Misogallo, e fatto punto all'occupazione di Roma, che mi pareva la piú brillante impresa di codesta schiaveria.
Per salvare dunque quest'opera per me cara ed importante, ne feci fare sino in dieci copie, e provvisto che in diversi luoghi non si potessero né annullare, né smarrire, ma al suo debito tempo poi comparissero.
Quindi, non avendo io mai dissimulato il mio odio e disprezzo per codesti schiavi malnati, volli aspettarmi da loro ogni violenza, ed insolenza, cioè prepararmi bene al solo modo che vi sarebbe di non le ricevere.
Non provocato, tacerei; ricercato in qualunque maniera, darei segno di vita, e di libero.
Disposi dunque tutto per vivere incontaminato, e libero, e rispettato, ovvero per morir vendicato se fosse bisognato.
La ragione che mi indusse a scrivere la mia vita, cioè perché altri non la scrivesse peggio di me, mi indusse allora altresí a farmi la mia lapide sepolcrale, e cosí alla mia donna, e le apporrò qui in nota(15), perché desidero questa e non altra, e quanto ci dico è il puro vero, sí di me, che di lei, spogliato di ogni fastosa amplificazione.
Provvisto cosí alla fama, o alla non infamia, volli anco provvedere ai lavori, limando, copiando, separando il finito dal no, e ponendo il dovuto termine a quello che l'età e il mio proposto volevano.
Perciò volli col compiere degli anni cinquanta frenare, e chiudere per sempre la soverchia fastidiosa copia delle rime, e ridottone un altro tometto purgato consistente in sonetti settanta, capitolo uno, e trentanove epigrammi, da aggiungersi alla prima parte di esse già stampate in Kehl, sigillai la lira, e la restituii a chi spettava, con una ode sull'andare di Pindaro, che per fare anche un po' il grecarello intitolai Teleutodía.
E con quella chiusi bottega per sempre; e se dopo ho fatto qualche sonettuccio o epigrammuccio, non l'ho scritto; se l'ho scritto non l'ho tenuto, e non saprei dove pescarlo, e non lo riconosco piú per mio.
Bisognava finir una volta e finire in tempo, e finire spontaneo, e non costretto.
L'occasione dei dieci lustri spirati, e dei barbari antilirici soprastantimi non potea esser piú giusta ed opportuna; l'afferrai, e non ci pensai poi mai piú.
Quanto alle traduzioni, il Virgilio mi era venuto ricopiato e corretto tutto intero nei due anni anteriori, onde lo lasciava sussistere; ma non come cosa finita.
Il Sallustio mi parea potere stare; e lasciavalo.
Il Terenzio no, perché una sola volta lo avea fatto, né rivistolo, né ricopiatolo; come non lo è adesso neppure.
Le quattro traduzioni dal greco, che condannarle al fuoco mi doleva, e lasciarle come cosa finita pur non poteva, poiché non l'erano, ad ogni rischio del se avrei il tempo o no, intrapresi di ricopiarle sí il testo che la traduzione, e prima di tutto l'Alceste per ritradurla veramente dal greco, che non mi sapesse poi di traduzione di traduzione.
Le tre altre bene o male, erano state direttamente tradotte dal testo, onde mi dovean costar poi meno tempo e fatica a correggerle.
L'Abele, che era ormai destinata ad essere (non dirò unica) ma sola, senza le concepite, e non mai eseguite compagne, l'avea fatta copiare, e limata, e mi parea potere stare.
Vi si era pure aggiunto alle opere di mio, negli anni precedenti una prosuccia brevina politica, intitolata Ammonimento alle potenze italiane; questa pure l'avea limata, e fatta copiare, e lasciavala.
Non già che io avessi la stolida vanagloria di voler fare il politico, che non è l'arte mia; ma si era fatto fare quello scritto dalla giusta indegnazione che mi aveano inspirata le politiche certo piú sciocche della mia, che in questi due ultimi anni avea visto adoprare dalla impotenza dell'imperatore, e dalle impotenze italiane.
Le satire finalmente, opera ch'io avea fatta a poco a poco, ed assai corretta, e limata, le lasciava pulite, e ricopiate in numero di diciassette quali sono; e quali pure ho fissato e promesso a me di non piú oltrepassare.
Cosi disposto, e appurato del mio secondo patrimonio poetico, smaltatomi il cuore, aspettava gli avvenimenti.
Ed affinché al mio vivere d'ora in poi se egli si dovea continuare venissi a dare un sistema piú confacente all'età in cui entrava, ed ai disegni ch'io mi era già da molto tempo proposti, fin dai primi del '99 mi distribuii un modo sistematico di studiare regolarmente ogni settimana, che tuttora costantemente mantengo, e manterrò finch'avrò salute e vita per farlo.
Il lunedí e martedí destinati, le tre prime ore della mattina appena svegliatomi, alla lettura, e studio della Sacra Scrittura; libro che mi vergognava molto di non conoscere a fondo, e di non averlo anzi mai letto sino a quell'età.
Il mercoledí e giovedí, Omero, secondo fonte d'ogni scrivere.
Il venerdí, sabato, e domenica, per quel prim'anno e piú li consecrai a Pindaro, come il piú difficile e scabro di tutti i greci, e di tutti i lirici di qualunque lingua, senza eccettuarne Giobbe, e i profeti.
E questi tre ultimi giorni mi proponeva poi, come ho fatto, di consecrarli successivamente ai tre tragici, ad Aristofane, Teocrito, ed altri sí poeti che prosatori, per vedere se mi era possibile di sfondare questa lingua, e non dico saperla (che è un sogno), ma intenderla almeno quanto fo il latino.
Ed il metodo che a poco a poco mi andai formando, mi parve utile; perciò lo sminuzzo, che forse potrà anche giovare cosí, o rettificato, a qualch'altri che dopo me intraprendesse questo studio.
La Bibbia la leggeva prima in greco, versione dei Settanta, testo vaticano, poi la raffrontava col testo alessandrino; quindi gli stessi due, o al piú tre capitoli di quella mattina, li leggeva nel Diodati italiani, che erano fedelissimi al testo ebraico; poi li leggeva nella nostra volgata latina, poi in ultimo nella traduzione interlineare fedelissima latina dal testo ebraico; col quale bazzicando cosí piú anni, ed avendone imparato l'alfabeto, veniva anche a poter leggere materialmente la parola ebraica, e raccapezzarne cosí il suono, per lo piú bruttissimo, ed i modi strani per noi, e misti di sublime e di barbaro.
Quanto poi ad Omero, leggeva subito nel greco solo ad alta voce, traducendo in latino letteralmente, e non mi arrestando mai, per quanti spropositi potessero venirmi detti, quei sessanta, o ottanta, o al piú piú cento versi che volea studiare in quella mattina.
Storpiati cosí quei tanti versi, li leggeva ad alta voce prosodicamente in greco.
Poi ne leggeva lo scoliaste greco, poi le note latine del Barnes, Clarch, ed Ernesto; poi pigliando per ultima la traduzione letterale latina stampata, la rileggeva sul greco di mio, occhiando la colonna, per vedere dove, e come, e perché avessi sbagliato nel tradurre da prima.
Poi nel mio testo greco solo, se qualche cosa era sfuggita allo scoliaste di dichiararla, la dichiarava io in margine, con altre parole greche equivalenti, al che mi valeva molto di Esichio, dell'Etimologico, e del Favorino.
Poi le parole, o modi, o figure straordinarie, in una colonna di carta le annotava a parte, e dichiaravale in greco.
Poi leggeva tutto il commento di Eustazio su quei dati versi, che cosí m'erano passati cinquanta volte sotto gli occhi, loro, e tutte le loro interpretazioni, e figure.
Parrà questo metodo noioso, e duretto; ma era duretto anch'io, e la cotenna di cinquanta anni ha bisogno di ben altro scarpello per iscolpirvi qualcosa, che non quella di venti.
Sopra Pindaro poi, io aveva già fatto gli anni precedenti uno studio piú ancora di piombo, che i sopradetti.
Ho un Pindaretto, di cui non v'è parola, su cui non esista un mio numero aritmetico notatovi sopra, per indicare, coll'un due e tre, fino talvolta anche a quaranta, e piú, qual sia la sede che ogni parola ricostruita al suo senso deve occupare in que' suoi eterni e labirintici periodi.
Ma questo non mi bastava, ed intrapresi allora nei tre giorni ch'io gli destinai, di prendere un altro Pindaro greco solo, di edizione antica, e scorrettissimo, e mal punteggiato, quel del Calliergi di Roma, primo che abbia gli scolii, e su quello leggeva a prima vista, come dissi dell'Omero, subito in latino letteralmente sul greco, e poi la stessa progressione che su l'Omero; e di piú poi in ultimo una dichiarazione marginale mia in greco dell'intenzione dell'autore; cioè il pensiero spogliato del figurato.
Cosí poi praticai su l'Eschilo e Sofocle, quando sottentrarono ai giorni di Pindaro; e con questi sudori, e pazze ostinazioni, essendomisi debilitata da qualch'anni assai la memoria, confesso che ne so poco, e tuttavia prendo alla prima lettura dei grossissimi granchi.
Ma lo studio mi si è venuto facendo sí caro, e sí necessario, che già dal '96 in poi, per nessuna ragione mai ho smesso, o interrotto le tre ore di prima svegliata, e se ho composto qualche cosa di mio, come l'Alceste, le satire, e rime, ed ogni traduzione, l'ho fatto in ore secondarie, talché ho assegnato a me stesso l'avanzo di me, piuttosto che le primizie del giorno; e dovendo lasciare, o le cose mie, o lo studio, senza nessun dubbio lascio le mie.
Sistemato dunque in tal guisa il mio vivere, incassati tutti i miei libri, fuorché i necessari, e mandatili in una villa fuori di Firenze, per vedere se mi riusciva di non perderli una seconda volta, questa tanto aspettata ed abborrita invasione dei francesi in Firenze ebbe luogo il dí 25 marzo del '99, con tutte le particolarità, che ognuno sa, e non sa, e non meritano d'essere sapute, sendo tutte le operazioni di codesti schiavi di un solo colore ed essenza.
E quel giorno stesso, poche ore prima ch'essi v'entrassero, la mia donna ed io ce n'andammo in una villa fuor di Porta San Gallo presso a Montughi, avendo già prima vuotata interamente d'ogni nostra cosa la casa che abitavamo in Firenze per lasciarla in preda agli oppressivi alloggi militari.
CAPITOLO VIGESIMOTTAVO
Occupazioni in villa.
Uscita dei francesi.
Ritorno nostro in Firenze.
Lettere del Colli.
Dolore mio nell'udire la ristampa prepararsi in Parigi delle mie opere di Kehl, non mai pubblicate.
In tal maniera io oppresso dalla comune tirannide, ma non perciò soggiogato, me ne stetti in quella villa con poca gente di servizio, e la dolce metà di me stesso, ambedue indefessamente occupati nelle lettere, che anch'essa sufficientemente perita nella lingua inglese e tedesca, ed egualmente poi franca nell'italiano che nel francese, la letteratura di queste quattro nazioni conosce quant'è, è dell'antica non ignora l'essenza per mezzo delle traduzioni in queste quattro lingue.
Di tutto dunque potendo io favellare con essa, soddisfatto egualmente il core che la mente, non mi credeva piú felice, che quando mi toccava di vivere solo a solo con essa, disgiunti da tutti i tanti umani malanni.
E cosí eramo in quella villa, dove pochissimi dei nostri conoscenti di Firenze ci visitavano, e di rado, per non insospettire la militare e avvocatesca tirannide, Che è di tutti i guazzabugli politici il piú mostruoso, e risibile, e lagrimevole ed insopportabile, e mi rappresenta perfettamente un tigre guidato da un coniglio.
Subito arrivato in villa, mi posi a lavorare di fronte la ricopiatura e limatura delle due Alcesti, non toccando però le ore dello studio mattutino, onde poco tempo mi avanzava da pensare a nostri guai e pericoli, essendo sí caldamente occupato.
Ed i pericoli erano molti, né accadea dissimularceli, o lusingarci di non v'essere; ogni giorno mi avvisava; eppure con simile spina nel cuore e dovendo temere per due, mi facea pure animo, e lavorava.
Ogni giorno si arrestava arbitrariamente, al solito di codesto sgoverno, la gente; anzi sempre di notte.
Erano cosí stati presi sotto il titolo di ostaggi, molti dei primari giovani della città; presi in letto di notte, dal fianco delle loro mogli, spediti a Livorno come schiavi, ed imbarcativi alla peggio per l'isole di S.
Margarita.
Io, benché forestiere, dovea temere a questo, e piú, dovendo essere loro noto come disprezzatore e nemico.
Ogni notte poteva essere quella che mi venissero a cercare; avea provvisto per quanto si potea per non lasciarmi sorprendere, né malmenare.
Intanto si proclamava in Firenze la stessa libertà ch'era in Francia, e tutti i piú vili e rei schiavi trionfavano.
Intanto io verseggiava, e grecizzava, e confortava la mia donna.
Durò questo infelice stato dai 25 marzo ch'entrarono, fino al dí 5 luglio, che essendo battuti, e perdenti in tutta la Lombardia, se ne fuggirono per cosí dir di Firenze la mattina per tempissimo, dopo aver, già s'intende, portato via in ogni genere tutto ciò che potevano.
Né io né la mia donna in tutto questo frattempo abbiamo mai messo piede in Firenze, né contaminati i nostri occhi né pur con la vista di un solo francese.
Ma il tripudio di Firenze in quella mattina dell'evacuazione, e giorni dopo nell'ingresso di duecento ussari austriaci, non si può definir con parole.
Avvezzi a quella quiete della villa, ci volemmo stare ancora un altro mese, prima di tornare in Firenze, e riportarvi i nostri mobili, e libri.
Tornato in città, il mutar luogo non mi fece mutar in nulla l'intrapreso sistema degli studi, e continuava anzi con piú sapore, e speranza, poiché per tutto quel rimanente dell'anno '99, essendo disfatti per tutto i francesi, risorgeva alcuna speranza della salute dell'Italia, ed in me risorgeva la privata speranza, che avrei ancor tempo di finir tutte le mie piú che ammezzate opere.
Ricevei in quell'anno, dopo la battaglia di Novi, una lettera del marchese Colli, mio nipote, cioè marito di una figlia di mia sorella, che non m'era noto di persona, ma di fama, come ottimo ufiziale ch'egli era stato, e distintosi in quei cinque e piú anni di guerra, al servizio del re di Sardegna suo sovrano naturale, sendo egli d'Alessandria.
Mi scrisse dopo essere stato fatto prigioniero, e ferito gravemente, sendo allora passato al servizio dei francesi, dopo la deportazione del re di Sardegna fuori dei di lui stati, seguita nel gennaio di quell'anno '99.
La di lui lettera, e la mia risposta ripongo qui fra le note(16).
E dirò qui per incidenza quello che mi scordai di dir prima, che anzi l'invasion dei francesi, io avea veduto in Firenze il re di Sardegna, e fui a inchinarlo, come il doppio dover mio, sendo egli stato il mio re, ed essendo allora infelicissimo.
Egli mi accolse assai bene; la di lui vista mi commosse non poco, e provai in quel giorno quel ch'io non avea provato mai, una certa voglia di servirlo, vedendolo sí abbandonato, e sí inetti i pochi, che gli rimanevano; e me gli sarei profferto, se avessi creduto di potergli esser utile; ma la mia abilità era nulla in tal genere di cose, ed ad ogni modo era tardi.
Egli andò in Sardegna; variarono poi intanto le cose, egli tornò di Sardegna, ristette dei mesi molti in Firenze al Poggio Imperiale, tenendo gli austriaci allora la Toscana in nome del granduca; ma anche allora mal consigliato, non fece nulla di quel che doveva o poteva per l'utile suo e del Piemonte; onde di nuovo poi tornate al peggio le cose, egli si trovò interamente sommerso.
Lo inchinai pure di nuovo al ritorno di Sardegna, e vistolo in migliori speranze, molto meno mi rammaricai meco stesso di non potergli esser utile in nulla.
Appena queste vittorie dei difensori dell'ordine, e delle proprietà mi aveano rimesso un poco di balsamo nel sangue, che mi toccò di provare un dolore acerbissimo, ma non inaspettato.
Mi capitò alle mani un manifesto del libraio Molini italiano di Parigi, in cui diceva di aver intrapreso di stampare tutte le mie opere (diceva il manifesto, filosofiche, sí in prosa che in versi) e ne dava il ragguaglio, e tutte purtroppo le mie opere stampate in Kehl, come dissi, e da me non mai pubblicate, vi si trovavano per estenso.
Questo fu un fulmine, che mi atterrò per molti giorni, non già che io mi fossi lusingato, che quelle mie balle di tutta l'edizione delle quattro opere Rime, Etruria, Tirannide e Principe, potessero non essere state trovate da chi mi aveva svaligiato dei libri, e d'ogni altra cosa da me lasciata in Parigi, ma essendo passati tant'anní, sperava ancora dilazione.
Fin dall'anno '93 in Firenze, quando vidi assolutamente perduti i miei libri, feci pubblicare un avviso in tutte le gazzette d'Italia ove diceva essermi stati presi, confiscati, e venduti i miei libri, e carte, onde io dichiarava già fin d'allora non riconoscer per mia nessun'altra opera, fuorché le tali, e tali pubblicate da me.
Le altre, e alterate, o supposte, e certamente sempre surrepitemi, non le ammetteva.
Ora nel '99 udendo questo manifesto del Molini, il quale prometteva per l'800 venturo la ristampa delle sudette opere, il mezzo piú efficace di purgarmi agli occhi dei buoni e stimabili, sarebbe stato di fare un contromanifesto, e confessare i libri per miei, dire il modo con cui m'erano stati furati, e pubblicare per discolpa totale del mio sentire e pensare, il Misogallo, che certo è piú atto e bastante da ciò.
Ma io non era libero, né il sono; poiché abito in Italia; poiché amo, e temo per altri che per me; onde non feci questo che avrei dovuto fare in altre circostanze; per esentarmi una volta per sempre dall'infame ceto degli schiavi presenti, che non potendo imbiancare sé stessi, si compiacciono di sporcare gli altri, fingendo di crederli e di annoverarli tra i loro; ed io per aver parlato di libertà sono un di quelli, ch'essi si associano volentieri, ma me ne dissocierà ampiamente poi il Misogallo agli occhi anche dei maligni e degli stupidi, che son i soli che mi posson confondere con codestoro; ma disgraziatamente, queste due categorie sono i due terzi e mezzo del mondo.
Non potendo io dunque fare ciò, che avrei saputo e dovuto, feci soltanto quel pochissimo che poteva per allora; e fu di ripubblicare di nuovo in tutte le gazzette d'Italia il mio avviso del '93, aggiungendovi la poscritta, che avendo udito che si pubblicava in Parigi delle opere in prosa e in versi, sotto il mio nome, rinnovava quel protesto fatto sei anni innanzi.
Ma il fatto si era, che quell'onesto letterato dell'ambasciator Ginguené, che mi avea scritto le lettere surriferite, e che io poi avea fatto richiedere in voce dell'abate di Caluso, giacché egli voleva pure ad ogni costo fare di me, ch'io non richiedeva i miei libri, né altro, ma che solamente avrei desiderato raccapezzar quelle sei balle dell'edizioni non pubblicate, ad impedire ogni circolazione: fatto si è, dico (a quel ch'io mi penso) che il Ginguené ritornato poi a Parigi avrà frugato tra i miei libri di nuovo, e trovatavi una ballottina contenente quattro soli esemplari di quelle quattro opere, se le appropriò; ne vendé forse al Molini un esemplare perché si ristampassero, e le altre si tenne, e tradusse le prose in francese per farne bottega e donò, non sendo sue, alla Biblioteca Nazionale, [...] come sta scritto nella prefazione stessa del quarto volume ristampato dal Molini, che dice non essere reperibile l'edizion prima, altro che quattro esemplari, ch'egli individua cosí come ho detto, e che tornano per l'appunto con la piccola balla da me lasciata fra i libri altri miei.
Quanto poi alle sei balle, contenenti piú di cinquecento esemplari di ciascun'opera non posso congetturare cosa ne sia avvenuto.
Se fossero state trovate ed aperte, circolerebbero, e si sarebbero vendute piuttosto che ristampate, sendo sí belle l'edizioni, la carta, e i caratteri, e la correzione.
Il non essere venute in luce mi fa credere che ammontate in qualche di quei sepolcri di libri che tanti della roba perduta ne rimangono infatti a putrefarsi in Parigi, non siano stati aperti; perché ci avea fatto scrivere su le balle di fuori Tragedie italiane.
Comunque sia, il doppio danno ne ho avuto di perdere la mia spesa e fatica nella proprietà di quelle stampate da me, e di acquistare (non dirò l'infamia) ma la disapprovazione e la taccia di far da corista a que' birbi, nel vedermele pubblicate per mezzo delle stampe d'altrui.
CAPITOLO VIGESIMONONO
Seconda invasione.
Insistenza noiosa del general letterato.
Pace tal quale, per cui mi scemano d'alquanto le angustie.
Sei commedie ideate ad un parto.
Appena per qualche mesi aveva l'Italia un poco respirato dal giogo, e ruberie francesi, quando la favolosa battaglia di Marengo nel giugno del 1800, diede in poche ore l'Italia tutta in preda di costoro, chi sa per quanti anni.
Io la sentiva quanto e piú ch'altri, ma piegando il collo alla necessità, tirava a finire le cose mie senza piú punto curare per cosí dire un pericolo, dal quale non m'era divezzato ancora, né oramai, visto l'instabilità di codeste sozzure politiche, me ne divezzerò mai piú.
Assiduamente dunque lavorando sempre a ben ridurre e limare le mie quattro traduzioni greche, e null'altro poi facendo che proseguire ardentemente gli studi troppo tardi intrapresi, strascinava il tempo.
Venne l'ottobre, e il dí 15 d'esso, ecco di nuovo inaspettatamente in tempo di tregua fissata con l'imperatore, invadono i francesi di nuovo la Toscana, che riconoscevano tenersi pel granduca, col quale non erano in guerra.
Non ebbi tempo questa volta di andare in villa come la prima, e bisognò sentirli e vederli, ma non mai altro, s'intende, che nella strada.
Del resto la maggior noia e la piú oppressiva, cioè l'alloggio militare, venni a capo presso il comune di Firenze di farmene esentare come forestiere, ed avendo una casa ristretta e incapace.
Assoluto di questo timore che era il piú incalzante e tedioso, del resto mi rassegnai a quel che sarebbe.
Mi chiusi per cosí dire in casa, e fuorché due ore di passeggiata a me necessarie, che faceva ogni mattina nei luoghi piú appartati e soletto, non mi facea mai vedere, né desisteva dalla piú ostinata fatica.
Ma se io sfuggiva costoro, non vollero essi sfuggire me, e per mia disgrazia il loro generale comandante in Firenze, pizzicando del letterato, volle conoscermi, e civilmente passò da me una, e due volte, sempre non mi trovando, che già avea provvisto di non essere repperibile mai; né volli pure rendere garbo per garbo col restituir per polizza la visita.
Alcuni giorni dopo egli mandò ambasciata a voce, per sapere in che ore mi si potrebbe trovare.
Io vedendo crescere l'insistenza, e non volendo commettere ad un servitor di piazza la risposta in voce, che potea venire o scambiata o alterata, scrissi su un fogliolino; che Vittorio Alfieri, perché non seguisse sbaglio nella risposta da rendersi dal servo al signor generale, mettea per iscritto: che se il generale in qualità di comandante di Firenze intimavagli di esser da lui, egli ci si sarebbe immediatamente costituito, come non resistente alla forza imperante, qual ch'ella si fosse; ma che se quel volermi vedere era una mera curiosità dell'individuo, Vittorio Alfieri, di sua natura molto selvatico non rinnovava oramai piú conoscenza con chicchesia, e lo pregava quindi di dispensarnelo.
Il generale rispose direttamente a me due parole in cui diceva che dalle mie opere gli era nata questa voglia di conoscermi, ma che ora vedendo questa mia indole ritrosa, non ne cercherebbe altrimenti.
E cosí fece; e cosí mi liberai di una cosa per me piú gravosa e accorante, che nessun altro supplizio che mi si fosse potuto dare.
In questo frattempo il già mio Piemonte, celtizzato anch'egli, scimmiando ogni cosa dei suoi servipadroni, cambiò l'Accademia sua delle Scienze, già detta Reale, in un Istituto Nazionale a norma di quel di Parigi, dove avean luogo, e le belle lettere, e gli artisti.
Piacque a coloro, non so quali si fossero (perché il mio amico Caluso si era dimesso del segretariato della già Accademia), piacque dico a coloro di nominarmi di codesto Istituto, e darmene parte con lettera diretta.
Io prevenuto già dall'abate, rimandai la lettera non apertala, e feci dire in voce dall'abate che io non riceveva tale aggregazione; che non voleva essere di nessuno, e massimamente d'una donde recentemente erano stati esclusi con animosa sfacciataggine, tre cosí degni soggetti, come il cardinale Gerdil, il conte Balbo, ed il cavalier Morozzo, come si può vedere dalle qui annesse(17) lettere dell'amico Caluso, non adducendo di ciò altra cagione, fuorché questi erano troppo realisti.
Io non sono mai stato, né sono realista, ma non perciò son da essere misto con tale genia; la mia repubblica non è la loro, e sono, e mi professerò sempre d'essere in tutto quel ch'essi non sono.
E qui pure pien d'ira pel ricevuto affronto, mi spergiurai rimando quattordici versi su tal fatto, e li mandai all'amico; ma non ne tenni copia, né questi né altri che l'indegnazione od altro affetto mi venisse a strappar dalla penna, non registrerò oramai piú fra le mie già troppe rime.
Non cosí aveva io avuto la forza di resistere nel settembre dell'anno avanti ad un nuovo (o per dir meglio) ad un rinnovato impulso naturale fortissimo, che mi si fece sentire per piú giorni, e finalmente, non lo potendo cacciare, cedei.
E ideai in iscritto sei commedie, si può dire ad un parto solo.
Sempre avea avuto in animo di provarmi in quest'ultimo arringo, ed avea fissato di farne dodici, ma i contrattempi, le angustie d'animo, e piú d'ogni cosa lo studio prosciugante continuo di una sí immensamente vasta lingua, qual è la greca, mi aveano sviato e smunto il cervello, e credeva oramai impossibile ch'io concepissi piú nulla, né ci pensava neppure.
Ma, non saprei dir come nel piú tristo momento di schiavitú, e senza quasi probabilità, né speranza di uscirne, né d'aver tempo io piú, né mezzi per eseguire, mi si sollevò ad un tratto lo spirito, e mi riaccese faville creatrici.
Le prime quattro commedie adunque, che son quasi una divisa in quattro, perché tendenti ad uno scopo solo, ma per mezzi diversi, mi vennero ideate insieme in una passeggiata, e tornando ne feci l'abbozzo al solito mio.
Poi il giorno dopo fantasticandovi, e volendo pur vedere se anche in altro genere ne potrei fare, almeno una per saggio, ne ideai altre due, di cui la prima fosse di un genere anche nuovo per l'Itaha, ma diverso dalle quattro, e la sesta poi fosse la commedia mera italiana dei costumi d'Italia quali sono adesso; per non aver taccia di non saperli descrivere.
Ma appunto perché i costumi variano, chi vuol che le commedie restino, deve pigliar a deridere, ed emendare l'uomo; ma non l'uomo d'Italia, piú che di Francia o di Persia; non quello del 1800, piú che quello del 1500, o del 2000, se no perisce con quegli uomini e quei costumi, il sale della commedia e l'autore.
Cosí dunque in sei commedie io ho creduto, o tentato di dare tre generi diversi di commedie.
Le quattro prime adattabili ad ogni tempo, luogo, e costume; la quinta fantastica, poetica, ed anche di largo confine, la sesta nell'andamento moderno di tutte le commedie che si vanno facendo, e delle quali se ne può far a dozzina imbrattando il pennello nello sterco che si ha giornalmente sotto gli occhi: ma la trivialítà d'esse è molta; poco, a parer mio, il diletto, e nessunissimo utile.
Questo mio secolo, scarsetto anzi che no d'invenzione, ha voluto pescar la tragedia dalla commedia, praticando il dramma urbano, che è come chi direbbe l'epopea delle rane.
Io all'incontro che non mi piego mai se non al vero, ho voluto cavare (con maggiore verisimiglianza mi credo) dalla tragedia la commedia; il che mi pare piú utile, piú divertente, e piú nel vero; poiché dei grandi e potenti che ci fan ridere si vedono spesso; ma dei mezzani, cioè banchieri avvocati, o simili, che si facciano ammirare non ne vediamo mai; ed il coturno assai male si adatta ai piedi fangosi.
Comunque sia l'ho tentato; il tempo, ed io stesso rivedendole giudicherò poi se debbano stare, o bruciarsi.
CAPITOLO TRIGESIMO
Stendo un anno dopo averle ideate la prosa delle sei commedie; ed un altr'anno dopo le verseggio; l'una e l'altra di queste due fatiche con gravissimo scapito della salute.
Rivedo l'abate di Caluso in Firenze.
Passò pure anche quell'anno lunghissimo dell'800, la di cui seconda metà era stata sí funesta, e terribile a tutti i galantuomini; e nei primi mesi del seguente '801 non avendo fatto gli alleati altro che spropositi, si venne finalmente a quella orribil sedicente pace, che ancora dura, e tiene tutta l'Europa in armi, in timore, ed in schiavitú, cominciando dalla Francia stessa, che a tutte l'altre dando legge, la riceve poi essa da un perpetuo console piú dura ed infame, che non la dà.
Ma io oramai pel troppo sentire queste pubbliche italiane sventure fatto direi quasi insensibile, ad altro piú non pensava, che a terminare la mia già troppo lunga e copiosa carriera letteraria.
Perciò verso il luglio di quest'anno mi rivolsi caldamente a provare le mie ultime forze nello stendere tutte quelle sei commedie.
E cosí pure di un fiato come le aveva ideate mi vi posi a stenderle senza intermissione, circa sei giorni al piú per ognuna; ma fu tale il riscaldamento e la tensione del capo, che non potei finire la quinta, ch'io mi ammalai gravemente d'un'accensione al capo, e d'una fissazione di podagra al petto, che terminò col farmi sputare del sangue.
Dovei dunque smettere quel caro lavoro, ed attendere a guarirmi.
Il male fu forte, ma non lungo; lunga fu la debolezza della convalescenza in appresso; e non mi potei rimettere a finir la quinta, e scrivere tutta la sesta commedia, fino al fin di settembre; ma ai primi di ottobre tutte erano stese; e mi sentii sollevato di quel martello che elle mi aveano dato in capo da tanto tempo.
Sul fin di quest'anno ebbi di Torino una cattiva nuova; la morte del mio unico nipote di sorella carnale, il conte di Cumiana, in età di trent'anni appena; in tre giorni di malattia, senza aver avuto né moglie, né figli.
Questo mi afflisse non poco, benché io appena l'avessi visto ragazzo; ma entrai nel dolore della madre (il di lui padre era morto due anni innanzi), ed anche confesserò che mi doleva di veder passare tutto il mio, che aveva donato alla sorella, in mano di estranei.
Che eredi saranno della mia sorella, e cognato, tre figlie, che le rimangono tutte tre accasate; una come, dissi col Colli d'Alesandria, l'altra con un Ferreri di Genova, e l'altra con il conte di Cellano d'Aosta.
Quella vanitaduzza, che si può far tacere, ma non si sradica mai dal cuore di chi è nato distinto, di desiderare una continuità del nome, o almeno della famiglia, non mi s'era neppure totalmente sradicata in me, e me ne rammaricai piú che non avrei creduto; tanto è vero, che per ben conoscer sé stessi, bisogna la viva esperienza, e ritrovarsi nei dati casi, per poter dire quel che si è.
Questa orfanità di nipote maschio, mi indusse poi a sistemare amichevolmente con mia sorella altri mezzi per l'assicurazione della mia pensione in Piemonte, caso mai (che nol credo) ch'io dovessi sopravvivere a lei, per non ritrovarmi all'arbitrio di codeste nipoti, e dei loro mariti che non conosco.
Ma intanto quella quantunque pessima pace avea pure ricondotto una mezza tranquillità in Italia, e dal despotismo francese essendosi annullate le cedole monetarie sí in Piemonte, che in Roma, tornati dalla carta all'oro sí la signora che io, ella di Roma, io di Piemonte cavando, ci ritrovammo ad un tratto fuori quasi dell'angustia, che avevamo provato negli interessi da piú di cinque anni, scapitando ogni giorno piú dell'avere.
Perciò sul finire del suddetto '801 ricomprammo cavalli, ma non piú che quattro, di cui solo uno da sella per me, che da Parigi in poi non avea mai piú avuto cavallo, né altra carrozza che una pessima d'affitto.
Ma gli anni, le disgrazie pubbliche, tanti esempi di sorte peggior della nostra, mi aveano reso moderato e discreto; onde i quattro cavalli furono oramai anche troppi, per chi per molti anni appena si era contentato di dieci, e di quindici.
Del rimanente poi bastantemente sazio e disingannato delle cose del mondo, sobrio di vitto, vestendo sempre di nero, nulla spendendo che in libri, mi trovo ricchissimo, e mi pregio assai di morire di una buona metà piú povero, che non son nato.
Perciò non attesi alle offerte che il mio nipote Colli mi fece fare dalla sorella, di adoperarsi in Parigi, dove egli andava a fissarsi, presso quei suoi amici, ch'egli senza vergogna mi annovera e nomina nella sua seconda lettera che ho pure trascritta, di adoperarsi, dico, presso coloro per farmi rendere il mio confiscatomi in Francia, l'entrate ed i libri, ed il rimanente.
Dai ladri non ripeto mai nulla; e da una risibil tirannide in cui l'ottener giustizia è una grazia, non voglio né l'una né l'altra.
Onde non ho altrimenti neppure fatto rispondere al Colli nulla su di ciò; come neppure nulla avea replicato alla di lui seconda lettera, in cui egli dissimula di aver ricevuta la mia risposta alla prima; ed in fatti permanendo egli general francese, dovea dissimular la mia sola risposta.
Cosí io permanendo libero e puro uomo italiano dovea dissimulare ogni sua ulteriore lettera, e offerta, che per qualunque mezzo pervenir mi facesse.
Venuto appena l'estate dell'802 (ch
...
[Pagina successiva]

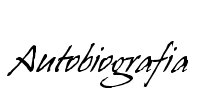 Libri online
Libri online