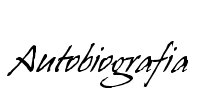[Pagina precedente]...io.
Piú d'un modo di farlo mi si presentava alla mente. Quello di andar prolungando, d'anno in anno la licenza, chiedendola; ed era forse il piú savio, ma rimaneva anche dubbio, né mai mi vi potea pienamente affidare, dipendendo dall'arbitrio altrui. Quello di usar sottigliezze, raggiri, e lungaggini, simulando dei debiti, con vendite clandestine, e altri simili compensi per realizzare il fatto mio, ed estrarlo da quel nobil carcere. Ma questi mezzi eran vili, ed incerti; né mi piacevano punto, fors'anche perché estremi non erano. Del resto, avvezzo io per carattere a sempre presupporre le cose al peggio, assolutamente voleva anticipando schiarire e decidere questo fatto, al quale mi conveniva poi a ogni modo un giorno o l'altro venirci, o rinunziare all'arte e alla gloria di indipendente e veridico autore. Determinato dunque di appurar la cosa, e fissare se avrei potuto salvare parte del mio per campare e stampare fuor di paese, mi accinsi vigorosamente all'impresa. E feci saviamente, ancorché giovine fossi, ed appassionato in tante maniere. E certo, se io mai (visto il dispotico governo sotto cui mi era toccato di nascere) s'io mai mi fossi lasciato avvantaggiare dal tempo, e trovatomi nel caso di avere stampato fuori paese anche i piú innocenti scritti, la cosa diveniva assai problematica allora, e la mia sussistenza, la mia gloria, la mia libertà , rimanevano interamente ad arbitrio di quell'autorità assoluta, che necessariamente offesa dal mio pensare, scrivere, ed operare dispettosamente generoso e libero, non mi avrebbe certamente poi favorito nell'impresa di rendermi indipendente da essa.
Esisteva in quel tempo una legge in Piemonte, che dice: "Sarà pur anche proibito a chicchessia di fare stampar libri o altri scritti fuori de' nostri Stati, senza licenza de' revisori, sotto pena di scudi sessanta, od altra maggiore, ed eziandio corporale, se cosà esigesse qualche circostanza per un pubblico esempio". Alla qual legge aggiungendo quest'altra: "I vassalli abitanti de' nostri Stati non potranno assentarsi dai medesimi senza nostra licenza in iscritto". E fra questi due ceppi si vien facilmente a conchiudere, che io non poteva essere ad un tempo vassallo ed autore. Io dunque prescelsi di essere autore. E, nemicissimo com'io era d'ogni sotterfugio ed indugio, presi per disvassallarmi la piú corta e la piú piana via, di fare una interissima donazione in vita d'ogni mio stabile sà infeudato che libero (e questo era piú che i due terzi del tutto) al mio erede naturale, che era la mia sorella Giulia, maritata come dissi col conte di Cumiana. E cosà feci nella piú solenne e irrevocabile maniera, riserbandomi una pensione annua di lire quattordici mila di Piemonte, cioè zecchini fiorentini mille quattrocento, che venivano ad essere poco piú in circa della metà della mia totale entrata d'allora. E contentone io rimanevami di perdere l'altra metà , o di comprare con essa l'indipendenza della mia opinione, e la scelta del mio soggiorno, e la libertà dello scrivere. Ma il dare stabile e intero compimento a codest'affare mi cagionò molte noie e disturbi, attese le molte formalità legali, che trattandosi l'affare da lontano per lettere, consumarono necessariamente assai piú tempo. Ci vollero oltre ciò le consuete permissioni del re; che in ogni piú privata cosa in quel benedetto paese sempre c'entra, il re. E fu d'uopo che il mio cognato, facendo per sé e per me, ottenesse dal re la licenza di accettare la mia donazione, e venisse autorizzato a corrispondermene quell'annuale prestazione in qualsivoglia paese mi fosse piaciuto dimorare. Agli occhi pur anche dei meno accorti manifestissima cosa era, che la principal cagione della mia donazione era stata la determinazione di non abitar piú nel paese: quindi era necessarissimo di ottenerne la permissione dal governo, il quale ad arbitrio suo si sarebbe sempre potuto opporre allo sborso della pensione in paese estero. Ma, per mia somma fortuna, il re d'allora, il quale certamente avea notizia del mio pensare (avendone io dati non pochi cenni) egli ebbe molto piú piacere di darmi l'andare che non di tenermi. Onde egli consentà subito a quella mia spontanea spogliazione; ed ambedue fummo contentissimi: egli di perdermi, io di ritrovarmi.
Ma mi par giusto di aggiungere qui una particolarità bastantemente strana, per consolare con essa i malevoli miei, e nello stesso tempo far ridere alle spalle mie chiunque esaminando sé stesso si riconoscerà meno infermo d'animo, e meno bambino ch'io non mi fossi. In questa particolarità , la quale in me si troverà accoppiata con gli atti di forza che io andava pure facendo, si scorgerà da chi ben osserva e riflette, che talvolta l'uomo, o almeno, che io riuniva in me, per cosà dire, il gigante ed il nano. Fatto si è, che nel tempo stesso ch'io scriveva la Virginia, e il libro della Tirannide; nel tempo stesso ch'io scuoteva cosà robustamente e scioglieva le mie originarie catene, io continuava pure di vestire l'uniforme del re di Sardegna, essendo fuori paese, e non mi trovando piú da circa quattr'anni al servizio. E che diran poi i saggi, quand'io confesserò candidamente la ragione perché lo portassi? Perché mi persuadeva di essere in codesto assetto assai piú snello e avvenente della persona. Ridi, o lettore, che tu n'hai ben donde. Ed aggiungi del tuo: che io dunque in ciò fare, puerilmente e sconclusionatamente preferiva di forse parere agli altrui occhi piú bello, all'essere stimabile ai miei.
La conclusione di quel mio affare andò frattanto in lunga dal gennaio al novembre di quell'anno '78; atteso che intavolai poi e ultimai come un secondo trattato la permuta di lire cinquemila della prestazione annuale in un capitale di lire centomila di Piemonte, da sborsarmisi dalla sorella. E questo soffrà qualche difficoltà piú che il primo. Ma finalmente consentà anche il re che mi fosse mandata tal somma; ed io poi con altre la collocai in uno di quei tanti insidiosi vitalizi di Francia. Non già ch'io mi fidassi molto piú nel cristianissimo che nel sardo re; ma perché mi pareva intanto che dimezzato cosà il mio avere tra due diverse tirannidi, ne riuscirei alquanto meno precario, e che salverei in tal guisa, se non la borsa, almeno l'intelletto e la penna.
Di questo passo della donazione, epoca per me decisiva e importante (e di cui ho sempre dappoi benedetto il pensiero e l'esito), io non ne feci parte alla donna mia, se non se dopo che l'atto principale fu consolidato e perfetto. Non volli esporre il delicato suo animo al cimento di dovermi, o biasimare di ciò, e come contrario al mio utile, impedirmelo; ovvero di lodarlo e approvarmelo, come giovevole in qualche aspetto al sempre piú dar base e durata al nostro reciproco amore; poiché questa sola determinazione mia potevami porre in grado di non la dovere abbandonare mai piú. Quand'essa lo seppe, biasimollo con quella candida ingenuità tutta sua. Ma non potendolo pure piú impedire, ella vi si acquetò, perdonandomi d'averglielo taciuto. E tanto piú forse mi riamò, né mi stimò niente meno. Frattanto, mentre io stava scrivendo lettere a Torino, e riscrivendo, e tornando a scrivere, perché si conchiudessero codeste noie e stitichezze reali, legali, e parentevoli; io, risoluto di non dar addietro, qualunque fosse per essere l'esito, avea ordinato al mio Elia che avea lasciato in Torino, di vendere tutti i mobili ed argenti. Egli in due mesi di tempo, lavorando indefessamente a ciò mi avea messi insieme da sei e piú mila zecchini, che tosto gli ordinai di farmi sborsare per mezzo di cambiali in Firenze. Non so per qual caso nascesse, che fra l'avermi egli scritto d'aver questa mia somma nelle mani, e l'eseguire poi l'incarico ch'io gli avea dato rispondendogli a posta corrente di mandar le cambiali, corsero piú di tre settimane in cui non ricevei piú né lettere di lui, né altro; né avviso di banchiere nessuno. Benché io non sia per carattere molto diffidente, tuttavia poteva pur ragionevolmente entrare in qualche sospetto, vedendo in circostanze cosà urgenti una sà strana tardanza per parte d'un uomo sà sollecito ed esatto come l'Elia. Mi entrò dunque non poca diffidenza nel cuore; e la fantasia (in me sempre ardentissima) mi fabbricò questo danno che era tra i possibili, come se veramente già mi fosse accaduto. Onde io credei fermamente per piú di quindici giorni che i miei sei mila zecchini fossero iti all'aria insieme con l'ottima opinione ch'io mi era sempre giustamente tenuta di quell'Elia. Ciò posto io mi trovava allora in due circostanze. L'affare con la sorella non era sistemato ancora; e sempre ricevendo nuove cavillazioni dal cognato, che tutte le sue private obbiezioni me le andava sempre facendo in nome e autorità del re; io gli avea finalmente risposto con ira e disprezzo: che se essi non voleano Donato, pigliassero pure Pigliato; perché io a ogni modo non ci tornerei mai, e poco m'importava di essi e dei lor danari e del loro re, che si tenessero il tutto e fosse cosa finita. Ed io era in fatti risolutissimo all'espatriazione perpetua, a costo pur anche del mendicare. Dunque per questa parte trovandomi in dubbio d'ogni cosa, e per quella dei mobili realizzati non mi vedendo sicuro di nulla, io me la passai cosà fantasticando e vedendomi sempre la squallida povertà innanzi agli occhi, finché mi pervennero le cambiali d'Elia, e vistomi possessore di quella piccola somma non dovei piú temere per la sussistenza. In quei deliri di fantasia, l'arte che mi si prepresentava come la piú propria per farmi campare, era quella del domacavalli, in cui sono o mi par d'essere maestro; ed è certamente una delle meno servili. Ed anche mi sembrava che questa dovesse riuscirmi la piú combinabile con quella di poeta, potendosi assai piú facilmente scriver tragedie nella stalla che in corte.
Ma già , prima di trovarmi in queste angustie piú immaginate che vere, appena ebbi fatta la donazione, io avea congedato tutti i miei servi meno uno per me, ed uno per cucinarmi; che poco dopo anche licenziai. E da quel punto in poi, benché io fossi già assai parco nel vitto, contrassi l'egregia e salutare abitudine di una sobrietà non comune; lasciato interamente il vino, il caffè, e simili, e ristrettomi ai semplicissimi cibi di riso, e lesso, ed arrosto, senza mai variare le specie per anni interi. Dei cavalli, quattro ne avea rimandati a Torino perché si vendessero con quelli che ci avea lasciati partendone; ed altri quattro li regalai ciascuno a diversi signori fiorentini, i quali benché fossero semplicemente miei conoscenti e non già amici, avendo tuttavia assai meno orgoglio di me gli accettarono. Tutti gli abiti parimenti donai al mio cameriere, ed allora poi anche sagrificai l'uniforme; e indossai l'abito nero per la sera, e un turchinaccio per la mattina, colori che non ho poi deposti mai piú, e che mi vestiranno fino alla tomba. E cosà in ogni altro genere mi andai sempre piú restringendo anche anche grettamente al semplicissimo necessario, a tal segno ch'io mi ritrovai ad un medesimo tempo e donator d'ogni cosa ed avaro.
Dispostissimo in questa guisa a tutto ciò che mai mi potrebbe accadere di peggio, non mi tenendo aver altro che quei sei mila zecchini, che subito inabissai in uno dei vitalizi di Francia; ed essendo la mia natura sempre inclinata agli estremi, la mia economia e indipendenza andò a poco a poco tant'oltre, che ogni giorno inventandomi una nuova privazione, caddi nel sordido quasi; e dico quasi, perché pur sempre mutai la camicia ogni giorno, e non trascurai la persona; ma lo stomaco, se a lui toccasse di scrivere la mia vita, tolto ogni quasi, direbbe ch'io m'era fatto sordidissimo. E questo fu il secondo, e crederei l'ultimo accesso di un sà fastidioso e sà turpe morbo che degrada pur tanto l'animo, e l'intelletto restringe. Ma benché ogni giorno andassi sottilizzando per negarmi o diminuirmi una qualche cosa, io andava pure spendendo in libri, e non poco. Raccolsi allora quasi tutti i libri nostri di lingua, ed in copia le piú belle edizioni dei cla...
[Pagina successiva]