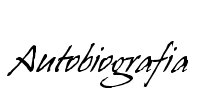[Pagina precedente]...enno, i cavalli mi aveano a gran passi ricondotto all'asino mio primitivo. E tanto mi era già di bel nuovo irrugginita la mente, ch'io mi riputava ora mai nella totale impossibilità di nulla piú ideare, né scrivere.
CAPITOLO DECIMOTERZO
Breve soggiorno in Torino. Recita uditavi della Virginia.
In Torino ebbi alcuni piaceri, e alcuni piú dispiaceri. Il rivedere gli amici della prima gioventú, ed i luoghi che primi si son conosciuti, ed ogni pianta, ogni sasso, in somma ogni oggetto di quelle idee e passioni primitive, ell'è dolcissima cosa. Per altra parte poi, l'avere io ritrovati non pochi di quei compagnoni d'adolescenza, i quali vedendomi ora venire per una via, di quanto potean piú lontano mi scantonavano; ovvero, presi alle strette, gelidamente appena mi salutavano, od anche voltavano il viso altrove; gente, a cui io non aveva fatto mai nulla, se non se amicizia e cordialità ; questo mi amareggiò non poco; e piú mi avrebbe amareggiato, se non mi fosse stato detto da altri pochi e benevoli, che gli uni mi trattavan cosà perché io aveva scritto tragedie; gli altri, perché avea viaggiato tanto; gli altri, perché ora io era ricomparito in paese con troppi cavalli: piccolezze in somma; scusabili però, e scusabilissime presso chiunque conosce l'uomo esaminando imparzialmente sé stesso: ma cose da scansarsi per quanto è possibile, col non abitare fra i suoi nazionali, allorché non si vuol fare quel che essi fanno o non fanno; allorché il paese è piccolo, ed oziosi gli abitanti; ed allorché finalmente si è venuto ad offenderli involontariamente, anche col solo tentare di farsi dappiú di loro, qualunque sia il genere e il modo in cui l'uomo abbia tentato tal cosa.
Un altro amarissimo boccone che mi convenne inghiottire in Torino, fu di dovermi indispensabilmente presentare al re, il quale per certo si teneva offeso da me, per averlo io tacitamente rinnegato coll'espatriazione perpetua. Eppure, visti gli usi del paese, e le mie stesse circostanze, io non mi poteva assolvere dal fargli riverenza, ed ossequio, senza riportarne la giusta taccia di stravagante e insolente e scortese. Appena io giunsi in Torino, che il mio buon cognato, allora primo gentiluomo di camera, ansiosamente subito mi tastò per vedere se io mi presenterei a corte, o no. Ma io immediatamente lo acquetai e racconsolai col dirgli positivamente di sÃ; ed egli insistendo sul quando, non volli differire. Fui il giorno dopo dal ministro. Il mio cognato già mi avea prevenuto, che in quel punto le disposizioni di quel governo erano ottime per me; onde sarei molto ben ricevuto; ed aggiunse anco che si avea voglia d'impiegarmi. Questo non meritato né aspettato favore mi fece tremare; ma l'avviso mi servà assai, per tener tal contegno e discorso da non mi fare né prendere né invitare. Io dissi dunque al ministro, che passando per Torino credeva del mio dovere di visitare lui ministro, e di richiedere per mezzo suo di rassegnarmi al re, semplicemente per inchinarmegli. Il ministro con blande maniere mi accolse, e direi quasi che mi festeggiò. E di una parola in un'altra mi venne lasciato travedere da prima, e poi mi disse apertamente: che al re piacerebbe ch'io mi volessi fissare in patria; che si varrebbe volentieri di me; ch'io mi sarei potuto distinguere; e simili frasche. Tagliai a dirittura nel vivo, e senza punto tergiversare risposi: che io ritornava in Toscana per ivi proseguire le mie stampe e i miei studi; ch'io mi trovava avere trentacinque anni, età in cui non si dee oramai piú cangiare di proposito; che avendo io abbracciata l'arte delle lettere, o bene o male la praticherei per tutto il rimanente di vita mia. Egli soggiunse: che le lettere erano belle e buone, ma che esistevano delle occupazioni piú grandi e piú importanti, di cui io era e mi dovea sentir ben capace. Ringraziai cortesemente, ma persistei nel no; ed ebbi anche la moderazione e la generosità di non dare a quel buon galantuomo l'inutile mortificazione, ch'egli si sarebbe pur meritata; di lasciargli cioè intendere, che i loro dispacci e diplomazie mi pareano, ed eran per certo, assai meno importante ed alta cosa che non le tragedie mie o le altrui. Ma questa specie di gente è, e dev'essere, inconvertibile. Ed io, per natura mia, non disputo mai, se non se raramente con quelli con cui concordiamo di massima; agli altri ogni cosa io la do vinta alla prima. Mi contentai dunque di non acconsentire. Questa mia resistenza negativa verisimilmente poi passò sino al re pel canal del ministro; onde il giorno dopo, ch'io vi fui a inchinarlo, il re non mi parlò punto di questo, e del rimanente mi accolse colla massima affabilità e cortesia, che gli è propria. Questi era (ed ancora regna) Vittorio Amedeo II, figlio di Carlo Emanuele, sotto il cui regno io nacqui. Ancorché io non ami punto i re in genere, e meno i piú arbitrari, debbo pur dire ingenuamente che la razza di questi nostri principi è ottima sul totale, e massime paragonandola a quasi tutte l'altre presenti d'Europa. Ed io mi sentiva nell'intimo del cuore piuttosto affetto per essi, che non avversione; stante che sà questo re che il di lui predecessore, sono di ottime intenzioni, di buona e costumata ed esemplarissima indole e fanno al paese loro piú bene che male. Con tutto ciò quando si pensa e vivamente si sente che il loro giovare o nuocere pendono dal loro assoluto volere, bisogna fremere, e fuggire. E cosà feci io dopo alcuni giorni, quanti bastarono per rivedere i miei parenti e conoscenti in Torino, e trattenermi piacevolmente e utilmente per me le piú ore di quei pochi giorni coll'incomparabile amico, l'abate di Caluso, che un cotal poco mi riassestò anche il capo, e mi riscosse dal letargo in cui la stalla mi avea precipitato, e quasi che sepellito.
Nel trattenermi in Torino mi toccò di assistere (senza ch'io n'avessi gran voglia) ad una recita pubblica della mia Virginia, che fu fatta su lo stesso teatro, nove anni dopo quella della Cleopatra, da attori a un bel circa della stessa abilità . Un mio amico già d'Accademia avea preparata questa recita già prima ch'io arrivassi a Torino, e senza sapere ch'io ci capiterei. Egli mi chiese di volermi adoprare nell'addestrare un tal poco gli attori; come avea fatto già per la Cleopatra. Ma io, cresciuto forse alquanto di mezzi, e molto piú di orgoglio, non mi ci volli prestare in nulla, conoscendo benissimo quel che siano finora ed i nostri attori, e le nostre platee. Non mi volli dunque far complice a nessun patto della loro incapacità , che senza averli sentiti ella mi era già cosa dimostratissima. Sapeva, che avrebbe bisognato cominciare dall'impossibile; cioè dall'insegnar loro a parlare e pronunziar italiano, e non veneziano; a recitar essi, e non il rammentatore; ad intendere (troppo sarebbe pretendere, s'io dicessi a sentire), ma ad intendere semplicemente quello che volean far intendere all'uditorio. Non era poi dunque sà irragionevole il mio niego, né si indiscreto il mio orgoglio. Lasciai dunque che l'amico ci pensasse da sé, e condiscesi soltanto col promettergli a mal mio grado d'assistervi. Ed in fatti ci fui, già ben convinto in me stesso, che di vivente mio non v'era da raccogliere per me in nessunissimo teatro d'Italia, né lode né biasimo. La Virginia ottenne per l'appunto la stessa attenzione, e lo stessissimo esito che avea già ottenuta la Cleopatra; e fu richiesta per la sera dopo, né piú né meno di quella; ed io, come si può credere, non ci tornai. Ma da quel giorno cominciò in gran parte quel mio disinganno di gloria, in cui mi vo di giorno in giorno sempre piú confermando. Con tutto ciò non mi rimoverò io dall'abbracciato proposito di tentare ancora per altri dieci o quindici anni all'incirca, sin sotto ai sessanta cioè, di scrivere in due o tre altri generi delle nuove composizioni, quanto piú accuratamente e meglio il saprò; per avere, morendo o invecchiando, la intima consolazione di aver soddisfatto a me stesso, ed all'arte quant'era in me. Che quanto ai giudizi degli uomini presenti, atteso lo stato in cui si trova l'arte critica in Italia, ripeto piangendo, che non v'è da sperare né ottenere per ora, né lode né biasimo. Che io non reputo lode, quella che non discerne, e motivando sé stessa inanima l'autore; né biasimo chiamo, quello che non t'insegna a far meglio.
Io patii morte a codesta recita della Virginia, piú ancora che a quella di Cleopatra, ma per ragioni troppo diverse. Né piú esattamente le voglio allegare ora qui; poiché a chi ha ed il gusto e l'orgoglio dell'arte, elle già sono notissime; per chi non l'ha, elle riuscirebbero inutili ed inconcepibili.
Partito di Torino, mi trattenni tre giorni in Asti presso l'ottima rispettabilissima mia madre. Ci separammo poi con gran lagrime, presagendo ambedue che verisimilmente non ci saremmo piú riveduti. Io non dirò che mi sentissi per lei quanto affetto avrei potuto e dovuto; atteso che dall'età di nov'anni in poi non mi era mai piú trovato con essa, se non se alla sfuggita per ore. Ma la mia stima, gratitudine, e venerazione per essa e per le di lei virtú è stata sempre somma, e lo sarà finch'io vivo. Il Cielo le accordi lunga vita, poich'ella sà bene la impiega in edificazione e vantaggio di tutta la sua città . Essa poi è oltre ogni dire sviscerata per me, piú assai ch'io non abbia mai meritato. Perciò il di lei vero ed immenso dolore nell'atto della nostra dipartenza grandemente mi accorò, ed accora.
Appena uscito io poi dagli stati del re sardo, mi sentii come allargato il respiro: cotanto mi pesava tuttavia tacitamente sul collo anche l'avanzo stesso di quel mio giogo natio, ancorché infranto lo avessi. Talché il poco tempo ch'io vi stetti, ogni qualvolta mi dovei trovare con alcuno dei barbassori governanti di quel paese, io mi vi teneva piuttosto in aspetto di liberto che non d'uomo libero; sempre rammentandomi quel bellissimo detto di Pompeo nello scendere in Egitto alla discrezione ed arbitrio d'un Fotino: "Chi entra in casa del tiranno, s'egli schiavo non era si fa". CosÃ, chi per mero ozio e vaghezza rientra nel già disertato suo carcere, vi si può benissimo ritrovar chiuso all'uscirne, finché pur carcerieri rimangonvi.
Inoltrandomi intanto verso Modena, le nuove ch'io avea ricevute dalla mia donna mi andavano riempiendo or di dolore, ora di speranza, e sempre di molta incertezza. Ma l'ultime ricevute in Piacenza mi annunziavano finalmente la di lei liberazione di Roma, il che mi empiva d'allegrezza; poiché Roma era per allora il sol luogo dove non l'avrei potuta vedere, ma per altra parte la convenienza con catene di piombo mi vietava assolutamente, anche in quel punto, di seguitarla. Ella aveva con mille stenti, e con dei sacrifici pecuniari non piccioli verso il marito, ottenuto finalmente dal cognato, e dal papa, la licenza di portarsi negli Svizzeri all'acque di Baden; trovandosi per i molti disgusti la di lei salute considerabilmente alterata. In quel giugno dunque dell'anno 1784 ell'erasi partita di Roma, e bel bello lungo la spiaggia dell'Adriatico, per Bologna e Mantova e Trento, si avviava verso il Tirolo, nel tempo stesso che io partitomi di Torino, per Piacenza, Modena e Pistoia me ne ritornava a Siena. Questo pensiero, di essere allora cosà vicino a lei, per tosto poi di bel nuovo rimanere cosà disgiunti e lontani, mi riusciva ad un tempo e piacevole e doloroso. Avrei benissimo potuto mandar per la diritta in Toscana il mio legno e la mia gente, ed io a traverso per le poste a cavallo soletto l'avrei potuta presto raggiungere, e almen l'avrei vista. Desiderava, temeva, sperava, voleva, disvoleva: vicende tutte ben note ai pochi e veraci amatori; ma vinse pur finalmente il dovere, e l'amore di essa e del di lei decoro, piú che di me. Onde, bestemmiando e piangendo, non mi scartai punto dalla strada mia. Cosà sotto il peso gravissimo di questa mia dolorosa vittoria giunsi in Siena dopo dieci mesi in circa di viaggio; e ritrovai nell'amico Gori l'usato mio necessarissimo conforto, onde andarvi pure strascinando la vita, e stancando oramai...
[Pagina successiva]