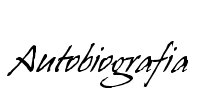[Pagina precedente]...là il libro saltai a sedere sul letto, dov'io giaceva nel leggere; ed impugnata con ira la penna, ad alta voce gridando dissi a me stesso: "Plinio mio, se tu eri davvero e l'amico, e l'emulo, e l'ammiratore di Tacito, ecco come avresti dovuto parlare a Traiano". E senza piú aspettare, né riflettere, scrissi d'impeto, quasi forsennato, cosà come la penna buttava, circa quattro gran pagine del mio minutissimo scritto; finché stanco, e disebriato dallo sfogo delle versate parole, lasciai di scrivere, e quel giorno non vi pensai piú. La mattina dopo, ripigliato il mio Plinio, o per dir meglio, quel Plinio che tanto mi era scaduto di grazia nel giorno innanzi, volli continuar di leggere il di lui Panegirico. Alcune poche pagine piú, facendomi gran forza, ne lessi; poi non mi fu possibile di proseguire, Allora volli un po' rileggere quello squarcione del mio Panegirico, ch'io avea scritto delirando la mattina innanzi. Lettolo, e piaciutomi, e rinfiammato piú di prima, d'una burla ne feci, o credei farne, una cosa serissima; e distribuito e diviso alla meglio il mio tema, senza piú ripigliar fiato, scrivendone ogni mattina quanto ne potevan gli occhi, che dopo un par d'ore di entusiastico lavoro non mi fanno piú luce; e pensandovi poi e ruminandone tutto l'intero giorno, come sempre mi accade allorché non so chi mi dà questa febbre del concepire e comporre; me lo trovai tutto steso nella quinta mattina, dal dà 13 al 17 di marzo! e, con pochissima varietà , toltone l'opera della lima, da quello che va dattorno stampato.
Codesto lavoro mi avea riacceso l'intelletto, ed una qualche tregua avea pur anche data ai miei tanti dolori. Ed allora mi convinsi per esperienza, che a voler tollerare quelle mie angustie d'animo, ed aspettarne il fine senza soccombere, mi era piú che necessario di farmi forza, e costringer la mente ad un qualche lavoro. Ma siccome la mente mia, piú libera e piú indipendente di me, non mi vuole a niun conto obbedire; tal che, se io mi fossi proposto, prima di leggere il Plinio, di voler fare un panegirico a Traiano, non avrebbe essa forse voluto raccozzar due idee; per ingannare ad un tempo e il dolore e la mente, trovai il compenso di violentarmi in una qualche opera di pazienza, e di schiena come si suol dire. Perciò tornatomi fra mani quel Sallustio che circa dieci anni prima aveva tradotto in Torino per semplice studio, lo feci ricopiare col testo accanto, e mi posi seriamente a correggerlo, coll'intenzione e speranza ch'egli riuscisse una cosa. Ma neppure per questo pacifico lavoro io sentiva il mio animo capace di continua e tranquilla applicazione; onde non lo migliorai di gran fatto, anzi mi avvidi, che nel bollore e deliri d'un cuore preoccupato e scontento, riesce forse piú possibile il concepire e creare una cosa breve e focosa, che non il freddamente limare una cosa già fatta. La lima è un tedio, onde facilmente si pensa ad altro, adoprandola. La creazione è una febbre, durante l'accesso, non si sente altro che lei. Lasciato dunque il Sallustio a tempi piú lieti, mi rivolsi a continuar quella prosa Del principe e delle lettere, da me ideata, e distribuita piú anni prima in Firenze. Ne scrissi allora tutto il primo libro, e due o tre capitoli del secondo.
Fin dall'estate antecedente, al mio tornare d'Inghilterra in Siena, io aveva pubblicato il terzo volume delle tragedie, e mandatolo, come a molti altri valentuomini d'Italia, anche all'egregio Cesarotti, pregandolo di darmi un qualche lume sovra il mio stile e composizione e condotta. Ne ricevei in quell'aprile una lettera critica su le tre tragedie del terzo volume, alla quale risposi allora brevemente, ringraziandolo, e notando le cose che mi pareano da potersi ribattere; e ripregandolo di indicarmi o darmi egli un qualche modello di verso tragico. E da notarsi su ciò, che quello stesso Cesarotti, il quale aveva concepiti ed eseguiti con tanta maestria i sublimi versi dell'Ossian, essendo stato richiesto da me, quasi due anni prima, di volermi indicare un qualche modello di verso sciolto di dialogo, egli non si vergognò di parlarmi d'alcune sue traduzioni dal francese, della Semiramide e del Maometto di Voltaire, stampate già da molti anni; e di tacitamente propormele per modello. Queste traduzioni del Cesarotti essendo in mano di chiunque le vorrà leggere, non occorre ch'io aggiunga riflessioni su questo particolare; ognuno se ne può far giudice e paragonare quei versi tragici con i miei; e paragonarli anche con i versi epici dello stesso Cesarotti nell'Ossian, e vedere se paÃano della stessa officina. Ma questo fatto servirà pure a dimostrare quanto miserabil cosa siamo noi tutti uomini, e noi autori massimamente, che sempre abbiam fra le mani e tavolozza e pennello per dipingere altrui, ma non mai lo specchio per ben rimirarci noi stessi e conoscerci.
Il giornalista di Pisa, dovendo poi dare o inserire nel suo giornale un giudizio critico su quel mio terzo tomo delle tragedie, stimò piú breve e piú facil cosa il trascrivere a dirittura quella lettera del Cesarotti, con le mie note che le servono di risposta. Io mi trattenni in Pisa sino a tutto l'agosto di quell'anno 1785; e non vi feci piú nulla da quelle prose in poi, fuorché far ricopiare le dieci tragedie stampate, ed apporvi in margine molte mutazioni, che allora mi parvero soverchie; ma quando poi venni a ristamparle in Parigi, elle mi vi parvero piú che insufficienti, e bisognò per lo meno quadruplicarle. Nel maggio di quell'anno godei in Pisa del divertimento del Giuoco del Ponte, spettacolo bellissimo, che riunisce un non so che di antico e d'eroico. Vi si aggiunse anco un'altra festa bellissima d'un altro genere, la luminara di tutta la detta città , come si costuma ogni due anni per la festa di San Ranieri. Queste feste si fecero allora riunitamente, all'occasione della venuta del re e regina di Napoli in Toscana per visitarvi il gran duca Leopoldo, cognato del suddetto re. La mia vanaglorietta in quelle feste rimase bastantemente soddisfatta, essendomi io fatto molto osservare a cagione de' miei be' cavalli inglesi, che vincevano in mole, bellezza e brio quanti altri mai cavalli vi fossero capitati in codest'occasione. Ma in mezzo a quel mio fallace e pueril godimento, mi convinsi con sommo dolore ad un tempo stesso, che nella fetida e morta Italia ella era assai piú facil cosa il farsi additare per via di cavalli, che non per via di tragedie.
CAPITOLO DECIMOSESTO
Secondo viaggio in Alsazia, dove mi fisso. Ideativi, e stesi i due Bruti, e l'Abele. Studi caldamente ripigliati.
In questo frattempo era ripartita di Bologna la mia donna, ed avviatasi verso Parigi nel mese di aprile. Non volendo essa tornare a Roma, in nessun altro luogo ella potea piú convenientemente fissarsi che in Francia, dove avea parenti, aderenze, e interessi. Trattenutasi in Parigi sino all'agosto inoltrato, ella ritornò in Alsazia in quella stessa villa dove c'eramo incontrati l'anno innanzi. Onde io ai primi di settembre con infinita gioia e premura mi vi avviai per la solita strada dell'Alpi tirolesi. Ma l'aver perduto l'amico di Siena, e l'essersi oramai la mia donna traspiantata fuori d'Italia, mi fece anche risolvere di non dimorarci piú neppur io. E benché per allora né volessi, né convenisse ch'io mi fissassi a dimora dove ella, io cercai pure di starle il meno lontano ch'io potessi, e di toglierci almeno l'Alpi di mezzo. Feci dunque muovere anche tutta la mia cavalleria, che sana e salva arrivò un mese dopo di me in Alsazia, dove allora ebbi raccolto ogni mia cosa, fuorché i libri, che i piú gli avea lasciati in Roma. Ma la mia felicità derivata da questa seconda riunione non durò né potea durare altro che due mesi in circa, dovendosi la mia donna restituire in Parigi nell'inverno. Nel decembre l'accompagnai sino a Strasborgo, dove, con mio sommo dolore costretto di lasciarla, me ne separai per la terza volta; ella continuò la sua strada per Parigi, io ritornai nella nostra villa. Ancorché io fossi scontento, pure la mia afflizione riusciva ora assai minore della passata, trovandoci piú vicini, Potendo senza ostacolo, e senza pericolo di nuocerle dare una scorsa per vederla, ed avendo in somma fra noi la certezza di rivederci nella prossima estate. Tutte queste speranze mi posero un tal balsamo in corpo, e mi rischiarirono talmente l'intelletto, che di bel nuovo intieramente mi diedi in braccio alle Muse. In quel solo inverno, nella quiete e libertà della villa, feci assai piú lavoro che non avessi fatto mai in cosà breve spazio di tempo; cotanto la continuità del pensare ad una stessa cosa, e a non aver divagazioni né dispiaceri, abbreviandoci l'ore ad un tempo ce le moltiplica. Appena tornato nel mio ritiro, da prima finii di stendere l'Agide, che fin dal decembre precedente avea cominciato in Pisa; poi infastidito del lavoro (cosa che non mi accadeva mai nel creare) non lo avea piú potuto proseguire. Finitolo ora felicemente, senza pigliar piú respiro stesi in quello stesso decembre la Sofonisba e la Mirra. Quindi in gennaio finii interamente di stendere il secondo e terzo libro Del principe e delle lettere; ideai e stesi il dialogo Della virtú sconosciuta; tributo che da gran tempo mi rimproverava di non aver pagato alla adorata memoria del degnissimo amico Gori; e ideai inoltre, e distesi tutta, e verseggiai la parte lirica dell'Abele tramelogedia; genere di cui mi occorrerà di parlare in appresso, se avrò vita e mente e mezzi da effettuare quanto mi propongo di eseguire. Postomi quindi al far versi, non abbandonai piú quel mio poemetto ch'io non l'avessi interamente terminato col quarto canto; e quindi dettati, ricorretti, e riannestati insieme i tre altri, che nello spazio di dieci anni essendo stati scritti a pezzi, aveano (e forse tuttora serbano) un non so che di sconnesso; il che tra i miei molti difetti non suole però avvenirmi nelle altre composizioni. Appena era finito il poema, mi accadde che in una delle tante e sempre a me graditissime lettere della mia donna, essa come a caso mi accennava di aver assistito in teatro ad una recita del Bruto di Voltaire, e che codesta tragedia le era sommamente piaciuta. Io, che l'aveva veduta recitare forse dieci anni prima, e che non me ne ricordava punto, riempiutomi istantaneamente di una rabida e disdegnosa emulazione sà il cuor che la mente, dissi fra me: "Che Bruti, che Bruti di un Voltaire? io ne farò dei Bruti, e li farò tutt'e due: il tempo dimostrerà poi, se tali soggetti di tragedia si addicessero meglio a me, o ad un francese nato plebeo, e sottoscrittosi nelle sue firme per lo spazio di settanta e piú anni: Voltaire gentiluomo ordinario del re". Né altro dissi, né di questo toccai pur parola nel rispondere alla mia donna; ma subitamente d'un lampo ideai ad un parto i due Bruti, quali poi li ho eseguiti. In questo modo uscii per la terza volta dal mio proposito di non far piú tragedie; e da dodici ch'essere doveano, son arrivate a diciannove. Su l'ultimo Bruto rinnovai poi il giuramento ad Apolline piú solenne ch'io non l'avessi fatto mai, e questo io son quasi certo di non l'aver piú ad infrangere. Gli anni che mi si vanno ammontando sul tergo me n'entrano quasi mallevadori; e le tante altre cose di altro genere che mi restan da fare, se pure farle potrò e saprò.
Dopo aver passati cinque e piú mesi in villa in un continuo bollore di mente, poiché appena sveglio la mattina per tempissimo io scriveva cinque o sei pagine alla mia donna; poi lavorava fino alle due o le tre dopo mezzogiorno; poi andando o a cavallo, o in biroccio per un par d'ore, in vece di divagarmi e riposarmi, pel continuo pensare ora a quel verso, ora a quel personaggio, ora ad altro, mi affaticava assai piú l'intelletto che non lo sollevassi; mi ritrovai perciò nell'aprile una fierissima podagra a ridosso, la quale m'inchiodò per la prima volta in letto, e mi vi tenne immobile e addoloratissimo per quindici giorni almeno, e pose cosà una spiacevole interruzione ai miei studi sà caldamente avviati. Ma troppo avea impreso...
[Pagina successiva]