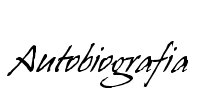[Pagina precedente]... trasmutavano in oggetto di tristezza e squallore allo sbarcare fra certe strade, intere isole di muriccie avanzi del terremoto, accatastate e spartite allineate a guisa di isole di abitati edifizi. E di cotali strade se ne vedevano ancora moltissime nella parte bassa della città , benché fossero già oramai trascorsi quindici anni dopo quella funesta catastrofe.
Quel mio breve soggiorno in Lisbona di circa cinque settimane, sarà per me un'epoca sempre memorabile e cara, per avervi io imparato a conoscere l'abate Tommaso di Caluso, fratello minore del conte Valperga di Masino allora nostro ministro in Portogallo. Quest'uomo, raro per l'indole, i costumi e la dottrina, mi rendé delizioso codesto soggiorno, a segno che, oltre al vederlo per lo piú ogni mattina a pranzo dal fratello, anche le lunghe serate dell'inverno io preferiva pure di passarmele intere da solo a solo con lui, piuttosto che correre attorno pe' divertimenti sciocchissimi del gran mondo. Con esso io imparava sempre qualche cosa, e tanta era la di lui bontà e tolleranza, che egli sapea per cosà dire alleggerirmi la vergogna ed il peso della mia ignoranza estrema, la quale tanto piú fastidiosa e stomachevole gli dovea pur comparire, quanto maggiore ed immenso era in esso il sapere. Cosa che, non mi essendo fin allora accaduta con nessuno dei non molti letterati ch'io avessi dovuti trattare, me li avea fatti tutti prendere a noia. E ben dovea essere cosÃ, non essendo in me niente minore l'orgoglio, che l'ignoranza. Fu in una di quelle dolcissime serate, ch'io provai nel piú intimo della mente e del cuore un impeto veramente febeo, di rapimento entusiastico per l'arte della poesia; il quale pure non fu che un brevissimo lampo, che immediatamente si tornò a spegnere, e dormà poi sotto cenere ancora degli anni ben molti. Il degnissimo e compiacentissimo abate mi stava leggendo quella grandiosa ode del Guidi alla Fortuna, poeta, di cui sino a quel giorno io non avea neppur mai udito il nome. Alcune stanze di quella canzone, e specialmente la bellissima di Pompeo, mi trasportarono a un segno indicibile, talché il buon abate si persuase e mi disse che io era nato per far dei versi, e che avrei potuto, studiando, pervenire a farne degli ottimi. Ma io, passato quel momentaneo furore, trovandomi cosà irrugginite tutte le facoltà della mente, non la credei oramai cosa possibile, e non ci pensai altrimenti.
Intanto l'amicizia e la soave compagnia di quell'uomo unico, che è un Montaigne vivo, mi giovò assaissimo a riassestarmi un poco l'animo; onde, ancorché non mi sentissi del tutto guarito, mi riavvezzai pure a poco a poco a leggicchiare, e riflettere, assai piú che non avessi ciò fatto da circa diciotto mesi. Quanto poi alla città di Lisbona, dove non mi sarei trattenuto neppur dieci giorni, se non fosse stato l'abate, nulla me ne piacque fuorché in generale le donne, nelle quali veramente abonda il lubricus adspici di Orazio. Ma, essendomi ridivenuta mille volte piú cara la salute dell'animo che quella del corpo, io mi studiai e riuscii di sfuggire sempre le oneste.
Verso i primi di febbraio partii alla volta di Siviglia e di Cadice; né portai meco altra cosa di Lisbona, se non se una stima ed amicizia somma pel suddetto abate di Caluso, ch'io sperava di riveder poi, quando che fosse, in Torino. Di Siviglia me ne andò a genio il bel clima, e la faccia originalissima spagnuolissima che tuttavia conservavasi codesta città sovra ogni altra del regno. Ed io sempre ho preferito originale anche tristo ad ottima copia. La nazione spagnuola, e la portoghese, sono in fatti quasi oramai le sole di Europa che conservino i loro costumi, specialmente nel basso e medio ceto. E benché il buono vi sia quasi naufrago in un mare di storture di ogni genere che vi predominano, io credo tuttavia quel popolo una eccellente materia prima per potersi addirizzar facilmente ad operar cose grandi, massimamente in virtú militare; avendone essi in sovrano grado tutti gli elementi; coraggio, perseveranza, onore, sobrietà , obbedienza, pazienza, ed altezza d'animo.
In Cadice terminai il carnevale bastantemente lieto. Ma mi avvidi alcuni giorni dopo esserne partito alla volta di Cordova, che riportato n'avea meco delle memorie gaditane, che alcun tempo mi durerebbero. Quelle ferite poco gloriose mi amareggiarono assai quel lunghissimo viaggio da Cadice a Torino, ch'io intrapresi di fare d'un sol fiato cosà ad oncia ad oncia per tutta la lunghezza della Spagna sino ai confini di Francia, di dove già v'era entrato. Ma pure a forza di robustezza, ostinazione e sofferenza, cavalcando, sfangando a piedi, e strapazzandomi d'ogni maniera, arrivai, assai mal concio, a dir vero, a Perpignano, di dove poi continuando per le poste ebbi a soffrir molto meno. In quel gran tratto di terra i due soli luoghi che mi diedero una qualche soddisfazione, furono Cordova e Valenza: massimamente poi tutto il regno di Valenza, che misurai per lo lungo sul finir di marzo, ed era per tutto una primavera tepida e deliziosissima, di quelle veramente descritte dai poeti. Le adiacenze poi e i passeggi, e le limpide acque, e la posizione locale della città di Valenza, e il bellissimo azzurro del di lei cielo, e un non so che di elastico ed amoroso nell'atmosfera; e donne i di cui occhi protervi mi faceano bestemmiare le gaditane; e un tutto, insomma, sà fatto mi si appresentò in quel favoloso paese, che nessun'altra terra mi ha lasciato un tale desiderio di sé, né mi si riaffaccia sà spesso alla fantasia quanto codesta.
Giunto per la via di Tortosa una seconda volta in Barcellona, e tediatissimo del viaggiare a cosà lento passo, feci il gran distacco dal mio bellissimo cavallo andaluso, che per essere molto affaticato da quest'ultimo viaggio di trenta e piú giorni consecutivi da Cadice a Barcellona, non lo volea strapazzar maggiormente col farmelo trottar dietro il legno quando sarei partito per Perpignano a marcia duplicata. L'altro mio cavallo, il cordovesino, essendomisi azzoppito fra Cordova e Valenza, piuttosto che trattenermi due giorni che forse si sarebbe riavuto, lo avea regalato alle figlie di una ostessa molto belline, raccomandandolo che se lo curavano e gli davano un po' di riposo, rinsanito lo venderebbero benissimo; né mai piú ne seppi altro. Quest'ultimo dunque rimastomi, non lo volendo io vendere, perché sono per natura nemicissimo del vendere, lo regalai ad un banchiere francese domiciliato in Barcellona, già mio conoscente sin dalla mia prima dimora in codesta città . E qui, per definire e dimostrare quel che sia il cuore di un pubblicano, aggiungerò una particolarità . Essendomi rimaste di piú forse un trecento doppie d'oro di Spagna, che attese le severe perquisizioni che si fanno alle dogane di frontiera all'uscire di Spagna, difficilmente forse le avrei potute estrarre, sendo cosa proibita; richiesi al su detto banchiere, dopo avergli regalato il cavallo, che mi desse una cambiale di codesta somma pagabile a vista in Monpellieri di dove mi toccava passare. Ed egli, per testificarmi la sua gratitudine, ricevute le mie doppie sonanti, mi concepà la cambiale in tutto quel massimo rigore di cambio che facea in quella settimana; talché poi a Monpellieri riscotendo la somma in luigi, mi trovai aver meno circa il sette per cento di quello ch'io avrei ricavato se vi avessi portate e scambiate le mie doppie effettive. Ma io non avea neppur bisogno di aver provato questa cortesia banchieresca per fissare la mia opinione su codesta classe di gente, che sempre mi è sembrata l'una delle piú vili e pessime del mondo sociale; e ciò tanto piú, quanto essi si van mascherando da signori, e mentre vi danno un lauto pranzo in casa loro per fasto, vi spogliano per uso d'arte al loro banco; e sempre poi sono pronti ad impinguarsi delle calamità pubbliche. A fretta in furia, facendo con danari bastonare le tardissime mule, mi portai dunque in due giorni soli da Barcellona a Perpignano, dove ce n'avea impiegati quattro al venire. E la fretta poi mi era sà fattamente rientrata addosso, che di Perpignano in Antibo volando per le poste, non mi trattenni mai, né in Narbona, né in Monpellieri, né in Aix. Ed in Antibo subito imbarcatomi per Genova, dove solo per riposarmi soggiornai tre giorni, di là mi restituiva in patria due altri giorni trattenendomi presso mia madre in Asti; e quindi, dopo tre anni di assenza, in Torino, dove giunsi il dà quinto di maggio dell'anno 1772. Nel passare di Monpellieri io avea consultato un chirurgo di alto grido, su i miei incommodi incettati in Cadice. Costui mi ci volea far trattenere; ma io, fidandomi alquanto su l'esperienza che avea oramai contratta di simili incommodi, e sul parere del mio Elia, che di queste cose intendeva benissimo, e mi avea già altre volte perfettamente guarito in Germania, ed altrove; senza dar retta all'ingordo chirurgo di Monpellieri, avea proseguito, come dissi, il mio viaggio rapidissimamente. Ma lo strapazzo stesso di due mesi di viaggio avea molto aggravato il male. Onde al mio arrivo in Torino, sendo assai mal ridotto, ebbi che fare quasi tutta l'estate per rimettermi in salute. E questo fu il principal frutto dei tre anni di questo secondo mio viaggio.
CAPITOLO DECIMOTERZO
Poco dopo essere rimpatriato, incappo nella terza rete amorosa. Primi tentativi di poesia.
Ma benché agli occhi dei piú, ed anche ai miei, nessun buon frutto avessi riportato da quei cinque anni di viaggi, mi si erano con tutto ciò assai allargate le idee, e rettificato non poco il pensare; talché, quando il mio cognato mi volle riparlare d'impieghi diplomatici che avrei dovuto sollecitare, io gli risposi: che avendo veduti un pochino piú da presso ed i re, e coloro che li rappresentano, e non li potendo stimare un iota nessuni, io non avrei voluto rappresentarne né anche il Gran Mogol, non che prendessi mai a rappresentare il piú piccolo di tutti i re dell'Europa, qual era il nostro; e che non rimaneva altro compenso a chi si trovava nato in simili paesi, se non se di camparvi del suo, avendovelo, e d'impiegarsi da sé in una qualche lodevole occupazione sotto gli auspici favorevolissimi sempre della beata indipendenza. Questi miei detti fecero torcere moltissimo il muso a quell'ottimo uomo che trovavasi essere uno dei gentiluomini di camera del re; né mai piú avendomi egli parlato di ciò, io pure sempre piú mi confermai nel mio proposito.
Io mi trovava allora in età di ventitré anni; bastantemente ricco, pel mio paese; libero, quanto vi si può essere; esperto, benché cosà alla peggio, delle cose morali e politiche, per aver veduti successivamente tanti diversi paesi e tanti uomini; pensatore, piú assai che non lo comportasse quell'età ; e presumente anche piú che ignorante. Con questi dati mi rimaneano necessariamente da farsi molti altri errori, prima che dovessi pur ritrovare un qualche lodevole ed utile sfogo al bollore del mio impetuoso intollerante e superbo carattere.
In fine di quell'anno del mio ripatriamento, provvistomi in Torino una magnifica casa posta su la piazza bellissima di San Carlo, e ammobigliatala con lusso e gusto e singolarità , mi posi a far vita di gaudente con gli amici, che allora me ne ritrovai averne a dovizia. Gli antichi miei compagni d'Accademia, e di tutte quelle prime scappataggini di gioventú, furono di nuovo i miei intimi; e tra quelli, forse un dodici e piú persone, stringendoci piú assiduamente insieme, venimmo a stabilire una società permanente, con admissione od esclusiva ad essa per via di voti, e regole, e buffonerie diverse, che poteano forse somigliare, ma non erano però, Libera Muratoreria. Né di tal società altro fine ci proponevamo, fuorché divertirci, cenando spesso insieme (senza però nessunissimo scandalo); e del resto nell'adunanze periodiche settimanali la sera, ragionando o sragionando sovra ogni cosa. Tenevansi queste auguste sessioni in casa mia, perché era e piú bella e piú spaziosa di quelle dei compagni, e perché essendovi io solo si rimanea piú liberi. C'era fra questi giovani (che tutti er...
[Pagina successiva]