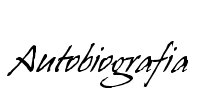[Pagina precedente]...e, dicendomi che gran dovizia di lingua e di modi vi troverei. Il che equivarrebbe a chi proponesse a un pittore di storia di studiare il Callotta. Altri mi lodava lo stile del Metastasio, come l'ottimo per la tragedia. Altri, altro. E nessun di quei dotti era dotto in tragedia.
Nel soggiorno di Pisa tradussi anche la Poetica d'Orazio in prosa con chiarezza e semplicità per invasarmi que' suoi veridici e ingegnosi precetti. Mi diedi anche molto a leggere le tragedie di Seneca, benché in tutto ben mi avvedessi essere quelle il contrario dei precetti d'Orazio. Ma alcuni tratti di sublime vero mi trasportavano, e cercava di renderli in versi sciolti per mio doppio studio, di latino e d'italiano, di verseggiare e grandeggiare. E nel fare questi tentativi mi veniva evidentemente sotto gli occhi la gran differenza tra il verso giambo ed il verso epico, i di cui diversi metri bastano per distinguere ampiamente le ragioni del dialogo da quelle di ogni altra poesia; e nel tempo stesso mi veniva evidentemente dimostrato che noi italiani non avendo altro verso che l'endecasillabo per ogni componimento eroico, bisognava creare una giacitura di parole, un rompere sempre variato di suono, un fraseggiare di brevità e di forza, che venissero a distinguere assolutamente il verso sciolto tragico da ogni altro verso sciolto e rimato sà epico che lirico. I giambi di Seneca mi convinsero di questa verità , e forse in parte me ne procacciarono i mezzi. Che alcuni tratti maschi e feroci di quell'autore debbono per metà la loro sublime energia al metro poco sonante, e spezzato. Ed in fatti qual è sà sprovvisto di sentimento e d'udito, che non noti l'enorme differenza che passa tra questi due versi? L'uno, di Virgilio, che vuol dilettare e rapire il lettore:
Quadrupedante putrem sonitu quatit ungula campum;
l'altro, di Seneca che vuole stupire e atterrir l'uditore; e caratterizzare in due sole parole due personaggi diversi:
Concede mortem.
Si recusares, darem.
Per questa ragione stessa non dovrà dunque un autor tragico italiano nei punti piú appassionati e fieri porre in bocca de' suoi dialogizzanti personaggi dei versi, che quanto al suono in nulla somiglino a quei peraltro stupendi e grandiosissimi del nostro epico:
Chiama gli abitator dell'ombre eterne
il rauco suon della tartarea tromba.
Convinto io nell'intimo cuore della necessità di questa total differenza da serbarsi nei due stili, e tanto piú difficile per noi italiani, quando è giuoco forza crearsela nei limiti dello stesso metro, io dava dunque poco retta ai saccenti di Pisa quanto al fondo dell'arte drammatica, e quanto allo stile da adoprarvisi; gli ascoltava bensà con umiltà e pazienza su la purità toscanesca e grammaticale; ancorché neppure in questo i presenti toscani gran cosa la sfoggino.
Eccomi intanto in meno d'un anno dopo la recita della Cleopatra, possessore in proprio del patrimonietto di tre altre tragedie. E qui mi tocca di confessare, pel vero, di quai fonti le avessi tratte. Il Filippo, nato francese, e figlio di francese, mi venne di ricordo dall'aver letto piú anni prima il romanzo di Don Carlos, dell'Abate di San Reale. Il Polinice, gallo anch'egli, lo trassi dai Fratelli nemici, del Racine. L'Antigone, prima non imbrattata di origine esotica, mi venne fatta leggendo il duodecimo libro di Stazio nella traduzione su mentovata, del Bentivoglio. Nel Polinice l'avere io inserito alcuni tratti presi nel Racine, ed altri presi dai Sette prodi di Eschilo, che leggicchiai nella traduzione francese del padre Brumoy, mi fece far voto in appresso, di non piú mai leggere tragedie d'altri prima d'aver fatte le mie, allorché trattava soggetti trattati, per non incorrere cosà nella taccia di ladro, ed errare o far bene, del mio. Chi molto legge prima di comporre, ruba senza avvedersene, e perde l'originalità , se l'avea. E per questa ragione anche avea abbandonato fin dall'anno innanzi la lettura di Shakespeare (oltre che mi toccava di leggerlo tradotto in francese). Ma quanto piú mi andava a sangue quell'autore (di cui però benissimo distingueva tutti i difetti), tanto piú me ne volli astenere.
Appena ebbi stesa l'Antigone in prosa, che la lettura di Seneca m'infiammò e sforzò d'ideare ad un parto le due gemelle tragedie, l'Agamennone, e l'Oreste. Non mi parea con tutto ciò, ch'elli mi siano riuscite in nulla un furto fatto da Seneca. Nel fin di giugno sloggiai da Pisa, e venni in Firenze, dove mi trattenni tutto il settembre. Mi vi applicai moltissimo all'impossessarmi della lingua parlabile; e conversando giornalmente con fiorentini, ci pervenni bastantemente. Onde cominciai da quel tempo a pensare quasi esclusivamente in quella doviziosissima ed elegante lingua; prima indispensabile base per bene scriverla. Nel soggiorno in Firenze verseggiai per la seconda volta il Filippo da capo in fondo, senza neppur piú guardare quei primi versi, ma rifacendoli dalla prosa. Ma i progressi mi pareano lentissimi, e spesso mi parea anzi di scapitare che di migliorare. Nel corrente di agosto, trovandomi una mattina in un crocchio di letterati, udii a caso rammentare l'aneddoto storico di Don Garzia ucciso dal proprio padre Cosimo I. Questo fatto mi colpÃ; e siccome stampato non è, me lo procurai manoscritto, estratto dai pubblici archivi di Firenze, e fin d'allora ne ideai la tragedia. Continuava intanto a schiccherare molte rime, ma tutte mi riuscivano infelici. E benché non avessi in Firenze nessun amico censore che equivalesse al Tana e al Paciaudi, pure ebbi abbastanza senno e criterio di non ne dar copia a chi che si fosse, e anche la sobrietà di pochissimo andarle recitando. Il mal esito delle rime non mi scoraggiava con tutto ciò; ma bensà convincevami che non bisognava mai restare di leggerne dell'ottime, e d'impararne a memoria, per invasarmi di forme poetiche. Onde in quell'estate m'inondai il cervello di versi del Petrarca, di Dante, del Tasso, e sino ai primi tre canti interi dell'Ariosto; convinto in me stesso, che il giorno verrebbe infallibilmente, in cui tutte quelle forme, frasi, e parole d'altri mi tornerebbero poi fuori dalle cellule di esso miste e immedesimate coi miei propri pensieri ed affetti.
CAPITOLO TERZO
Ostinazione negli studi piú ingrati.
Nell'ottobre tornai in Torino, perché non avea prese le misure necessarie per soggiornare piú lungamente fuor di casa, non già perché io mi presumessi intoscanito abbastanza. Ed anche molte altre frivole ragioni mi fecero tornare. Tutti i miei cavalli lasciati in Torino mi vi aspettavano e richiamavano; passione che in me contrastò lungamente con le Muse, e non rimase poi perdente davvero, se non se piú d'un anno dopo. Né mi premeva allora tanto lo studio e la gloria, che non mi pungesse anco molto a riprese la smania del divertirmi; il che mi riusciva assai piú facile in Torino dove c'avea buona casa, aderenze d'ogni sorta, bestie a sufficienza, divagazioni ed amici piú del bisogno. Malgrado tutti questi ostacoli, non rallentai punto lo studio in quell'inverno; ed anzi mi accrebbi le occupazioni e gl'impegni. Dopo Orazio intero, avea letti e studiati ad oncia ad oncia piú altri autori, e fra questi Sallustio. La brevità ed eleganza di quest'istorico mi avea rapito talmente, che mi accinsi con molta applicazione a tradurlo; e ne venni a capo in quell'inverno. Molto, anzi infinito obbligo io debbo a quel lavoro; che poi piú e piú volte ho rifatto, mutato e limato, non so se con miglioramento dell'opera, ma certamente con molto mio lucro sà nell'intelligenza della lingua latina, che nella padronanza di maneggiar l'italiana.
Era frattanto ritornato di Portogallo l'incomparabile abate Tommaso di Caluso; e trovatomi contro la sua aspettativa ingolfato davvero nella letteratura, e ostinato nello scabroso proposito di farmi autor tragico, egli mi secondò, consigliò, e soccorse di tutti i suoi lumi con benignità e amorevolezza indicibile. E cosà pure fece l'eruditissimo conte di San Raffaele, ch'io appresi in quell'anno a conoscere, e altri coltissimi individui, i quali tutti a me superiori di età , di dottrina, e d'esperienza nell'arte mi compativano pure, ed incoraggivano; ancorché non ne avessi bisogno atteso il bollore del mio carattere. Ma la gratitudine che sovra ogni altra professo e sempre professerò a tutti i suddetti personaggi, si è per aver essi umanamente comportata la mia incomportabile petulanza d'allora; la quale, a dir anche il vero, mi andava però di giorno in giorno scemando, a misura che riacquistava lume.
Sul finir di quell'anno '76, ebbi una grandissima e lungamente sospirata consolazione. Una mattina andato dal Tana, a cui sempre palpitante e tremante io solea portare le mie rime, appena partorite che fossero, gli portai finalmente un sonetto al quale pochissimo trovò che ridire e lo lodò anzi molto come i primi versi ch'io mi facessi meritevoli di un tal nome. Dopo le tante e continue afflizioni ed umiliazioni ch'io avea provate nel leggergli da piú d'un anno le mie sconcie rime, ch'egli da vero e generoso amico senza misericordia nessuna censurava, e diceva il perché e il suo perché mi appagava; giudichi ciascuno qual soave néttare mi giunsero all'anima quelle insolite sincere lodi. Era il sonetto una descrizione del ratto di Ganimede, fatto a imitazione dell'inimitabile del Cassiani sul ratto di Proserpina. Egli è stampato da me il primo tra le mie rime. E invaghito della lode, tosto ne feci anche due altri, tratto il soggetto dalla favola, e imitai anch'essi come il primo, a cui immediatamente anche nella stampa ho voluto poi che seguitassero. Tutti e tre si risentono un po' troppo della loro serva origine imitativa, ma pure (s'io non erro) hanno il merito d'essere scritti con una certa evidenza, e bastante eleganza; quale in somma non mi era venuta mai fin allora. E come tali ho voluto serbarli, e stamparli con pochissime mutazioni molti anni dopo. In seguito poi di quei tre primi sufficienti sonetti, come se mi si fosse dischiusa una nuova fonte, ne scaturii in quell'inverno troppi altri; i piú, amorosi; ma senza amore che li dettasse. Per esercizio mero di lingua e di rime avea impreso a descrivere a parte a parte le bellezze palesi d'una amabilissima e leggiadra signora; né per essa io sentiva neppure la minima favilluzza nel cuore; e forse ci si parrà in quei sonetti piú descrittivi che affettuosi. Tuttavia, siccome non mal verseggiati, ho voluto quasi che tutti conservarli, e dar loro luogo nelle mie rime; dove agli intendenti dell'arte possono forse andare additando i progressi ch'io allora andava facendo gradatamente nella difficilissima arte del dir bene, senza la quale per quanto sia ben concepito e condotto il sonetto, non può aver vita.
Alcuni evidenti progressi nel rimare, e la prosa del Sallustio ridotta a molta brevità con sufficiente chiarezza (ma priva ancora di quella variata armonia, tutta propria sua, della ben concepita prosa), mi aveano ripieno il cuore di ardenti speranze. Ma siccome ogni altra cosa ch'io faceva, o tentava, tutte aveano sempre per primo ed allora unico scopo, di formarmi uno stile proprio ed ottimo per la tragedia, da quelle occupazioni secondarie di tempo in tempo mi riprovava a risalire alla prima. Nell'aprile del '77 verseggiai perciò l'Antigone, ch'io, come dissi, avea ideata e stesa ad un tempo, circa un anno prima, essendo in Pisa. La verseggiai tutta in meno di tre settimane; e parendomi aver acquistata facilità , mi tenni di aver fatto gran cosa. Ma appena l'ebbi io letta in una società letteraria, dove quasi ogni sera ci radunavamo, ch'io ravvedutomi (benché lodato dagli altri) con mio sommo dolore mi trovai veramente lontanissimo da quel modo di dire ch'io avea tanto profondamente fitto nell'intelletto, senza pur quasi mai ritrovarmelo poi nella penna. Le lodi di quei colti amici uditori mi persuasero che forse la tragedia quanto agli affetti e condotta ci fosse; ma i miei orecchi e intelletto mi convinsero ch'ella non c'era quanto allo stile. E nessun altri di ciò poteva a una prima lettura esser giudi...
[Pagina successiva]