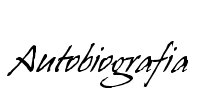[Pagina precedente]...ano ben nati e dei primari della città ) un po' d'ogni cosa; dei ricchi e dei poveri, dei buoni, dei cattivucci, e degli ottimi, degli ingegnosi, degli sciocchetti, e dei colti; onde da sà fatta mistura, che il caso la somministrò ottimamente temperata, risultava che io né vi potea, né avrei voluto potendolo, primeggiare in niun modo, ancorché avessi veduto piú cose di loro. Quindi le leggi che vi si stabilirono furono discusse e non già dettate; e riuscirono imparziali, egualissime, e giuste; a segno che un corpo di persone come eramo noi, tanto potea fondare una ben equilibrata repubblica, come una ben equilibrata buffoneria. La sorte e le circostanze vollero che si fabbricasse piuttosto questa che quella. Si era stabilito un ceppo assai ben capace, dalla di cui spaccatura superiore vi si introducevano scritti d'ogni specie, da leggersi poi dal presidente nostro elettivo ebdomadario, il quale tenea di esso ceppo la chiave. Fra quegli scritti se ne sentivano talvolta alcuni assai divertenti e bizzarri; se ne indovinavano per lo piú gli autori, ma non portavano nome. Per nostra comune e piú mia particolare sventura, quegli scritti erano tutti in (non dirò lingua), ma in parole francesi. Io ebbi la sorte d'introdurre varie carte nel ceppo, le quali divertirono assai la brigata; ed erano cose facete miste di filosofia e d'impertinenza, scritte in un francese che dovea essere almeno non buono, se pure non pessimo, ma riuscivano pure intelligibili e passabili per un uditorio che non era piú dotto di me in quella lingua. E fra gli altri, uno ne introdussi, e tuttavia lo conservo, che fingeva la scena di un Giudizio Universale, in cui Dio domandando alle diverse anime un pieno conto di sé stesse, ci aveva rappresentate diverse persone che dipingevano i loro propri caratteri; e questo ebbe molto incontro perché era fatto con un qualche sale, e molta verità ; talché le allusioni, e i ritratti vivissimi e lieti e variati di molti sà uomini che donne della nostra città , venivano riconosciuti e nominati immediatamente da tutto l'uditorio.
Questo piccolo saggio del mio poter mettere in carta le mie idee quali ch'elle fossero, e di potere, nel farlo, un qualche diletto recare ad altrui, mi andò poi di tempo in tempo saettando un qualche lampo confuso di desiderio e di speranza di scrivere quando che fosse qualcosa che potesse aver vita; ma non mi sapeva neppur io quale potrebbe mai essere la materia, vedendomi sprovvisto di quasi tutti i mezzi. Per natura mia prima prima, a nessuna altra cosa inclinava quanto alla satira, ed all'appiccicare il ridicolo sà alle cose che alle persone. Ma pure poi riflettendo e pensando, ancorché mi vi paresse dovervi aver forse qualche destrezza, non apprezzava io nell'intimo del cuore gran fatto questo sà fallace genere; il di cui buon esito, spesso momentaneo, è posto e radicato assai piú nella malignità e invidia naturale degli uomini, gongolanti sempre allorché vedono mordere i loro simili, che non nel merito intrinseco del morditore.
Intanto per allora la divagazione somma e continua, la libertà totale, le donne, i miei ventiquattro anni, e i cavalli di cui avea spinto il numero sino a dodici e piú, tutti questi ostacoli potentissimi al non far nulla di buono, presto spegnevano od assopivano in me ogni qualunque velleità di divenire autore. Vegetando io dunque cosà in questa vita giovenile oziosissima, non avendo mai un istante quasi di mio, né mai aprendo piú un libro di sorte nessuna, incappai (come ben dovea essere) di bel nuovo in un tristo amore; dal quale poi dopo infinite angosce, vergogne, e dolori, ne uscii finalmente col vero, fortissimo, e frenetico amore del sapere e del fare, il quale d'allora in poi non mi abbandonò mai piú; e che, se non altro, mi ha una volta sottratto dagli orrori della noia, della sazietà , e dell'ozio; e dirò piú, dalla disperazione; verso la quale a poco a poco io mi sentiva strascinare talmente, che se non mi fossi ingolfato poi in una continua e caldissima occupazione di mente, non v'era certamente per me nessun altro compenso che mi potesse impedire prima dei trent'anni dall'impazzire o affogarmi.
Questa mia terza ebrezza d'amore fu veramente sconcia, e pur troppo lungamente anche durò. Era la mia nuova fiamma una donna, distinta di nascita, ma di non troppo buon nome nel mondo galante, ed anche attempatetta; cioè maggiore di me di circa nove in dieci anni. Una passeggiera amicizia era già stata tra noi, al mio primo uscire nel mondo, quando ancora era nel Primo Appartamento dell'Accademia. Sei e piú anni dopo, il trovarmi alloggiato di faccia a lei, il vedermi da essa festeggiato moltissimo; il non far nulla; e l'esser io forse una di quelle anime di cui dice, con tanta verità ed affetto, il Petrarca:
So di che poco canape si allaccia
un'anima gentil, quand'ella è sola,
e non è chi per lei difesa faccia;
ed in somma il mio buon padre Apollo che forse per tal via straordinaria mi volea chiamare a sé; fatto si è, ch'io, benché da principio non l'amassi, né mai poi la stimassi, e neppure molto la di lei bellezza non ordinaria mi andasse a genio; con tutto ciò credendo come un mentecatto al di lei immenso amore per me, a poco a poco l'amai davvero, e mi c'ingolfai sino agli occhi. Non vi fu piú per me né divertimenti, né amici; perfino gli adorati cavalli furono da me trascurati. Dalla mattina all'otto fino alle dodici della sera eternamente seco, scontento dell'esserci, e non potendo pure non esserci; bizzarro e tormentosissimo stato, in cui vissi non ostante (o vegetai, per dir meglio) da circa il mezzo dell'anno 1773 sino a tutto il febbraio del '75; senza contar poi la coda di questa per me fatale e ad un tempo fausta cometa.
CAPITOLO DECIMOQUARTO
Malattia e ravvedimento.
Nel lungo tempo che durò questa pratica, arrabbiando io dalla mattina alla sera, facilmente mi alterai la salute. Ed in fatti nel fine del '73 ebbi una malattia non lunga, ma fierissima, e straordinaria a segno che i maligni begl'ingegni, di cui Torino non manca, dissero argutamente ch'io l'avea inventata esclusivamente per me. Cominciò con lo dar di stomaco per ben trentasei ore continue, in cui non v'essendo piú neppur umido da rigettare, si era risoluto il vomito in un singhiozzo sforzoso, con una orribile convulsione del diaframma che neppur l'acqua in piccolissimi sorsi mi permettea d'ingoiare. I medici, temendo l'infiammazione, mi cacciarono sangue dal piede, e immediatamente cessò lo sforzo di quel vomito asciutto, ma mi si impossessò una tal convulsione universale, e subsultazione dei nervi tutti, che a scosse terribili ora andava percuotendo il capo della testiera del letto, se non me lo teneano, ora le mani e massimamente i gomiti, contro qualunque cosa vi fosse stata aderente. Né alcunissimo nutrimento, o bevanda, per nessuna via mi si poteva far prendere, perché all'avvicinarsi o vaso o istromento qualunque a qualunque orifizio, prima anche di toccare la parte era tale lo scatto cagionato dai subsulti nervosi, che nessuna forza valeva a impedirli; anzi, se mi voleano tener fermo con violenza era assai peggio, ed io ammalato dopo anche quattro giorni di totale digiuno, estenuato di forze, conservava però un tale orgasmo di muscoli, che mi venivano fatti allora degli sforzi che non avrei mai potuti fare essendo in piena salute. In questo modo passai cinque giorni interi in cui non mi vennero inghiottiti forse venti o trenta sorsetti di acqua presi cosà a contrattempo di volo, e spesso immediatamente rigettati. Finalmente nel sesto la convulsione allentò, mediante le cinque o le sei ore il giorno che fui tenuto in un bagno caldissimo di mezz'olio e mezz'acqua. Riapertasi la via dell'esofago, in pochi giorni col bere moltissimo siere fui risanato. La lunghezza del digiuno e gli sforzi del vomito erano stati tali, che nella forcina dello stomaco, fra quei due ossucci che la compongono, vi si formò un tal vuoto, che un uovo di mezzana grandezza vi potea capire; né mai poi mi si ripianò come prima. La rabbia, la vergogna, e il dolore, in cui mi facea sempre vivere quell'indegno amore, mi aveano cagionata quella singolar malattia. Ed io, non vedendo strada per me di uscire di quel sozzo laberinto, sperai, e desiderai di morirne. Nel quinto giorno del male, quando piú si temeva dai medici che non ne ritornerei, mi fu messo intorno un degno cavaliere mio amico, ma assai piú vecchio di me, per indurmi a ciò che il suo viso e i preamboli del suo dire mi fecero indovinare prima ch'egli parlasse; cioè a confessarmi e testare. Lo prevenni, col domandar l'uno e l'altro, né questo mi sturbò punto l'animo. In due o tre aspetti mi occorse di rimirare ben in faccia la morte nella mia gioventú; e mi pare di averla ricevuta sempre con lo stesso contegno. Chi sa poi, se quando ella mi si riaffaccerà irremissibile io nello stesso modo la riceverò. Bisogna veramente che l'uomo muoia, perché altri possa appurare, ed ei stesso, il di lui giusto valore.
Risorto da quella malattia, ripigliai tristamente le mie catene amorose. Ma per levarmene pure qualcun'altra d'addosso, non volli piú lungamente godermi i lacci militari, che sommamente mi erano sempre dispiaciuti, abborrendo io quell'infame mestiere dell'armi sotto un'autorità assoluta qual ch'ella sia; cosa, che sempre esclude il sacrosanto nome di patria. Non negherò pure, che in quel punto la mia Venere non fosse piú assai per me opprobriosa che non era il mio Marte. In somma fui dal colonnello, e allegando la salute domandai dimissione dal servizio, che non avea a dir vero prestato mai; poiché in circa ott'anni che portai l'uniforme, cinque li avea passati fuor del paese; e nei tre altri appena cinque riviste avea passate, che due l'anno se ne passavano sole in quei reggimenti di Milizie Provinciali in cui avea preso servizio. Il colonnello volle ch'io ci pensassi dell'altro prima di chiedere per me codesta dimissione; accettai per civiltà il suo invito e simulando di avervi pensato altri quindici giorni, la ridomandai piú fermamente e l'ottenni.
Io frattanto strascinava i miei giorni nel serventismo, vergognoso di me stesso, noioso e annoiato, sfuggendo ogni mio conoscente ed amico, sui di cui visi io benissimo leggeva tacitamente scolpita la mia opprobriosa dabenaggine. Avvenne poi nel gennaio del 1774, che quella mia signora si ammalò di un male di cui forse poteva esser io la cagione, benché non intieramente il credessi. E richiedendo il suo male ch'ella stesse in totale riposo e silenzio, fedelmente io le stava a piè del letto seduto per servirla; e ci stava dalla mattina alla sera, senza pure aprir bocca per non le nuocere col farla parlare. In una di queste poco, certo, divertenti sedute, io mosso dal tedio, dato di piglio a cinque o sei fogli di carta che mi caddero sotto mano, cominciai cosà a caso, e senza aver piano nessuno, a schiccherare una scena di una non so come chiamarla, se tragedia, o commedia, se d'un sol atto, o di cinque, o di dieci; ma insomma delle parole a guisa di dialogo, e a guisa di versi, tra un Photino, una donna, ed una Cleopatra, che poi sopravveniva dopo un lunghetto parlare fra codesti due prima nominati. Ed a quella donna, dovendole pur dare un nome, né altro sovvenendomene, appiccicai quel di Lachesi, senza pur ricordarmi ch'ella delle tre Parche era l'una. E mi pare, ora esaminandola, tanto piú strana quella mia subitanea impresa, quanto da circa sei e piú anni io non avea mai piú scritto una parola italiana, pochissimo e assai di rado e con lunghissime interruzioni ne avea letto. Eppure cosà in un subito, né saprei dire né come né perché, mi accinsi a stendere quelle scene in lingua italiana ed in verso. Ma, affinché il lettore possa giudicar da sé stesso della scarsezza del mio patrimonio poetico in quel tempo, trascriverò qui in fondo di pagina a guisa di nota(1) un bastante squarcio di codesta composizione, e fedelissimamente lo trascriverò dall'originale che tuttavia conservo, con tutti gli spropositi perfino di ortografia con cui fu scritto: e spero, ch...
[Pagina successiva]