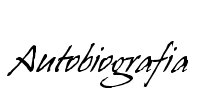[Pagina precedente]...ssici latini. E in tutti l'un dopo l'altro, e replicatamente li lessi, ma troppo presto e con troppa avidità , onde non mi fecero quel frutto che me ne sarebbe ridondato leggendoli pacatamente, e ingoiandomi le note. Cosa alla quale mi son poi piegato tardissimo, avendo sempre da giovane anteposto l'indovinare i passi difficili, o il saltarli a piè pari, all'apianarmeli colla lettura e meditazione dei commenti.
Le mie composizioni frattanto nel decorso di quell'anno borsale 1778, non dirò che fossero tralasciate, ma elle si risentivano dei tanti disturbi antiletterari in cui m'era ingolfato di necessità . E circa poi al punto principale per me, cioè la padronanza della lingua toscana, mi si era aggiunto anche un nuovo ostacolo, ed era, che la mia donna non sapendo allora quasi punto l'italiano, io mi era trovato costretto a ricader nel francese, parlandolo e sentendolo parlare continuamente in casa sua. Nel rimanente del giorno io cercava poi il contravveleno dei gallicismi nei nostri ottimi e noiosi prosatori trecentisti, e feci su questo proposito delle fatiche niente poetiche, ma veramente da asino. A poco a poco pure spuntai, che l'amata imparasse perfettamente l'italiano sà per leggere che per parlare; e vi riuscà quanto e piú ch'altra mai forestiera che vi si accingesse; e lo parlò anzi con una assai migliore pronunzia che non lo parlano le donne d'Italia non toscane, che tutte, o sian lombarde, o veneziane o napoletane o anche romane, lacerano quale in un modo quale nell'altro, ogni orecchio che siasi avvezzo al soavissimo, e vibratissimo accento toscano. Ma per quanto la mia donna non parlasse tosto altra lingua con me, tuttavia la casa sua sempre ripiena di oltramontaneria era per il mio povero toscanismo un continuo martirio; talché, oltre parecchie altre, io ebbi anche questa contrarietà , di esser stato presso che tre anni allora in Firenze, e d'avervi assai piú dovuto ingoiare dei suoni francesi, che non dei toscani. E in quasi tutto il decorso della mia vita, finora, mi è toccata in sorte questa barbaria di gallicheria; onde, se io pure sarò potuto riuscire a scrivere correttamente, puramente, e con sapore di toscanità (senza però ricercarla con affettazione e indiscrezione), ne dovrò riportar doppia lode, attesi gli ostacoli; e se riuscito non ci sono, ne meriterò ampia scusa.
CAPITOLO SETTIMO
Caldi studi in Firenze
Nell'aprile del '78, dopo aver verseggiata la Virginia, e quasi che tutto l'Agamennone, ebbi una breve ma forte malattia infiammatoria, con un'angina, che costrinse il medico a dissanguarmi; il che mi lasciò una lunga convalescenza, e fu epoca per me di un notabile indebolimento di salute in appresso. L'agitazione, i disturbi, lo studio, e la passione di cuore mi aveano fatto infermare, e benché poi nel finir di quell'anno cessassero interamente i disturbi d'interesse domestico, lo studio e l'amore che sempre andarono crescendo, bastarono a non mi lasciar piú godere in appresso di quella robustezza d'idiota ch'io mi era andata formando in quei dieci anni di dissipazione, e di viaggi quasi continui. Tuttavia nel venir poi dell'estate, mi riebbi, e moltissimo lavorai. L'estate è la mia stagione favorita; e tanto piú mii si confà , quanto piú eccessiva riesce; massimamente pel comporre. Fin dal maggio di quell'anno avea dato principio ad un poemetto in ottava rima, su la uccisione del duca Alessandro da Lorenzino de' Medici; fatto, che essendomi piaciuto molto, ma non lo trovando suscettibile di tragedia, mi si affacciò piuttosto come poema. Lo andava lavorando a pezzi, senza averne steso abbozzo nessuno, per esercitarmi al far rime, da cui gli sciolti delle oramai già tante tragedie mi andavano deviando. Andava anche scrivendo alcune rime d'amore, sà per lodare la mia donna, che per isfogare le tante angustie in cui, attese le di lei circostanze domestiche, mi conveniva passare molt'ore. E hanno cominciamento le mie rime per essa, da quel sonetto (tra gli stampati da me) che dice:
Negri, vivaci, in dolce fuoco ardenti;
dopo il quale tutte le rime amorose che seguono, tutte sono per essa, e ben sue, e di lei solamente, poiché mai d'altra donna per certo non canterò. E mi pare che in esse (siano con piú o meno felicità ed eleganza concepite e verseggiate), vi dovrebbe pure per lo piú trasparire quell'immenso affetto che mi sforzava di scriverle, e ch'io ogni giorno piú mi sentiva crescer per lei; e ciò massimamente, credo, si potrà scorgere nelle rime scritte quando poi mi trovai per gran tempo disgiunto da essa.
Torno alle occupazioni del '78. Nel luglio distesi con una febbre frenetica di libertà la tragedia de' Pazzi; quindi immediatamente il Don Garzia. Tosto dopo ideai e distribuii in capitoli i tre libri Del principe e delle lettere, e ne distesi i primi tre capitoli. Poi, non mi sentendo lingua abbastanza per ben esprimere i miei pensamenti, lo differii per non averlo poi a rifonder tutto allorché ci tornerei per correggerlo. Nell'agosto di quell'anno stesso, a suggerimento e soddisfazione dell'amata, ideai la Maria Stuarda. Dal settembre in giú verseggiai l'Oreste, con cui terminai quell'anno per me travagliatissimo.
Passavano allora i miei giorni in una quasi perfetta calma; e sarebbe stata intera, se non fossi stato spesso angustiato del vedere la mia donna angustiata da continui dispiaceri domestici cagionatile dal querulo, sragionevole, e sempre ebro attempato marito. Le sue pene eran mie; e vi ho successivamente patito dolori di morte. Io non la poteva vedere se non la sera, e talvolta a pranzo da lei; ma sempre presente lo sposo, o al piú standosi egli di continuo nella camera contigua. Non già ch'egli avesse ombra di me piú che d'altri; ma era tale il di lui sistema; ed in nove anni e piú che vissero insieme quei due coniugi, mai e poi mai e poi mai non è uscito egli di casa senza di lei, né ella senz'esso; continuità che riuscirebbe stucchevole perfino fra due coetanei amanti. Io dunque tutto l'intero giorno me ne stava in casa studiando, dopo aver cavalcato la mattina per un par d'ore un ronzino d'affitto per mera salute. La sera poi io trovava il sollievo della sua vista, ma amareggiato pur troppo dal vederla come dissi quasi sempre afflitta, ed oppressa. Se io non avessi avuta la tenacissima occupazione dello studio, non mi sarei potuto piegare al vederla sà poco, e in tal modo. Ma anche, se io non avessi avuto quell'unico sollievo della sua dolcissima vista per contravveleno all'asprezza della mia solitudine non avrei mai potuto resistere a uno studio cosà continuo, e cosÃ, direi, arrabbiato.
In tutto il '79 verseggiai la Congiura de' Pazzi; ideai la Rosmunda, l'Ottavia, e il Timoleone; stesi la Rosmunda, e Maria Stuarda; verseggiai il Don Garzia; terminai il primo canto del poema, e inoltrai non poco il secondo.
In mezzo a sà calde e faticose occupazioni della mente, mi trovava anche soddisfatti gli affetti del cuore, tra l'amata donna presente, e due amici lontani, con cui mi andava sfogando per lettere. Era l'uno di questi, il Gori di Siena, il quale anche due o tre volte era venuto in Firenze a vedermi; l'altro era l'ottimo abate di Caluso, il quale verso la metà di quell'anno '79 venne poi in Firenze, chiamatovi in parte dall'intenzione di godersi per un anno quella beatissima lingua toscana, ed in parte (me ne lusingo) chiamatovi dal piacere di essere con chi gli volea tanto bene quanto io; ed anche per darsi ai suoi studi piú quetamente e liberamente che non gli veniva fatto in Torino, dove fra i suoi tanti e fratelli, e nipoti, e cugini, e indiscreti d'altro genere la di lui mansueta e condiscendente natura lo costringeva ad essere assai piú d'altri che suo. Un anno presso che intero egli stette dunque in Firenze; ci vedevamo ogni giorno, e si passava insieme di molte ore del dopo pranzo. Ed io nella di lui piacevole ed erudita conversazione imparai senza quasi avvedermene piú cose assai che non avrei fatto in molti anni sudando su molti libri. E tra l'altre, quella di cui gli avrò eterna gratitudine, si è di avermi egli insegnato a gustare e sentire e discernere la bella ed immensa varietà dei versi di Virgilio, da me fin allora soltanto letti ed intesi; il che per la lettura di un poeta di tal fatta, e per l'utile che ne dee ridondare a chi legge, viene a dir quanto nulla. Ho tentato poi (non so con quanta felicità ) di trasportare nel mio verso sciolto di dialogo quella incessante varietà d'armonia, per cui raramente due versi somigliantisi si accoppino; quelle diverse sedi d'interrompimento, e quelle trasposizioni (per quanto l'indole della lingua nostra il concede), dalle quali il verseggiar di Virgilio riesce sà maraviglioso, e sà diverso da Lucano, da Ovidio, e da tutti. Differenze difficili ad esprimersi con parole, e poco concepibili da chi dell'arte non è. Ed era pur necessario ch'io mi andassi aiutando qua e là per far tesoro di forme e di modi, per cui il meccanismo del mio verso tragico assumesse una faccia sua propria, e si venisse a rialzare da per sé, per forza di struttura; mentre non si può in tal genere di composizione aiutare il verso, né gonfiarlo con i lunghi periodi, né con le molte immagini, né con le troppe trasposizioni, né con la soverchia pompa o stranezza dei vocaboli, né con ricercati epiteti: ma la sola semplice e dignitosa sua giacitura di parole infonde in esso la essenza del verso, senza punto fargli perdere la possibile naturalezza del dialogo. Ma tutto questo, ch'io forse qui mal esprimo, e ch'io aveva fin d'allora, e ogni dà piú caldamente, scolpito nella mente mia non lo acquistai nella penna se non se molti anni dopo, se pur mai lo acquistai: e forse fu quando poi ristampai le tragedie in Parigi. Che se il leggere, studiare, gustare, e discernere, e sviscerare le bellezze ed i modi del Dante e Petrarca mi poterono infonder forse la capacità di rimare sufficientemente e con qualche sapore; l'arte del verso sciolto tragico (ove ch'io mi trovassi poi d'averla o avuta o accennata) non la ripeterò da altri che da Virgilio, dal Cesarotti, e da me medesimo. Ma intanto, prima che io pervenissi a dilucidare in me l'essenza di questo stile da crearsi, mi toccò in sorte di errare assai lungamente brancolando, e di cadere anche spesso nello stentato ed oscuro, per voler troppo sfuggire il fiacco e il triviale; del che ho ampiamente parlato altrove quando mi occorse di dare ragione del mio scrivere.
Nell'anno susseguente, 1780, verseggiai la Maria Stuarda; stesi l'Ottavia e il Timoleone; di cui, questa era frutto della lettura di Plutarco, ch'io avea anche ripigliato; quella, era figlia mera di Tacito, ch'io leggeva e rileggeva con trasporto. Riverseggiai inoltre tutto intero il Filippo, per la terza volta, sempre scemandolo di parecchi versi; ma egli era pur sempre quello che si risentiva il piú della sua origine bastarda, pieno di tante forme straniere ed impure. Verseggiai la Rosmunda, e gran parte dell'Ottavia, ancorché verso il finir di quell'anno la dovessi poi interrompere, attesi i fieri disturbi di cuore che mi sopravvennero.
CAPITOLO OTTAVO
Accidente per cui di nuovo rivedo Napoli, e Roma, dove mi fisso.
La donna mia (come piú volte accennai) vivevasi angustiatissima; e tanto poi crebbero quei dispiaceri domestici, e le continue vessazioni del marito si terminarono finalmente in una sà violenta scena baccanale nella notte di Sant'Andrea, ch'ella per non soccombere sotto sà orribili trattamenti fu alla per fine costretta di cercare un modo per sottrarsi a sà fatta tirannia, e salvare la salute e la vita. Ed ecco allora, che io di bel nuovo dovei (contro la natura mia) raggirare presso i potenti di quel governo, per indurli a favorire la liberazione di quell'innocente vittima da un giogo sà barbaro e indegno. Io, assai ben conscio a me stesso che in codesto fatto operai piú pel bene d'altri che non per il mio; conscio ch'io mai non diedi consiglio estremo alla mia donna, se non quando i mali suoi divennero estremi davvero, perché questa è sempre stata la massima ch'io ho voluta pra...
[Pagina successiva]