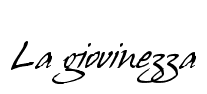[Pagina precedente]... zio mi diede un forte pizzicotto al braccio, e mi fece gridare: "ah!" Poi disse: "Eh! testa dura, scrivi questo nei giorni nefasti, perché oggi ti hai perduto una bella fortuna". Io aprii gli occhi, e non ne capii nulla, e andavo avanti tronfio con la testa alta, e parlavamo con Giovannino ancora di Cesare e di Annibale.
Non è possibile poi che io dica quale effetto avesse su me la parte fantastica della storia. Avevo una inclinazione naturale al rêve. Stavo spesso a testa china e taciturno, e zia Marianna ch'era come la governante di casa, talora mi dava un gran grido nell'orecchio, strillando: "Ciccillo!". Io mi riscuoteva in soprassalto come da un sonno, e zio diceva: "Lascialo stare, quello pensa". Io mi facevo rosso, perché al dir che io pensavo mi pareva una bugia. Io stavo cosà concentrato sotto il peso delle mie letture, che mi riempivano il cervello di fantasmi, e non mi lasciavano quieto. Nel mio cervello si formava come un mondo luminoso, nel quale vedevo quei fantasmi come persone vive, e sentivo le loro parole distintamente. E dimorando tutto dentro, non sentivo e non vedevo niente intorno a me. Quei fantasmi generavano altri fantasmi, ed io mi facevo il protagonista della storia, ed era sempre re, imperatore o generale, e davo di gran battaglie, con sapienza di apparecchi e di movimenti, e spesso questi sogni ad occhi aperti duravano piú giorni.
Un giorno ch'era l'ascensione, e l'uso era di mangiare i maccheroni con il latte, mi levai di tavola subito e assai prima degli altri, come soleva fare, perché divorava, non mangiava, e non sapeva cosa mi metteva in bocca. E andai difilato nell'ultima stanza con la testa piena. C'era nella testa la battaglia fra Tancredi e Argante, e Tancredi ero io, e presa in mano una squadra da compasso, assaliva vigorosamente Argante, e lo gittavo rovescio per terra, e mi pareva di montare sulle mura di Gerusalemme, e mi trovai sul davanzale della finestra col braccio teso in fuori agitando la squadra. Sul balcone dirimpetto stava una signorina che al vedermi cosà levò un gran grido, ed io come risvegliato scesi. A quel grido corsero mio cugino e la zia e mi videro scendere, e riferirono tutto allo zio, il quale comandò fossi condotto innanzi a lui. Ma non ci fu verso. Io per vergogna m'ero chiuso nel licet, e non volevo uscire. Allora venne lo zio dentro, e mi tirò per il braccio, e disse afferrandomi per l'orecchio: "Ciccillo, oggi tu sei rinato; ricordati questo giorno". E in verità , questo giorno dell'Ascensione non mi è uscito piú di mente. Un'altra volta innanzi a un uditorio scolastico rappresentammo una cosà detta tragedia, che non era altro se non scene staccate del Tasso da noi impasticciate e declamate, e l'autore di questo bel pasticcio ero io, e molti erano i complimenti e le strette di mano, e io mi pigliavo tutto con l'aria di chi crede di meritare ancora di piú.
A farla breve, in quei cinque anni di corso sapevo a mente una gran parte di Virgilio, di Livio, di Orazio, della Gerusalemme Liberata e dei drammi di Metastasio, oltre un'infinità di frasi e di pezzi staccati dai molti libri che si erano studiati. Dalle letture particolari mi veniva un'enorme quantità di notizie, di aneddoti, di sentenze, tutto rimescolato cosà a casaccio nel mio cervello. Non c'era ancora un giusto criterio per distinguere l'utile, il bello, il vero, l'importante. In quella farraggine entravano con pari dritto anche le cose piú goffe e piú volgari. Le Notti di Young, le tragedie di Voltaire, la Sofonisba del Trissino mi parevano cose grandi. Soprattutto ero molto innamorato delle Notti di Young, e recitavo con grande enfasi i pezzi piú romorosi. Avevo in capo un materiale enorme indigesto, che mi faceva l'effetto d'una grande ricchezza, e mi credevo da senno il piú dotto uomo d'Italia, e avevo appena quindici anni. Certo, nessuno dei miei compagni aveva letto tanti libri, sapeva tante cose. C'era di che averne il capogiro. Parlavo con gli occhi che mi scintillavano, con gesti pronti e risoluti, e mi perdonavano tutto, mi accarezzavano il mento, come a un caro fanciullo viziato. Ma, a trarre il sugo, di greco sapevo poco, il latino non mi entrava se non dopo laboriosi costruzione, e non era in grado di leggerlo e tanto meno di scriverlo, scrivevo l'italiano in uno stile pomposo e rettorico, un italiano corrente, mezzo francese, a modo del Beccaria e dei Cesarotti, ch'erano i miei favoriti. Cosà con molta presunzione, con grossa e confusa suppellettile, ma con giudizio poco, usciva da quei cinque anni di studio.
Capitolo terzo
ZIA MARIANNA
Governava la casa zia Marianna. Era ed è rimasta per me anche oggi la zia. Non ne sapevo piú avanti. Giovannino ch'era piú curioso di me ed aveva una certa malizia, mi narrò piú tardi non so che, ma non mi rimase nulla in mente. La mia natura non mi tira a indagare i fatti altrui; e quando sentiva a dire questo o quello, me ne rimaneva appena un ronzio nell'orecchio, e passava subito. Fatto sta ch'io volevo un bene a questa zia poco meno che a mamma, e tenevo a mostrarglielo. Per via studiavo sempre il passo per starle accanto, e mi attaccavo alla sua gonnella. Giovannino, per non parere da meno, la teneva dall'altro lato, ed ella rideva e ci accarezzava, e poi a tavola raccontava tutto con una specie di caricatura che faceva ridere lo zio; perché ella parlava e gestiva il piú bel napoletano. Aveva la pelle bianchissima e rosea; florida era di salute, e di umore allegro. La sera si ritirava in casa sua, poco lontano nella stessa strada. Verso il tardi andavamo noi e zio a visitarla, e si passava la serata allegramente. La mattina, Rachele ch'era la serva di casa, andava a svegliarla, e tutte e due andavano in piazza a far la spesa. Ella stava d'ordinario in cucina, una stanza bene arieggiata e provvedeva a tutto.
Mio zio volle che andass'io a svegliarlo, la mattina alle sei e mezzo; e quest'ora mi si era ficcata nel cerebro, e, come se avessi l'orologio nell'orecchio, mi gettavo giú di letto, e correvo allo zio e dicevo: "Zio, sono le sei e mezzo". Svegliatosi, stendeva un po' le membra, ma poi tornava tutto rannicchiato sotto a quel dolce tepore; ed io, fatte le mie cose in cucina, tornavo e facevo la seconda chiamata: "Zio, sono le sei e mezzo"; e lui si levava senz'altro. Quando sentivo il campanello, correvo, ch'era la zia, e le baciavo la mano. Veniva appresso a lei la serva, china gli omeri sotto la spesa. Non si mangiava male, perché c'era sempre qualche pensionista. Erano cibi sani e casarecci, che a me piacevano piú che le vivande delicate. Ma ciò che non potevo patire era quel piccolo pezzo di pane assegnatomi, e dovevo fare la faccia dura per avere un rinforzo.
Un giorno stavo collocato vicino al padre di un pensionista, un bravo vecchio, tagliato cosà alla grossa, che ci vedeva poco. Io aveva finito il mio pane, e piano piano mi tirai il suo, e lo divisi con Giovannino, ch'era quasi sempre l'istigatore. Il vecchio, quando gli bisognò, non trovò piú il suo pane, e andava cercando a tentoni. Io m'ero rimpiccinito, e avrei voluto sparire dal mondo. Zia Marianna se ne accorse, e diede un'altra fetta di pane al vecchio, e diede a me un'occhiata obliqua, che mi parve una spada. La sera ci fu gran chiasso; la mi fece una lavata di capo. Come ragazzi viziati, ci raccogliemmo nell'ultima stanza indispettiti, e cominciammo a mormorare contro la zia, che era un'avara, e ci faceva desiderare anche un po' di pane. E d'uno in altro proposito, Giovannino fece questa bella trovata. "Domani, - disse, - si fa il pane nuovo, che fetta e fetta! Andiamo e prendiamoci addirittura una panella, e sfamiamoci, e diamo una lezione alla zia". Vollero assolutamente che fossi io a fare questo bel tratto. Io non voleva; ma pur ci andai. Il giorno appresso nelle ore vespertine tutto dormiva, zio si soleva mettere nella grande stanza della scuola sopra una seggiola, con un fazzoletto che gli copriva la faccia. Nella stanza appresso stava un maestro di disegno, certo Ippolito Certain, che a quell'ora stava disteso sul letto sonnecchiando. Zia Marianna era a sua casa; ma nell'avanti-cucina come un Argo, stava Rachele cosà tra veglia e sonno sulle tavole del letto acquattata. Appunto in quella camera stava il pane nuovo in una cesta che penzolava a una fune presso il balcone. Giunse l'ora. Io ero pallido come un ladro; mi batteva il cuore. Mi levai le scarpe e zitto zitto aprii l'uscio della stanza, dove stava lo zio. Ma quel maledetto uscio sonò un poco, e zio disse: "Chi è?" Fatto ardito dalla paura, inventai una bugiella, e infilai l'altro uscio piano piano che non si sentiva un et. Il maestro, uso a pazienza, sentito o no, mi fece andar via, e non fiatò. Quando mi vidi nella stanza da letto, mi venne un riso sul labbro, e mi fregai le mani e le scarpe mi caddero a terra, e fecero uno strepito, che mi cacciò il riso nella strozza. Eccomi in cucina, e là mi fermai in punta di piedi, orecchiando, e mi feci un segno di croce, come per implorare l'assistenza di Dio. Mi affaccio nell'ultima stanza, e quelle panelle, fumigavano ancora, e me ne veniva l'odore alle narici. Stesi la mano, e la ritirai subito pensando a Rachele che mi potesse vedere. E mi volsi verso l'alcova, e vidi che stava tutta accoccolata, dormendo forte. Mi venne un'idea, di vedere com'era fatta la donna, ma la cacciai subito, e mi feci un gran segno di croce, come per scongiurare il demonio. Poi camminando in punta di piedi, pallido, sconvolto, stesi la mano alla cesta, ma la mano mi tremava e non voleva prendere la panelle. Stavo sempre sotto agli occhi di Rachele, e la paura di Rachele mi fece sollecito, e afferrai la panelle e me la misi in seno, e corsi difilato rifacendo la via, e mi sentivi fischiare nell'orecchio: "Al ladro, al ladro!" Giunsi in mezzo ai compagni cosà brutto che pensarono non fossi riuscito; quand'io mi cacciai di sotto la panelle. Saltarono, gridarono, batterono le mani, mi applaudirono, e in quel fragore io mi ripigliai e mi mangiai la mia parte.
Venne il dà appresso, e Rachele non trovò la panella, corse da zia Marianna. La zia fece la faccia seria, e disse: "Ciccillo mi dirà la verità ". E mi chiamò che mi tremavano le gambe, e mi pose gli occhi negli occhi, e disse: "Ciccillo, chi ha rubato la panella?" Io scoppiai in pianto.
In quel tempo ero spesso malato; fin d'allora ero stitico, il mio male era sempre nel ventre. Medico di casa era un certo Domenico Albanesi, che mi curava col metodo allora in fiore: purganti, salassi, clisteri, vomitivi e digiuni. Un salasso mi rimase aperto parecchi mesi, e ne ho ancora oggi la cicatrice. Per fin anno non bevvi piú caffè, perché ci sentivo dentro un odore d'ipecacuana. Talora, vista inutile l'azione delle purghe, ricorrevano al sale inglese, a costo di, vedermi scoppiare. Di sotto a quella cura usciva magro, e fragile e sottile come una canna, e pareva Nicola Villetta mezzo vivo e mezzo morto.
Capitolo quarto
GENOVIEFA
Anche oggi non posso pronunziare questo nome senza un battito di core. Genoviefa aveva qualche anno piú di me, ed era mia sorella ed era l'anima mia. Mi comandava con l'occhio dolce. E cantava e saltellava sempre, ed era bianca e rossa, come dicono nel mio paese, Ci vogliono intendere ch'era bellissima. Piccina la mandarono a Napoli a gran contentezza di zia Marianna, che la vestiva come una bambola. Quando andava per le vie, con quelle braccia nude e bianche, era una gioia, e tutti la guardavano. Mamma lo seppe, e si spaventò che con tanti vezzi e ninnoli non le guastassero il cuore, e rivolse la figliuola a casa. Ci fu un gran dire. Zia Marianna canzonava la mamma di quelle sue maniere semplici paesane, e strepitava che la era una rozza provinciale, e che non capiva la moda; e non voleva a nessun patto gliela togliessero via. Mamma non aveva la zia in odore di santità , e trepidava a lasciarle in mano la piccina; era una buona donna, di costumi austeri, e non voleva orpelli né vanità . Vinse l'autorità materna, e riebbe la figliuola. Quella breve dimora in Napoli non le ...
[Pagina successiva]