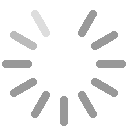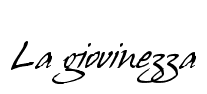[Pagina precedente]... fosse incollerito della critica fatta al suo lavoro, anche severissima; anzi nacque il costume che si andava a ringraziare l'autore della critica, e seguiva uno scambio di cortesie. Questo ingentiliva gli animi piú zotici, e li disponeva a sentimenti nobili. C'eravamo tutti alzati in un'atmosfera elevata, alla quale non pervenivano i rumori della vita comune. Una volta si sentí non so che diverbio in sala, e tutti vi prestavano orecchio. Io feci il volto severo, e citai il verso di Dante:
Ché voler ciò udire è bassa voglia.
Si fecero un pizzico. E non avvenne mai piú cosa simile.
In mezzo a loro io non prendeva aria professorale. Stavo come amico tra amici, alla buona e in tutta dimestichezza. Ma la mia natura concentrata mi teneva lontano da soverchia familiarità; c'era non so che cosa nell'aria del volto, che non consentiva altrui un soverchio abbandono, e mi manteneva il rispetto. Quando poi si usciva dalle conversazioni e cominciava la lezione, io mi trasformavo addirittura. Avevo un concetto cosí alto della mia missione, che il mio magistero mi pareva un sacerdozio. Avevo gli occhi bassi, la mente in travaglio, insino a che, preso l'aíre, gli occhi s'illuminavano e la voce s'intonava. Tutto questo avveniva con tanta serietà e con tanta sincerità, che produceva una certa comunione delle anime, e non si sentiva un zitto. Questa era un'aureola che manteneva il mio prestigio, sí che bastava una voltata d'occhio per farmi ubbidire. Non mi ricordo mai che nessuno mi abbia risposto.
Ciascun uomo ha il suo ritornello. E il mio ritornello era il disprezzo del luogo comune e il disprezzo del plebeo. Il maggior dispiacere che potesse avere un giovane era il sentirsi a dire di qualche suo lavoro: "L'è un luogo comune". Ed era una trafittura quando si sentiva dire: "I sentimenti sono plebei". Questo dava una impronta singolare alla scuola. Si abborriva dal mediocre; si mirava alla eccellenza. Io era incontentabile; solevo dire: "Mi contento per ora", mostrando loro un piú alto segno. Dicevo che il vero ingegno non s'acqueta mai, e poggia sempre piú alto. Questo teneva in moto continuo l'intelletto, e lo sforzava a cose nuove. Qualcuno mi osservò che ponevo la mira troppo alta, ove non arrivavano che i pochi; ma non c'era verso, l'impulso era dato. Dotato di molta pazienza, mosso da un gran desiderio del bene, tentai un corso speciale per i meno provetti, ritornando alle cose grammaticali, e dettandone un sunto. Ma se ne cavò poco frutto. Ciascuno mirava là dove splendevano gli astri maggiori, e avveniva che talora in lavori a grandi pretensioni si notavano scorrezioni grossolane, anche sgrammaticature. Se però il profitto non era uguale, il buono indirizzo giovava a tutti, stimolando le forze dello spirito.
Quello che volevo nello scrivere, volevo anche nella vita. Dicevo che lo scrittore dee concordare con l'uomo, e perciò anche nell'uomo volevo il disprezzo del comune e del plebeo. Ciò io chiamavo dignità personale. In questa parola compendiavo tutta la moralità, e dicevo che la dignità era la chiave della vita. Contravveniva alla dignità la menzogna, ch'io perseguitava cosí nello scrivere come nell'azione. "La menzogna nello scrivere, - dicevo, - è roba da retori e da pedanti". Ero cosí inflessibile, che dannavo non solo gli ornamenti e i ricami, che chiamavo il belletto e il rossetto dello scrivere; ma anche le frasi convenzionali e usuali di una ostentata benevolenza. Parimenti inflessibile ero nella vita, e dicevo che la menzogna era la negazione della propria personalità, un atto di vigliaccheria. Con lo stesso zelo flagellavo ogni atto basso e volgare, come la cortigianeria, la ciarlataneria, l'intrigo, la violenza, la superbia. Dicevo che l'orgoglio è il sentimento della dignità, ed è nell'uomo e nella donna la guardia della virtú, e chiamavo la superbia una maschera della dignità, una menzogna. "La vita, - dicevo, - è una missione determinata dalle forze che ciascun uomo ha sortito da natura, e che ha il dovere di svolgere secondo i grandi fini dell'umanità: la scienza, la giustizia, l'arte, che con parole del tempo si chiamavano il vero, il buono, il bello. La dignità non è cosa passiva, e non è cosa esteriore; il decoro è la sua apparenza, non è lei. La dignità è uno sforzo verso il meglio, che nobilita la persona". Queste idee mi venivano fuori, non in forma di lezione, ma secondo l'occasione, e trovavano il loro luogo specialmente nella critica degli autori e nelle mie prolusioni. Ho trovato nelle mie vecchie carte vari brani d'un discorso che pronunziai in quell'anno. Voglio riferirne alcuni, che daranno un concetto della scuola: "Ed ecco, noi siamo qui insieme un'altra volta: amico, rivedo gli amici miei. Con questa cara parola ci separammo l'ultima volta, e questa cara parola mi ritorna ora sul labbro. Voi, giovani, che qui la prima volta venite, specchiatevi in coloro ch'io ho chiamati col nome di amici miei; e il loro esempio vi mostri che delle lettere il primo frutto è gentilezza; e ricordatevi che spesso la bontà genera la sapienza e il cuore ispira la mente. Questo è il fondamento della nostra scuola; e quando vi sarete avvezzi a scrivere quello che avete prima sentito, voi non descriverete piú battaglie, assedi, tempeste, tombe e cimiteri, e non scriverete piú lettere di complimenti, di congratulazioni, di lode, voi, giovani sdegnosi dell'adulare, e schivi di quelle civili menzogne che chiamano cerimonia e convenevoli. No: preparatevi a scrivere con verità e naturalezza, serbando inviolata in voi l'umana dignità. Sia questo il principio e l'insegna della nostra scuola".
Queste idee non erano rettorica, anzi talora mi venivano di rimbalzo dalla stessa scuola. Alitava sopra tutti uno spirito pieno d'amore, come direbbe Dante, il quale ci teneva stretti intorno alla bandiera, alti sulla vita comune. L'esempio piú puro e piú attraente era Camillo De Meis, carattere eroico nella maggiore naturalezza.
Capitolo ventesimoquinto
LA RETTORICA
In questo tempo feci lezioni sulla rettorica, o piuttosto sull'anti-rettorica. Dissi che la rettorica ha per base l'arte del ben pensare, e perciò non può insegnarsi che ai già provetti nelle discipline filosofiche. Fu essa una invenzione e quasi un gioco dei Sofisti, i quali, separando le forme del dire dallo spirito che le avea generate, e nel quale sono vive e in atto, avevano fatto di quelle un morto repertorio. Di qui nacque l'indifferenza verso il contenuto, e il disprezzo della verità, trattando essi tutte le cause buone e cattive, e lodando l'abilità e il talento del dicitore anzi che la sua scienza e la sincerità. Contro questa prostituzione si armò la collera di Socrate, che flagellò come violazione dell'umana coscienza questi lenocinii dell'arte. Le regole rettoriche non hanno la loro verità che nelle forme del pensiero, materia della logica. Ma come la rettorica non ti dà il ben dire, cosí neppure la logica ti dà il ben pensare, essendo le sue forme staccate da quel centro di vita che si chiama lo spirito. Non perciò le regole sono inutili; anzi sono buone a consultare, come si fa un dizionario di parole o di frasi o di rime. Anche un cinquecentista credette di potere insegnare a scrivere de omnibus rebus, elaborando un dizionario di tutti gli oggetti. Tutto questo è un materiale grezzo, che dee riempire la memoria e divenire come l'arsenale dello spirito; ma, nell'atto dello scrivere, lo spirito dee mantenersi libero e guardare e ispirarsi nell'argomento, e guai a colui che cerca aiuto nei dizionari. Ricordavo il motto di Orazio, che lo scrittore dee per prima cosa studiare il suo argomento ed averne un'intera padronanza: la parola non manca a chi ha innanzi viva e schietta la cosa.
Lo studio delle cose richiede serietà e libertà d'intelletto: due qualità molto desiderate nei nostri scrittori. Serietà vuol dire che l'intelletto non si arresti alla superficie, ma scruti le cose nella loro intimità, perché la verità è nel pozzo, e là nel profondo bisogna ficcar l'occhio. Le armi dell'intelletto sono la sintesi e l'analisi, due forze che, debitamente esercitate, gli dànno la guardatura giusta e piena. Cosí armato, l'intelletto prende possesso delle cose, e ne fa il suo pensiero e la sua parola. Divenute proprietà dello spirito, ricevono ivi dall'intelletto, dall'immaginazione, dal sentimento, cioè da tutta l'anima, una seconda vita. C'è la cosa e c'è l'anima, che le dà la sua guardatura, e se la pone dinanzi e se la rappresenta. Qui è il foco dove prendono luce tutte le regole dei ben pensare e del ben dire, la logica e la rettorica. Ma occorre a questo che l'intelletto abbia piena libertà di moto; altrimenti le sue forze giacciono inoperose. La libertà è all'intelletto cosí necessaria, come la serietà. Spesso l'intelletto si crede libero, ed è servo, servo dell'abitudine, della tradizione, dell'autorità, della società. Segno certo della decadenza è la servitú dell'intelletto, la quale gli tarpa le ali, gli annebbia la visione delle cose, lo tiene sulla superficie, uccide ogni serietà. Perché l'intelletto sia libero, è mestieri che abbia l'amore del vero, quell'amore che è padre della fede. Qui è la moralità dello scrittore. Chi non ha fede in qualche cosa, può essere un buon giocoliere nel maneggio della rettorica, non sarà mai uno scrittore. Il liscio nella forma e la superficialità nelle cose sono i due piú gravi indizi di decadenza nazionale. In Italia l'espressione piú piccante di questa decadenza fu il seicentismo prima, e l'Arcadia poi, e dell'uno e dell'altro rimangono ancora oggi i vestigi anche nei nostri migliori, come io mostrai in parecchi scrittori, anche in Pietro Giordani, tenuto allora principe dell'arte, il cui stile io qualificai accademico. L'originalità è il risultato di quelle due qualità dell'intelletto. Lo spirito ha un suo orizzonte proprio, nel quale colloca le cose divenute sua proprietà, e partecipa a quelle l'impronta sua e dei tempo. Questa è l'originalità nelle cose e nelle forme. I grandi ingegni sono come le aquile, hanno la guardatura dall'alto e da lontano. L'umanità, dopo analisi secolari, giunge a questa guardatura aquilina, per ricominciare poi il lento lavorío analitico. La storia dell'umanità si ripete negl'individui, che solo dopo le pazienti analisi salgono alle sintesi serie e reali. La sintesi è la cosa guardata non nelle sue particolarità, ma nel suo tutto e nelle relazioni con le altre cose: relazioni di somiglianza, di differenza e di contrasto.
Le cosí dette figure rettoriche, cosí come i tropi, non sono che l'espressione di queste relazioni, e hanno in esse la loro verità. Venni all'esame di queste figure, e le ridussi in categorie, secondo le relazioni che esprimono, guardando dal di dentro al di fuori, come avevo fatto con le forme grammaticali, con la lingua e con lo stile. Mi fermai molto sui contrasti o antitesi, flagellando il loro abuso, massime quando lo stile a contrasti sia divenuto una maniera dello scrittore: il qual vizio io chiamai la piú grave malattia dell'intelletto, che, appagato in quei riscontri o raffronti o paralleli delle cose, non posa in alcuno. Biasimai soprattutto la critica dei paralleli, come quella che rimaneva alla superficie, toccando delle cose non la loro sostanza individua, ma le loro attinenze. Compiuto questo lavoro sulle figure, notai ch'elle non sono solo mezzi di stile, come le avevano considerate i retori, che le veggono solo nelle parole e nelle frasi. Le figure entrano nell'organismo stesso della composizione, e sono il modo di concepire e di guardare le cose nelle loro somiglianze, differenze e opposizioni. Esse dunque sono il processo delle cose nel loro tutto e in ciascuna parte. Addussi molti esempi di queste figure, sia nell'intimo stesso della concezione, sia nei singoli periodi. Questo lavoro parve nuovissimo, specialmente per le applicazioni.
Conchiusi che la rettorica, attirando l'attenzione sopra forme esteriori alle cose e appariscenti di falsa luce, indirizza la gioventú alla menzogna, e la svia da' forti stu...
[Pagina successiva]