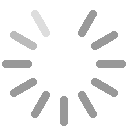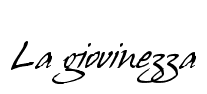[Pagina precedente]...gestire, colorire; aria, luce, elettricità; come si esaltava la mia immaginazione! Quella scintilla elettrica me la sentiva correre per le ossa. Quell'uccellino che perdeva il fiato nella campana pneumatica, mi toccava il core. Mi pareva essere in Cielo vagante tra quei primi elementi e assistere alla creazione. Il professore si studiava di tirarci allo studio di ciascun particolare e faceva esperienze delicate; ma io era miope, e gustavo poco quel che poco vedevo, e mi teneva nel largo, aiutandomi con l'immaginazione.
Dove proprio non fu possibile andare avanti, fu nelle matematiche.
L'aritmetica ragionata non mi voleva entrare in capo, e a gran fatica giunsi fino alla moltiplicazione, non seppi mai fare una divisione; non dico nulla dei rotti, delle frazioni e dei problemi. L'abate ci faceva le operazioni sulla lavagna; io ripeteva bene, perché aveva memoria, ma non ne capiva nulla. Il medesimo mi avvenne con la geometria piana e solida. Facevo le figure bene; ma quando cominciavo con l'angolo a b c e la curva e la retta f, e i triangoli e i cateti, mi pareva entrare come in una torre di Babele, e piú andavo innanzi e piú spropositavo, e quelle lettere mi ballavano innanzi e si mescolavano, e non c'era verso di cavarne un sugo, sicché correva subito al finale: Quod era demonstrandum. Per nascondere al maestro la mia confusione, mi mangiavo mezza la dimostrazione, ingoiando sillabe e correndo a precipizio. Il maestro ci badava poco, distratto e spesso seccato, e ci accomiatava con il suo solito intercalare: "Appresso!"
Questa mia inattitudine alle matematiche non so s'era colpa mia o del maestro; certo è che di quegli studi non mi è rimasto nulla. Ero avvezzo a studiare con l'immaginazione, e quei numeri e quelle linee cosí in astratto non mi capivano in mente. Non era un po' colpa del metodo? E poi il maestro aveva troppa fretta, e non faceva quasi altro che ripetere sulla lavagna il libro di testo. Queste lacune nel mio spirito erano dissimulate dalla potente memoria, e perché ripetevo tutto, pareva anche a me di sapere tutto. Portavo la testa alta tra i compagni, e una voce segreta mi diceva: "tu vali piú di loro". La lezione avuta dal Gesuita non mi aveva corretto, perché nel latino non la pretendevo a gran cosa. Ma quanto a letteratura e a filosofia, ci tenevo.
Volgevano verso la fine gli studi filosofici. Era il dí onomastico dell'abate. Per celebrare la sua festa volle dare una serata, una specie di accademia con versi e prose, in fine complimenti, gelati e confetture. Giovannino e io ci preparammo. Avevamo tra mano calde, calde certe poesie del Capasso in dialetto napoletano. Giovannino vi raffazzonò un sonetto, un luogo comune, girato assai bene in quattordici versi, con frasi goffe tolte a imprestito dal poeta napoletano. A me parve questa cosa troppo facile e troppo andante, e mi si volgeva nell'animo non so che Iliade, qualcosa di grosso. Sudai al gran lavoro una quindicina di giorni. Di qua, di là mi venivano immagini e frasi; non so come, mi brillavano accanto a un'immagine di Omero una frase di Virgilio e un verso sciolto del Trissino, che leggevo allora allora. Ne nacque una putrida in versi sciolti, un volume di carta scritta, da far paura. Andammo. Io era alto della persona, magro e svelto, tutto pulitino, e non capivo in me con quello scartafaccio sotto al braccio. La sala era piena. Molte signore con le bambine, numerosa gioventú, vecchi papà bene azzimati. L'uscio di faccia era aperto, e ne veniva un grato odore di confetture. L'abatino in guanti faceva assai bene gli onori di casa, di su di giú, sdrucciolava fra tutti i crocchi, dispensando sorrisi e strette di mano e gentili motti. C'era quel mormorio, che suol venire da una mescolanza confusa di voci. Ed ecco tutto a un tratto si udí un: "zitto!", e tutti gli occhi si volsero verso la tribuna. Chi è, chi non è? Ero proprio io col mio personcino e con la mia superbia. Stavo lí dritto squadernando il sacro volume e precipitando versi sopra versi correndo senza fiato. C'era una certa curiosità, e dapprima si udiva con pazienza. Poi a ogni voltata della carta si cominciò a guardare con raccapriccio a quello che rimaneva. E volto e volto, e pareva che fossi sempre da capo. Quella gente era venuta non a sentir versi, ma a conversare e a manicare, e non osavano pestar dei piedi, era gente educata, ma si movevano in qua e in là, come chi non trova posa. Ippolito Certain, quel tal maestro di disegno che abitava con noi, stava presso a me e notava tutto, con lo sguardo verso l'uditorio; io con gli occhi sulla carta continuava tronfio e precipitoso, come un torrente, rotte le dighe. Ippolito mi mise la mano alla bocca e disse: "Ferma che è tardi", e la gente voleva andare. "Bravo bravo" si udí attorno; e io tirato pel braccio da Ippolito scesi col mio scartafaccio sotto il naso. Tutti si levarono in piedi, come liberi da un peso, quando: "Zitto!" si udí, e si vide alla tribuna un bassotto, che gridò: "Sonetto in lingua napoletana". La brevità e la novità della poesia fece seder tutti. Giovannino, ch'era lui quel desso, recitava adagio e con grazia quelle frasi goffe, tutte da ridere, e terminò il sonetto tra una salva di applausi. La gente si precipitò verso il fortunato sonettista; e le signore lo baciavano; i giovani si congratulavano; i papà gli accarezzavano il mento, lui modesto e contento in tanta gloria. E l'abate sbirciando vide me tutto solo dall'altro lato, e venne e mi disse. "Hai dovuto faticar molto neh!, povero giovanotto". "Quindici giorni", diss'io, alzando gli occhi stizzito. E l'abate mi fece una carezza, come per consolarmi.
Quando fummo di ritorno a casa, zia Marianna ci aspettava, e volle saper da me come l'era andato. Io aveva come uno strale nel core, e non ebbi la forza di confessare la mia sconfitta, e inorpellai un po' le cose "Ippolito mi disse ch'era tardi, e io lasciai lí, e la gente mi applaudí, gridando: Bravo, bravo!" "Non è vero, - saltò su Giovannino; - gli applausi furono fatti a me, non a te". "Anche a me", diss'io. E sí e no, gli occhi ci si accendevano, e zia Marianna rideva.
Capitolo SESTO
DOMENICO CICIRELLI
A quel tempo avevo già i miei sedici anni. Compiuti erano gli studi letterarii e filosofici. Avvezzo a una vita interiore, avevo pochissimo gusto per i fatti materiali, e badavo piú alle relazioni tra le cose che alla conoscenza delle cose. La scuola ci aveva non piccola parte, perché era scuola di forme e non di cose, e si attendeva piú ad imparare le parole e le argomentazioni, che le cose a cui si riferivano. Oltre a ciò, ero miope, uso piú a guardare dentro a me che fuori. Quando mi si avvicinava una persona, restavo con gli occhi aperti e quasi incantato, tutto pieno delle cose che si dicevano, e non sapevo ridire alcuna particolarità dei suoi tratti o del suo vestire. Parlavo spesso dei mio amore alla natura, ai campi, ai fiori, ai ruscelli; ma era una natura che avevo imparata nei poeti. In verità, non sapevo scerre fior da fiore, e non distinguere albero da albero. Quei mormorii infiniti della natura che sono come la musica o come le lacrime delle cose, non giungevano alla mia anima. Pure l'età mi tirava al di fuori, e anche l'esempio dei compagni. Giovannino mi parlava già dei suoi amori; tutti mi facevano le loro confidenze; guardavo stupido, come chi non ci capisca nulla, e di nuovo a leggere. Avevo una febbre di lettura che mi divorava, e stavo le intere giornate con un libro avanti in un angolo di casa chiuso da un paravento e illuminato fiocamente da una finestra che metteva nel cortile. Poi venne il bisogno di compendiare e di postillare. Talora mi sentivo dolere il magro braccio dal troppo scrivere; mi sentivo gli occhi secchi e abbacinati; uscivo di là come uno scheletro, con un ronzio nell'orecchio, con la testa piena e confusa. In mezzo ai compagni non mi sentivo nessuna voglia di sciorinare le mie letture; già pochi leggevano, pochi erano atti a capirmi, soprattutto allora che poco mi capivo io stesso.
Nondimeno quel rigoglio di gioventú che mi era attorno mi rapiva seco, volente e nolente, m'infondeva sangue e spirito. La sera s'andava talora a mangiare la pizza in certe stanze al largo della Carità. Una volta s'andò a Porta di Massa in un certo covo puzzolente, dov'era buon vino e dove si bevve assai. E mi ricordo che mi accompagnarono a casa che menavo pugni e predicavo, andando a poggia e a orza come una nave in tempesta. Ma queste cattive abitudini erano rintuzzate da quella pianezza di vita intellettuale, che ci tirava a cose meno ignobili. Ci demmo agli esercizi cavallereschi. Studiammo scherma sotto il Parisi. Imparammo [a] ballare. Cominciammo pure lo studio del pianoforte, e anche oggi in certi momenti con le dita io fo le scale. Mi provai pure nel canto sotto un tal maestro Cinque, ma la voce non usciva e lasciai stare. Ci gittammo allo studio del francese, tentando metterci in capo le regole e i dialoghi di Goudar, che allora era in voga. Zio vedeva tutto e lasciava fare. Erano certo nobili sforzi, ma senza indirizzo e senza seguito, incoerenti e instabili. Si lasciava, si ripigliava, molto affannarsi e poca conclusione. Non perciò io lasciava gli studi filosofici.
Il professore fece una brillante lezione sull'armonia prestabilita di Leibnizio. E presto Leibnizio divenne il mio filosofo, come Annibale era stato il mio capitano. Quella figura placida e meditativa, quel carattere conciliativo, punto dommatico, quell'esposizione chiara, che niente avea di pedantesco, m'innamorò. E come l'una cosa tira l'altra, Leibnizio mi fu occasione a leggere Cartesio, Spinosa, Malebranche, Pascal, libri divorati tutti e poco digeriti. Questo era il mio corredo di erudizione filosofica verso la fine dell'anno scolastico, quando zio ci diceva: "Ora bisogna cercarvi un maestro di legge". Si batteva già alle porte della Università.
Venne il settembre e zio veggendomi cosí scheletrito, volle farmi bere un po' d'aria nativa. Andammo zio Pietro, Giovannino ed io. Non sapevo di amar tanto il mio paese. Quando di sopra la via nuova vidi un mucchio di case bianche, mi sentii ricercare le fibre, non so che nuovo mi batteva il core. Poco piú in là vedemmo non so quali punti neri. "Sono galantuomini che ci vengono incontro", disse zio Pietro. Scesi di cavallo a precipizio, e corsi, ed essi corsero a me, e mi trovai tra le braccia del babbo. La sua faccia allegra e rubiconda raggiava, era tutto un riso, e gli pareva essere cresciuto di altezza, tenendo per mano Ciccillo, e mi presentava tutto glorioso. Nonna non c'era piú. La mamma mi venne incontro sui gradini di casa, e mi tenea stretto al seno e piangeva e non sapeva staccarsi da me. La casa fu piena di gente. Molte le strette di mano, molte le carezze e i baci. Ma io m'era seccato, e cercava con gli occhi le compagne e i compagni, mi sentiva un piccino di nove anni, come quando li lasciai. Costantino alto e robusto, mi levò sulle braccia, dicendo: "Come sei fatto brutto!" Era un piccolo gigante quel Costantino. I miei gusti non erano mutati. Abbracciai Michele, il contadino, venuto su rude e saldo, come una torre. La distinzione delle classi non mi è mai entrata in capo. Contadino, operaio, galantuomo, gentiluomo, questo per me non aveva senso. Trattava tutti del pari, e usava il tu, il voi e il lei non secondo le persone e il grado, ma come mi veniva, cosí a casaccio, e spesso alla stessa persona dando del tu e del lei.
La sera ci fu gran pranzo, coi soliti strangolapreti, e il polpettone, e la pizza rustica e altri piatti di rito. Il dí appresso visitai tutti i luoghi dov'era passata la mia fanciullezza. Fui nel sottano, e dove si ammazzava il porco, e dove era la mangiatoia pei cavalli, e dove tra mucchi di legna o di grano solevo trovar le uova ancora calde e portarle alla mamma. Quel sottano sonava ancora dei miei trastulli fanciulleschi. Poi sbucai nell'orto, e salii il fico e mi empii di ciliege, e feci alle bocce o alle palle, correndo, schiamazzando. Ero in piena aria, in piena luce, mi sentivo ri...
[Pagina successiva]