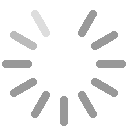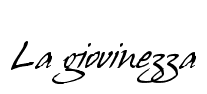[Pagina precedente]...pparisce prima, e la prosa è invece il tardo frutto dell'intelletto venuto a maturità". Queste osservazioni parvero nuove, perché Giambattista Vico era piú ammirato che studiato. Io per conclusione feci una lezione sulla Scienza Nuova, che destò nei giovani il desiderio di quello studio, e parecchi andarono a sentire le dotte lezioni di Enrico Amante sopra il Vico.
Il primo linguaggio dell'anima fu la lirica. E di qui cominciai il mio corso. La distinsi, secondo il contenuto, in religiosa, eroica ed amorosa. Toccai della lirica greca e romana, riserbando la trattazione a un corso speciale. Mi fermai molto sulla lirica ebraica, esaminando in ispecie il libro di Giobbe, il canto di Mosè dopo il passaggio del mar Rosso, i Salmi di Davide, la Cantica di Salomone, i Canti dei profeti, specialmente d'Isaia. Avevo sete di cose nuove, e quello studio era per me nuovissimo. Non avevo letto mai la Bibbia, e i giovani neppure. Con quella indifferenza mescolata di disprezzo, che allora si sentiva per le cose religiose, la Bibbia, come parola di Dio, moveva il sarcasmo. Nella nostra immaginazione c'erano il catechismo e le preghiere che ci sforzavano a recitare nelle Congregazioni, e la Bibbia entrava nel nostro disgusto di tutti i sacri riti. Lessi non so dove maraviglie di quel libro, come documento di alta eloquenza, e tirato dall'argomento delle mie lezioni, gittai l'occhio sopra il Libro di Giobbe. Rimasi atterrito. Non trovavo nella mia erudizione classica niente comparabile a quella grandezza. Portai le mie impressioni calde calde nella scuola. Avevo già fatto una lezione sopra l'origine del male e il significato di quel libro, e fu udita con molta attenzione. Ma quando lessi il libro tutto intero, la mia emozione e la mia ammirazione guadagnarono tutti. Preso l'aíre, c'immergemmo in quegli studi. Furono molto gustati la Cantica; un Salmo di Davide, dove dalla contemplazione delle cose create si argomenta la potenza e la grandezza del Creatore; e qualche Treno di Geremia. Era per noi come un viaggio in terre ignote e lontane dai nostri usi. Con esagerazione di neofiti, dimenticammo i nostri classici, fino Omero, e per parecchi mesi non si udí altro che Bibbia. C'era non so che di solenne e di religioso nella nostra impressione, che alzava gli animi. Chiamammo questo sentimento il divino, e intendevamo sotto questa parola tutto ciò che di puro e di grande è nella coscienza. Mi meraviglio come nelle nostre scuole, dove si fanno leggere tante cose frivole, non sia penetrata un'antologia biblica, attissima a tener vivo il sentimento religioso, ch'è lo stesso sentimento morale nel suo senso piú elevato. Staccare l'uomo da sé, e disporlo al sacrificio per tutti gl'ideali umani, la scienza, la libertà, la patria, questo è la morale, questo è la religione, e questo è l'imitazione di Cristo. Le mie impressioni erano vivaci, perché sincere, e partecipate da quella brava gioventú. Io non cercavo le frasi per fare effetto e per eccitare applausi; essi se ne accorgevano, sapevano che a me era piú grato il loro raccoglimento che il loro battimano. Volevo la serietà delle impressioni. "Cosa mi fanno i vostri applausi, quando, usciti di qua, non resta che un vaniloquio? No, la scuola dee essere la vita; e quella lezione è bella, che vi avrà resi migliori". La scuola era il riflesso della mia anima, e rassomigliava piú a una chiesa che a un teatro.
Venendo alla lirica italiana, mostrai perché noi non avevamo avuto lirica né religiosa né eroica. Questa lirica è voce di popolo sotto forma individuale, come si può vedere nei canti biblici, dove il vero cantore è il popolo ebreo, nel suo clima fisico e morale. Tale lirica è la voce delle genti primitive, e si confonde con i tempi mitici ed epici. La lirica italiana ha avuta la sua voce universale nella Divina Commedia, che oltrepassa i confini d'Italia ed è il poema religioso del Medio Evo. Il sentimento religioso ed eroico non ha avuto presso di noi un accento nazionale. Ci sono delle cosí dette poesie sacre o eroiche, dove cerchi invano la sincerità del sentimento, e spesso non sono che declamazioni, opere letterarie e convenzionali, non voci della coscienza popolare. Non eccettuai la celebrata canzone del Petrarca alla Vergine. A quel tempo correvano opinioni curiose sopra molti nostri lirici. Si citava come modello di genere eroico una canzone di Annibal Caro. Grande era l'ammirazione per le canzoni eroiche del Filicaja, del Chiabrera, del Guidi, del Frugoni. La canzone del Guidi alla Fortuna era un esempio di sublimità. Il Casa e il Costanzo erano lumi del Parnaso. Ma il nostro gusto era divenuto cosí delicato, il nostro giudizio cosí sicuro, che tutte queste divinità si liquefecero, e molti brani ammirati dagli altri destavano in noi il riso, perché ci sentivamo sotto il vuoto e il gonfio. Certe poesie facevano sdegno, come la canzone detta eroica di Annibal Caro, dove l'adulazione si sentiva lontano un miglio. La lirica amorosa non era poi che un sonnolento e artificioso petrarchismo. Ci fermammo dunque all'esame dei due grandi maestri: Dante e Petrarca. Noi eravamo come certi ambiziosi, che sognano re e imperatori, e abitano nei cieli, e sdegnano la bassa terra. Il mediocre e il comune non ci attirava neppure per il piacere di dirne male. Non potendo cansarlo, ci strisciavamo sopra con un "guarda e passa". Miravamo alle stelle di prima grandezza, disposti piú all'ammirazione che al biasimo. Certamente questa inclinazione ci teneva alto l'intelletto e il sentimento, ma pur lasciava una lacuna nello spirito. Non c'è niente di sí mediocre e piccolo, che non abbia il suo valore nella connessione delle cause e degli effetti; non c'è libro cosí volgare, dove non ci sia da imparare, e la storia dei sommi, scompagnati dal corteo dei mediocri, è come concepire il re senza sudditi. Tutto sta che il mediocre resti mediocre e non usurpi il luogo dei grandi: ciascuno al suo posto. Mirando sí alto, a noi riusciva facile spogliare della propria porpora molti re di cartone.
Le canzoni eroiche del Petrarca ci parvero roba letteraria. C'era in lui il grande artista, non c'era l'uomo. Pure, nella sua canzone all'Italia ammirammo la sincerità del sentimento giovanile. Venendo poi alla lirica amorosa, uso com'ero a collaborare coi giovani, feci fare parecchie ricerche sull'indole di quella lirica, indicando loro i libri da consultare. Fu questo il tema di parecchi componimenti. Uno scrisse sul culto della donna, un altro sul concetto dell'amore platonico, un terzo sopra Beatrice e sopra Laura. Vi furono lavori di qualche importanza, e discussioni interessanti. Le lezioni sulla lirica di Dante parvero una rivelazione. Conoscevamo la Divina Commedia a menadito; ma quella lirica era nuova a me e a loro. Mi capitò un esemplare muffito, macchiato e di caratteri antichi, che irritavano l'occhio. Certi sonetti mi fecero venir le grinze al naso: "Che roba è questa?" Mi pareva fra Guittone o fra Iacopone. Mi venne il sospetto d'interpolazioni o di falsificazioni. Poi mi furono innanzi sonetti vivi e freschi, che parevano scritti oggi: "Questa è poesia per tutti i secoli!" Feci notare che i sonetti buoni avevano a base un fatto concreto e una situazione determinata, con accordo di stile e di accento e di colore, e non vi comparivano le sottigliezze e i luoghi comuni del secolo. La canzone della visione della morte di Beatrice, e l'altra sulle tre suore destarono viva ammirazione, e parvero i monumenti piú importanti della nostra lirica. M'è ancora presente il fremito di tutta la scuola, quando dissi:
.... non sai novella?
Morta è la donna tua, ch'era sí bella;
e quando lessi:
.... Morte, assai dolce ti tegno:
Tu déi omai esser cosa gentile,
Poiché tu se' nella mia donna stata.
Fu anche applaudito il verso:
L'esilio che m'è dato, onor mi tegno.
La semplice lettura destava questi entusiasmi. Solevo però prepararli, riempiendo le lacune della situazione, e notando le idee accessorie, che fermentavano nel cervello del poeta, condensate in sintesi gravide, solevo dire, piene di cose. Critica pericolosa; ma ci riuscivo, perché, come un bravo attore, dimenticavo me nella situazione, e non vi aggiungevo niente di mio. D'altra parte avevo fatto molto progresso nell'arte del leggere, e ne avevo qualche obbligo a un tal Camilli, che teneva scuola di declamazione, dove, imparando a recitare con verità e naturalezza, avevo corretto quel po' d'enfasi stridente e piagnucolosa, che m'aveva appiccicato il Bidera. Ci conferiva anche il gusto che mi si andava purificando, e quel mio viver dentro nella lettura, sí che non mi sfuggivano le piú lievi gradazioni del pensiero o del sentimento. L'intonazione era giusta, l'accento sincero, la voce insinuante, fatta piú alla dolcezza che all'energia, non mai monotona. Dicevo che le cose hanno ciascuna la sua voce, e quando qualcuno, leggendo, non aveva la voce abbastanza flessibile e mutabile, mi veniva il mal di visceri, e non sapevo infingermi. Me la prendevo coi maestri, che non sapevano leggere; e dicevo che il modo di leggere mi mostrava il valore del giovane piú che qualunque esame, ciò che sembra un paradosso, ed è verità. Quando ero chiamato a qualche esame, solevo far leggere qualche periodo, e a dare il giudizio non mi occorreva altro. Queste parranno puerilità; ma penso anche oggi cosí. In Napoli pochissimi sanno ben leggere e ben pronunziare, e il fatto comincia nei fanciulli, che imparano in modo cosí barbaro a compitare. Il marchese ci si arrabbiava. L'importanza della buona pronunzia e delle letture pubbliche non è ancora ben capita. La lettura che facevo io m'impressionava tanto, che mi si ripercoteva nella memoria per piú d'un giorno, e i piú bei luoghi mi giravano per il capo, e non mi volevano lasciare, e mi gettavano in dolci fantasie.
Parlando di Dante, toccai del suo amico Guido Cavalcanti, e ci colpí non la vantata canzone sull'amore, ma le deliziose strofe sulla forosetta, e ancora piú la canzone sulla Mandetta, dove sentivamo il fremito d'una passione sincera, cosa rarissima nella nostra letteratura.
Sapevamo a mente molti sonetti e canzoni del Petrarca, e appunto perché dimesticati con lui, ci fece poca impressione. Poi, il petrarchismo, da noi tenuto a vile, noceva un poco al Petrarca, a quel modo che l'abuso della religione non è senza cattivo effetto sul sentimento religioso. Pure, io tenni molto a rialzare il concetto del Petrarca, e ciò feci a spese de' suoi imitatori. Notando che l'ispirazione del poeta era spesso letteraria, come nelle stesse tre canzoni sorelle e in molti sonetti sulla bellezza di Laura, trovai le orme d'una ispirazione sincera nella sua malinconia piena di dolcezza e di grazia; piú che poeta, io lo chiamai un grande artista. I giovani si misero a scernere il buono dal cattivo, e in queste ricerche e distinzioni si affinava il nostro gusto. Feci anche una curiosa ricerca. Avvezzo a guardare il di fuori nel di dentro, volli fare una storia del suo amore, cercando la successione e la gradazione dei sentimenti, e trovando cosí un prima e un poi in quelle poesie. Fu una volata d'ingegno, dalla quale uscirono una storia intima del poeta e una classificazione delle poesie, secondo lo stato dell'animo e la qualità dei sentimenti. Ciò piacque molto; ma piú tardi mi parve un romanzo e non ci pensai piú. Venendo ai nostri tempi, toccato del Parini e del Foscolo, mi fermai sopra il Manzoni e il Leopardi. Il Berchet non era ancora giunto tra noi, e appena qualche sentore si aveva del Giusti: se ne mormorava qualche strofa a bassa voce. Giudicai gl'Inni del Manzoni cosa letteraria, eco piú del talento individuale che di un vivo e profondo sentimento nazionale, stimando fittizio e superficiale quel sentimento neo-cattolico, che allora faceva tanto strepito. Anche il Cinque maggio mi parve opera letteraria, tale però, per vigore di concezione, per unità di getto, per grandezza d'immagini e per forza di stile, che in questo genere si poteva chiamare il piú grande monumento della nostra...
[Pagina successiva]