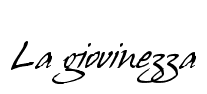[Pagina precedente]...rchese mi diede un bravo. Pure io non ci misi malizia; il mio intelletto era fatto cosÃ, e pareva arte quello ch'era natura.
Mi è saltato innanzi fra i tanti miei scartafacci un sunto di questi discorsi, essendo mio costume di notare per iscritto i concetti piú importanti delle mie lezioni. Quel sunto mi è parso magro e plebeo. Ero solito rifrugare quei concetti in me, e lungamente meditarvi sopra, e poi, parlando, mi rivenivano, ma con piú luce e piú energia. Quel sunto mi è parso il mio cadavere. Chi mi dà l'uomo vivo? Chi mi dà tanta parte di me, consumata in quel tripudio di un cervello esaltato, mosso da una forza allegra? Tutto questo è morto nel mio spirito, e non posso risuscitarlo. E morte sono quelle analisi e quelle critiche, una collaborazione, nella quale giovani e maestro entravano in comunione di spirito, ed in quell'attrito mandavano scintille. A che giovano le memorie? Di noi muore la miglior parte, e non ci è memoria che possa risuscitarla.
Capitolo ventiduesimo
REMINISCENZE. AGNESE
Sono già parecchi giorni che i medici mi hanno consentito di prendere un boccon d'aria, non piú che un'oretta. Mi è parso uscir di prigione, ed ho respirato a grandi sorsi, e mi sono sentito allargare il petto e i visceri. Mi sono ricordato le lunghe passeggiate di un tempo, là a Capodimonte o sul Vomero; ma ohimè! debbo camminare adagio e non mi posso stender molto lungi. Oggi, 8 marzo, mi sento meglio in gambe, e sono stato alla solita passeggiata, lungo il corso Vittorio Emanuele. Giunto al convento dei Pasqualini, là dov'ero solito rimettermi in carrozza e rifare la via, mi è venuta la voglia di far ritorno per un'altra via: tanto, non mi sentivo stanco, e le gambe volevano ancora andare. Sono sceso lemme lemme, per una scala erta, che mi hanno detto menare alla chiesa della Madonna dei Sette Dolori. Guardo e guardo: cercavo la casa dov'erano i Fernandez, e non trovo nulla, e non ravviso la strada. L'ingegneria, per fare il corso Vittorio Emanuele, ha disfatto due strade belle a quei tempi miei, quella di San Pasquale e l'altra di San Martino. Scendo e scendo e non mi ci raccapezzo. Giunto alla chiesa, respiro: tutto mi torna a mente. Laggiú è Magnocavallo, la strada nobile che mena a Toledo. Ma io piego a mancina e fo adagio quella scalinata lunga e sozza, fermandomi a ogni tratto, e mettendomi la mano sulla fronte, come se volessi evocare la mia giovinezza, vissuta in quelle parti. Giungo al palazzo ove abitavano e non so se abitano ancora i Minervini. A dritta è la strada del Formale. Mi ci avvio quasi automaticamente, ancorché non fosse la mia strada. Ma era la strada della mia prima giovinezza, piena di memorie. Da quella parte la via è incassata tra due mura alte e nude di vecchi conventi, entro di cui sono incavati certi primi piani e certe stanze terrene, simili a covili: un putridume. Le vedo imbiancate, ripulite, e vedo la via bene spazzata. "Manco male, - dissi; - qui c'è progresso". L'occhio da lontano afferrava già il portone numero 23. Mi ci fermo, e quell'entrata, dove sonarono già i miei clamori fanciulleschi, mi pare sporca e umida. Certi monelli cenciosi mi guardavano con un occhio interrogativo, come volessero dire: "Cosa vuole questo signore?" Mi fo un po' lontano, ed alzo un'occhiata su al terzo piano, e veggo una donnicciuola ingiallita, d'aspetto volgare e civettuolo, là sul balcone dove io soleva declamare le ottave del Tasso. Mi pare proprio un insulto quella donna. Scendo ancora e do un'occhiata obliqua al numero 39, a sinistra, dove fui cosà spesso a visitare zia Marianna, con zio Carlo e Giovannino. "E dove sono ora?" Vengo in malinconia e rifò i miei passi, e m'imbocco per la strada Rosario a Porta Medina. Giunto al larghetto dove è posta la chiesa, mi batté il cuore, ché presso v'è la casa da me abitata. Entro risolutamente nel cortile e guardo la scalinata. "Cosa volete?" dice una vecchiarella. "Eh! niente. Qui ho abitato, piú di trent'anni or sono". "Gesummaria! - disse lei, come vedesse l'orco; - trent'anni!" "In questo caso, io dovrei ricordarmene, che sono antico di qua", disse un uomo grosso, cavandosi il berretto. "Sì? Ma io non mi ricordo di te, - diss'io. - Ti ricordi tu quando venivano qui tanti scolari?" Restando esso tra il sà ed il no, gli domandai: "Ma in che anno sei venuto tu qui?" "Signore, nel 1845". "E io ci fui nel 1841" "Eh! oh! eh!" Io li lascio là ad esclamare, e mi pianto su l'uscio, e guardo su, dirimpetto, al terzo piano, e vedo il balconcino; ma non c'era lei. Povera Agnese! Mando cosà un respiro alla creatura dei miei passati dÃ, e torno lentamente a casa, pensoso e tutto pieno di questa giornata. Ho voluto raccontarla.
Sicuro! Dirimpetto al mio balcone era un balconcino, sul quale gli studenti gittavano furtivi sguardi. Assorto negli studi, non me n'ero avvisto; poi, guardai anch'io. Avevo preso l'abitudine di gittar per via occhiate alle donne, senza malizia, perché il mio spirito era altrove. In Napoli c'è spesso un saettÃo di occhiate tra balcone e balcone: cattiva abitudine anche questa. Ciò si chiama uno spassatiempo, un modo di passare il tempo. La donna era per me non so che vicino alla Divinità , troppo lontana da quelle ombre femminili che mi rasentavano il fianco per via. Il mio intelletto, profondato negli studi, era rimasto involuto, e non c'era entrata la malizia. Guardai a quel balconcino, e vidi una signorina vestita con semplicità non priva di gusto, un po' magrolina, con due occhi che parlavano. Ero cosà timido che non osavo guardarla fiso in faccia, e la guardavo con la coda dell'occhio. Ella stava là come una esposizione, e si faceva guardare. Talora la guardavo per di sopra a un libro che avevo in mano. Anche passeggiando e ripensando la mia lezione, gli occhi scappavano verso il balconcino. Sembra che ella sapesse tutte le mie ore, perché, affacciandomi, la trovavo sempre lÃ. Se con me erano altri giovani, la stava pur là e tirava occhiate di fuoco, mentre io voltavo le spalle per non farmi scorgere. Ma quando di lontano vedeva venire zio Peppe, la scappava subito: quella figura erculea e fiera le faceva paura. Cosà continuarono le cose per parecchi mesi. Io non ci pensavo che quando ero al balcone. Tutti i giorni si somigliavano: non si andava innanzi né indietro. Vedevo che la mi faceva di gran gesti; ma non ne capivo nulla. Talora si tirava dentro, e alzava la voce e pestava dei piedi; io guardava intontito: mi pareva una matta. Un sabato, dopo pranzo, che zio Peppe era sortito per non so quale faccenda, mi vedo volare sulla testa un involto di carta. La raccatto, lo spiego, ci trovo una letterina profumata, e vi era scritto cosÃ: "O mia celeste Emilia, domani a vent'ore sarò a San Martino. Verrai?" Rimasi trasognato. Voltavo e rivoltavo quella carta, e guardavo al balcone, e non c'era nessuno. Credo che la dovesse star da un canto, e farsi le grasse risi della mia dabbenaggine.
Il dà appresso Zio Peppe era andato a dir messa, e io, fattomi al balcone, vidi lei un po' indietro, e mi vidi piovere sopra un secondo involto. Lo afferrai per aria, e vi trovai scritta la stessa canzone, e sentivo di là dentro venire una voce che pareva fosse l'eco, e diceva: "Verrai? verrai?" Io presi subito una carta e ci scrissi sopra: "SÃ"; ma vidi ch'era troppo leggiera e sarebbe cascata giú. Presi un cartone e ve la inviluppai dentro, e con un filo la legai bene, e la lanciai di gran forza, che pareva volessi sfondare il muro. Ella apri con avidità , credendo trovare un letterone, e come vide quel sà asciutto, alzò il muso, in aria di disappunto. Io, spaventato della mia temerità , m'ero fatto un po' indietro.
Quel dà mangiai distratto. Zio Peppe scherzava sulla mia distrazione, e m'andava stuzzicando. Ma mi girava pel capo la mia bella del balconcino, e lo lasciavo dire e alzavo un tantino le spalle. Alle frutta mi levo in furia e in fretta, m'infilzo l'abito e mi calco il cappello. "Dove vai?" disse lui, guardandomi sospettoso. Quella sua guardata mi fece salire una fiamma sul volto. "Vado, - fec'io; - fra un par d'ore sarò qui". "Bene, t'aspetto. È la prima volta che ti vedo uscire a quest'ora e con questi calori. Bada, non sudare, e fai presto, ché vogliamo farci una bella passeggiata al fresco".
Quando fui in istrada, m'incamminai frettoloso, ché mi pareva l'ora tarda, e feci, a quattro a quattro, le scale che menano alla Madonna dei Sette Dolori, e volsi a dritta e infilai la via di San Martino. Salgo e salgo; avevo il fiato grosso e mi fermai alla terza rampa, dove era un bel giardino, convegno di gente allegra che andava là a fare baldoria. Mi si apriva innanzi la vista di mezza Napoli, case addossate a case, di mezzo a cui spiccavano cupole e campanili. Alzai il capo, e non mi parve mai cosà bello quel vivo, limpido azzurro del cielo. Mi ricordai che, nella mia adolescenza, di là appunto avevo mirato, tra gran folla, uno dei primi palloni che in Napoli si fossero alzati a spettacolo, e la zia mi tirava per la mano e diceva: "Vedi, vedi il pallone, è lÃ"; e mi indicava col dito, e io ficcavo gli occhi tra le nuvole e non vedevo niente, e mi arrabbiavo, e zia diceva: "Cosa ci vuoi fare? sei miope". Era la prima volta che sentivo parlare della mia miopia. Quella ricordanza se ne trasse appresso molte altre, ché quella era la via solita dei miei trastulli coi cugini e coi compagni. In quel giardino facevamo le nostre merenduole, e andavamo a mangiare le troianelle, i dolci fichi cosà cari ai napoletani. Pensando a quella innocenza di vita, mi parve una follia quel correr dietro a una donna, e il cuore mi disse: "Torna, torna, ché zio Peppe ti aspetta". Rifeci un po' i miei passi, sospeso tra il sà e il no, e l'occhio errava distratto tra quella infinità biancheggiante di case, e là vedevo lei, e non potevo cavarmela dinanzi, e mi sentivo mormorare all'orecchio quel suo: "Verrai?" Mi fermai, pensando a quel mio sÃ, e che ella era là e m'attendeva, e la bella figura ch'io farei: "Dirà per lo meno ch'io sono un buffone". Salivo già , tra questi pensieri, e mi trovai su quell'ampia pianura erbosa ch'è alle spalle di Sant'Elmo. Guardavo e non vedevo nessuno, e mi venne il pensiero che la bricconcella si fosse voluta pigliare gioco di me. "Tanto meglio", dissi, e feci per tornare, pensando a zio Peppe, quando la vidi sbucare di mezzo alle erbe, che mi parve una ninfa. "Ciccillo", fece ella, e mi tese la mano. Io la guardai, stupito. "Conoscete il mio nome?" "Sicuro! ti ho inteso tante volte chiamare da zio Peppe con quella sua vociona". "E conoscete pure zio Peppe?" fec'io, e la guardavo trasognato.
Ella rideva rideva, mostrando una fila di denti bianchissimi, e diceva: "Come vedi, io sono di casa". E qui, saltellando e tirandomi seco, mi raccontò la lunga storia dei suoi sospiri, dicendo di me alcune particolarità che mi facevano stupire. Mi fece sino il nome di qualche signorina alla quale davo lezione, e faceva la gelosa e diceva: "Già si sa, il signor maestro non poteva pensare a me". Mi venne innanzi come un baleno ch'ella mi umiliasse; ma non avevo tempo di fissare la mia idea, ch'ella parlava cosà lesta come camminava, e non mi dava tregua, e mi tirava nei suoi pensieri e nelle sue impressioni. Mi fece molto ridere di quel "letterone". "Diavolo! un maestro tuo pari uscirsene con quel sà secco e smunto; mi attendevo un bello scritto, ché so scrivere anch'io e ho una bella calligrafia". "Vi faccio i miei complimenti", diss'io. Ed ella mi parlò dei suoi studi, e come sapeva un po' di disegno, e aveva fatto anche la sua grammatica. "Bravo voi", diss'io. "Voi! voi! sempre con questo voi! Tu mi devi dare del tu". "Ma una signorina come lei..." "Ah! eccoci ora col lei. Tu mi confondi la grammatica, signor maestro!" Io mi feci rosso come uno scolarello colto in fallo. E lei, sdegnosa, mi prese la mano e disse: "Tu mi devi dare del tu, hai capito?" "Ma se questo tu non mi vuole uscire!..." "Ma tu non capisci che noi siamo predestinati ad esser marito e moglie?"
Qui la disse un po' grossa. Io mi feci un po' indi...
[Pagina successiva]