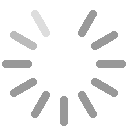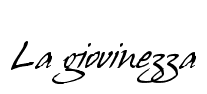[Pagina precedente]...are" Vittorio Alfieri, e seccavano tutti quanti. I miei temi erano letterine o fatterelli, di rado descrizioni, e sempre cavati da cose note e facili. Il difficile, il raro, il complicato, l'epigrammatico, l'indovinello mi è stato sempre antipatico. I piú svelti facevano di bei lavoretti. Io soleva staccare periodi buoni o cattivi, e li fissava lí sulla lavagna, e ne faceva tema d'interrogazione: ciascuno stava teso a domandar la parola, a fare la sua osservazione. La mia lezione divenne cosí popolare, che i piú grandi, quelli dell'ultimo anno, desiderarono ch'io li esercitassi nello scrivere, e io lo feci ben volentieri.
Cosí le cose andavano nel Collegio mica male, con soddisfazione mia e dei miei alunni. Scendendo di là, mi andavo a chiudere nel Caffè del Gigante, dove usavano negozianti stranieri, posto nelle sale terrene del palazzo del principe Leopoldo (Borbone). Erano quattro o cinque stanze ben larghe e ben pulite, cosa rara in Napoli, dove spesso il caffè non è che una stanza sola. Vi si beveva un caffè buono, del quale io era ghiotto. Ma ciò che mi tirava là erano i giornali francesi. C'erano lí il "Siècle", i "Débats"; c'erano anche, pe' negozianti inglesi, il "Times", il "Morning-Post". Scrivevo e pronunziavo il francese poco bene, ma l'intendeva benissimo, e leggevo in un baleno. Trovai nei "Débats" le tornate della Camera dei Deputati e del Senato. Mi ci gittai sopra con avidità. Quella lettura divenne per me come una malattia, che mi si era appiccicata addosso: non potevo starne senza. La domenica, che non c'era tornata, mi sentivo infelice. I miei eroi erano Molé, Guizot, Berryer, Montalembert; ma il mio beniamino era Thiers. La sua Storia della rivoluzione francese mi aveva ubbriacato; quel suo dire didattico e insinuante mi rapiva. C'era nella sua maniera non so che di maestro di scuola, un voler spiegar le cose, senz'aria però di pedagogo, anzi facendosi piccino per meglio conquistare i suoi uditori. Sentivo in lui confusamente qualche cosa che rispondeva alla mia natura. Il mio genio mi tirava sempre all'opposizione, alla minoranza. Avevo poca simpatia però con l'enfasi nebulosa di Odilon Barrot, e con gl'impeti a freddo di Ledru-Rollin. Stavo cosí profondato in quelle letture, che non vedevo altro, non udivo niente. Non era già un'attenzione letteraria solamente; io ci portava un'emozione e una passione, come fossi un francese, e mi trovassi lí, e prendevo parte per l'uno o per l'altro. Giunto appena nel Caffè, la mia impazienza era vivissima, e, mentre bevevo, divoravo già con gli occhi il giornale. Quei maledetti vecchi negozianti mi facevano crepare di rabbia con la loro flemma. Quando prendevano un giornale, non lo lasciavano piú. Io mi rodevo e dicevo tra me: "Pezzo d'asino! mi pare quasi che stia lí compitando le lettere". Altro che mezz'ora! Io contavo i minuti, e mi pareva che stessero lí le ore intere.
Un giorno vidi uno di quei cotali, e mi presi in fretta il giornale, mentre bevevo il caffè. Egli notò la mia manovra, si accostò gravemente, e disse: "Pardon", e si riprese il giornale. Io non ci vidi riparo, e lo lasciai fare. Strettamente la ragione era sua: tu bevi il caffè, lascia leggere me. Nella mia vita ci è stato sempre questo, che non ho mai osato di oppormi deliberatamente a cosa che in fondo la mia coscienza dichiarava ragionevole. Quel mostrare di aver ragione, quell'alzar la voce e volere imporsi, quel dire sí quando la coscienza dice no, il presumere e il pretendere non mi è andato mai ai versi. Quel prendere il giornale di sul tavolo dov'era quel signore, mi era parsa una gherminella, e al suono di quel "Pardon" mi venne il rosso fino sulla fronte. Il messere squardernò il giornale, inforcò due occhiali verdi, si prese una grossa "pizzicata" di tabacco, si pose il giornale sotto il naso, e andava dimenando il capo da destra a sinistra e da sinistra a destra. Io credevo che per delicatezza dovesse far presto, sapendo ch'ero lettore anch'io, e che stavo lí aspettando il suo comodo. Guardavo, cosí, distratto, ma l'occhio ansioso lo spiava, e quel lento movere del capo mi pareva eterno. Per farlo venire in sé, guardai piú volte l'orologio, e una volta dissi a mezza voce: "Diavolo! sono già le dieci e mezzo". Fiato sprecato. Quel galantuomo prese una "pizzicata" di tabacco, e io cacciai fuori uno sbadiglio. Ecco il mio uomo entrare in conversazione. Io stendo la mano e dico: "Pardon", e cerco di pigliare il giornale; ma lui, piú lesto di me, disse: "Pardon", e ci ricadde sopra col naso. Gran Dio! era uno sfinimento. Si avvicinavano le undici, ora in cui solevo terminare le letture e avviarmi al palazzo Sangro. Parte puntiglio, parte curiosità, non mi risolsi di andar via, preferendo quella lettura, tanto piú gustosa quanto piú ritardata, all'adempimento del dover mio. Gridai: "Cameriere!" Venne; e, trovati due soldi di regalo per lui, disse: "Grazie". "Come si fa? - diss'io, - anch'io ho diritto di leggere". Il cameriere capí, e si voltò a quel signore pancione e tabaccone, dicendo: "Quel signore aspetta". E lui senza moversi disse: "Ho finito". Io respirai; l'amico era in terza pagina, e stava col naso giú giú. Fra poco avrà finito! Ma che finito d'Egitto! Egli spiava me di sotto agli occhiali, mentre io spiava lui, e, tranquillo e impassibile, voltò la quarta pagina. "Anche gli annunzi, - diss'io, - costui legge anche gli annunzi!" Vidi in lui un mezzo riso, e mi balenò che in lui doveva esserci partito preso, e che per me non c'era misericordia. Uscii sconfitto, in collera contro di me che avevo perso tanto tempo attorno a un imbecille. E giurai che non ci sarei capitato piú. Ma poi ci capitavo spesso; la natura era piú forte dei giuramenti.
Quelle letture mi facevano tanta impressione, ch'io ne parlavo con tutti, in ogni occasione, e faceva dei soliloqui, perché nessuno leggeva i giornali. Io avevo tale memoria, che spesso ripetevo punto per punto qualcuno di quei discorsi. Essi mi udivano con maraviglia, ma senza interesse. Di politica si parlava poco, e io stesso sentiva un'ammirazione letteraria per quei potenti oratori; ma di politica non me ne incaricavo, secondo il motto napolitano. Erano alla moda pettegolezzi letterari; cominciavano a uscir fuori "Omnibus", "Poliorami" e "Strenne"; le menti costrette in piccol cerchio impiccolivano e pettegoleggiavano. Si chiacchierava ancora molto di musica. Bellini morto, era piú vivo che prima. Era il tempo di Lablache e della Malibran. San Carlo era nel suo pieno fiore; la Norma aveva voltato i cervelli i motivi li sentivi canticchiare per tutte le vie. In mezzo a queste ebbrezze musicali e letterarie io ero una stonatura; e mi piantavano lí con Thiers e Guizot, sicché finii con ruminarli io tutto solo. La mia vita intellettuale si compendiava nel caffè del Gigante e nella scuola al vico Bisi. Sembravo un estraneo alla società, che mi respingeva da sé con un'alzata di spalle. Io passava per le vie, pensando alla scuola o al caffè, e m'era dolce naufragare in quel piccolo mondo, ch'era il mio "Infinito".
Capitolo sedicesimo
LA SCUOLA AL VICO BISI
Chi sa perché questo vicolo fu chiamato Bisi? Oggi lo chiamano vico Nilo, ed è un termine piú presentabile. Del resto, esso era degno di quel nome. C'era lí da impiccarsi per malinconia. Figurarsi un vicolo stretto stretto, con case altissime, che pare ti si congiungano sul capo e ti rubino la vista del cielo. Là, in una gran sala oscura, s'impiantò la scuola nel modo piú semplice: un tavolino nudo, non netto di macchie d'inchiostro; un discreto numero di sedie piú o meno impagliate, e lunghe file di panche. Le mura bianche e nude mi recavano alla mente il mio stanzone da studio. La decorazione c'era, ed era nel cuor mio e dei miei giovani, che vedevamo lí attaccate a quelle mura tutte le memorie della nostra vita intellettuale. Quando io entrava colà, e, cambiato uno sguardo coi giovani, mi si accendevano gli occhi e mi si scioglieva la lingua, quella sala mi appariva splendidamente decorata dalle immagini generate dalla mia fantasia. Né quel luogo pareva poco decoroso al marchese Puoti, uomo semplice, ch'era egli medesimo di quella sala la piú bella decorazione.
Il mercoledí era giorno di traduzione. Ci veniva il marchese, e si faceva presso a poco quello che s'era fatto nel suo studio, salvo che, essendo ivi gioventú nuova, capitata allora allora dalle provincie, al marchese non parea di stare in casa sua, tra gente familiare, e usava un po' piú di riserbo nei modi e nelle parole. Anche la mia presenza gli faceva una certa impressione, perché io gli stavo a lato teso e duro, con la faccia oscura e severa, e non ridevo mai; i suoi scherzi e i suoi motteggi cadevano freddi in mezzo a una gioventú che la mia imperturbabilità teneva in soggezione. La scuola prese presto un'aria magistrale, e fu smesso quel tono di familiarità scherzevole, che piaceva tanto in casa del marchese. Non c'era ancora comunione spirituale tra maestro e discepoli; e quell'aria magistrale portava facilmente seco non so che di grave e pedantesco, che in certi intervalli ti toglieva ogni elasticità di pensiero, e la noia ti possedeva. Quel mercoledí era il giorno dello sbadiglio; era quella stessa scuola di Basilio Puoti, ma senza genialità, senza sale: la veste era pur quella, ma lo spirito era altro. il marchese ci stava a disagio; io parlavo poco, con un'aria fredda, che pareva alterigia ed era timidezza. Talora venivano alcuni dei piú provetti suoi discepoli, e questi pigliavano la mano e dottoreggiavano e animavano la scuola. Sorgevano dispute, e ci si metteva l'amor proprio; gli "Anziani" volevano mostrare la loro superiorità; gli altri li ribattevano e non se la lasciavano fare; il marchese balzava fuori col suo naturale, le fronti si spianavano e le ore passavano rapide.
Lunedí e venerdí ero solo io, e la scuola prendeva un'altr'aria. Mutolo e timido, quando il marchese stava lí, allora mi sentiva io, e mi metteva tra quelle panche a confabulare, a interrogare, a spiegare; e presto giunsi ad affiatarmi con quei giovani quasi tutti della mia età. Quando s'era fatto numero, salivo su di una cattedra e dettavo grammatica; poi mi mettevo a tavolino tra un cerchio dei giovani piú attenti, e si faceva la lettura. Col mio fare monotono e severo c'era da morir di noia; ma tant'era la mia vivacità, e la novità delle cose, che presto vivemmo tutti insieme entro quegli studi, e non udivi batter sillaba, e la scuola pareva una chiesa di quacqueri. Ciascuna lezione spremeva il miglior sugo del mio cervello. Io mi ci preparavo per bene, e tutto il dí non facevo che pensare alla lezione, anche per istrada, gesticolando, movendo le labbra; e gli amici dicevano, canzonando: "Che fa De Sanctis? Pensa alla lezione". Talora mi riscotevo, veggendo qualcuno guardarmi e ridere; ma poi tiravo di lungo con aria sdegnosa, come chi dicesse: "Gente, a cui si fa notte innanzi sera".
Il mio disprezzo dei poltroni e dei vagabondi era infinito, e battezzavo cosí tutti quelli che non si profondavano negli studi. Pensando sempre alla stessa cosa, mi stillavo il cervello; il pensiero si volgeva in un vano fantasticare, e, non reggendo piú al gioco, mi veniva la distrazione; altri oggetti mi passavano innanzi, e finivo con sottigliezze e con frasi incoerenti: il cervello diveniva fumoso e pieno di ombre. Talora si avvicinava qualcuno e si ostinava a volermi tener compagnia. Io a fargli capire che volevo star solo, e lui a non volerla capire, e a dire: "Non fate cerimonie, tanto non ho che fare". E mi si cuciva ai panni, e parlava parlava, e io non sentivo niente che mi si aggirava la lezione per lo capo; e lui a voler per forza una mia risposta, e io col mento in aria, e lui da capo ricominciava la storia: era uno sfinimento, un tormento; l'avrei preso per la gola. Uno di questi, un tal Tommaso, mi ricordo, non gli bastando l'avermi seccato per tutta la lunga via, giunto al portone di casa, a me che gli dicevo addio, disse: "No, no, vi pare! vi accompagno per le scale". E sali, e mi entrò in ...
[Pagina successiva]