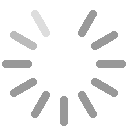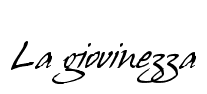[Pagina precedente]...oro erano eccellenti nell'analisi delle forme grammaticali, risalendo alle forme semplici e primitive: cosí "amo" vuol dire "io sono amante". La ellissi era posta da loro come base di tutte le forme di una grammatica generale. Questo non mi contentava che a mezzo. Io sosteneva che quella decomposizione di "amo" in "sono amante" m'incadaveriva la parola, le sottraeva tutto quel moto che le veniva dalla volontà in atto. I giovani sentivano quei giudizii acuti con raccoglimento, e mi credevano in tutta buona fede quell'uno che doveva oscurare i francesi e irradiare l'Italia di una scienza nuova.
E in verità io sosteneva che la grammatica non era solo un'arte, ma ch'era principalmente una scienza: era o doveva essere. Questa scienza della grammatica, malgrado le tante grammatiche ragionate e filosofiche, era per me ancora un di là da venire. Quel "ragionato" appiccicato alle grammatiche era una protesta contro la pedanteria passata, e voleva dire che non bastava dare le regole, ma che di ciascuna regola bisognava dare i motivi o le ragioni. Paragonavo i grammatici o accozzatori di regole agli articolisti, che credevano di sapere il Codice, perché si ficcavano in capo gli articoli, parola per parola, e numero per numero. Ma quel ragionare la grammatica non era ancora la scienza. Certo era un progresso, e io ne dava lode ai nostri del Cinquecento e ai francesi, i quali ponevano la spiegazione della regola ora nella derivazione da lingue precedenti, ora nell'uso dei buoni scrittori, e ora nell'uso vivo del popolo, e cosí ne tiravano notizie utili e ragioni plausibili. Ma questo agli occhi miei era una storia, non una scienza; e cercavo la scienza al di sotto delle forme, nel movimento immutabile delle idee, dei giudizii e del discorso. Cosí trovavo nella logica il fondamento scientifico della grammatica; e finché mi tenevo nei termini generalissimi di una grammatica unica, come la concepiva Leibnitz, il mio favorito, la mia corsa andava bene. Ma mi cascava l'asino, quando veniva alle differenze tra le grammatiche, spesso in urto con la logica, e originate da una storia naturale o sociale, piena di varietà e poco riducibile a principio fissi. Per trovare in quella storia la scienza, si richiedeva altra cultura e altra preparazione. Nella mia ricerca dell'assoluto, avrei voluto ridurre tutto a fil di logica, e concordare insieme derivazioni, scrittori e popolo; ma, non potendo sopprimere le differenze e guastare la storia, ponevo l'ingegno a dimostrare la conformità del fatto grammaticale con la logica, della storia con la scienza. Chi vinceva avea sempre ragione; e coi piú sottili argomenti dimostravo la ragione della vittoria.
Anche nel metodo volevo la scienza; e metodo scientifico era non l'arbitrario succedersi delle cose, secondo i preconcetti di questo o di quello, ma la cosa stessa nel suo movimento naturale. Io voleva una sintesi provvisoria, per darmi il piacere di decomporla e procedere analiticamente e riuscire poi ad una composizione definitiva. La mia sintesi provvisoria era il discorso di cui davo una spiegazione intuitiva, esponendone le parti in un gran quadro sinottico. Poi, biasimando quel rilegare in ultimo l'ortoepia e l'ortografia, io cominciavo dalle sillabe e dalle parole, in quanto sono pronunziate e scritte, salvo l'interpunzione, ch'era l'ultimo capitolo della mia grammatica. Indi le parole erano analizzate secondo il loro contenuto, sostanze, accidenti, modificazioni, alterazioni, e parecchie cose nuove mi uscivano dette intorno agli articoli, a' pronomi, agli avverbi, alle preposizioni, alle congiunzioni. Mi ricordo di un quadro, nel quale andavo significando tutti i movimenti intellettuali e materiali, e vi sottordinavo tutte le preposizioni, che parve cosa nuova e mirabile. L'ellissi rappresentava una gran parte in queste analisi, e cosí spiegai tutte le interiezioni, non dimenticando mai di ricomporre e dare il significato vivo della parola, dopo di averla decomposta e trovato il suo senso logico. Quando questo lavoro anatomico era compiuto, compariva in ultimo il verbo, come il principio della vita o del moto, che metteva in azione tutto quell'organismo. Inselvato in quel ginepraio di tempi, di modi e di verbi irregolari, aguzzando l'ingegno in ridur tutto a regola e a logica, uscivo tutto affannoso alla riva, e ritrovavo la sintassi. E qui le stesse pretensioni. Io non ammetteva la irregolarità e le eccezioni, e pretendeva che il mondo andasse sempre diritto: altrimenti, dov'era la scienza? Se allora avessi conosciuto Hegel, avrei battezzato per accidente tutto quello ch'era fuori della scienza; ma non ero abbastanza ingegnoso, e volevo per forza tirare nei confini della scienza tutti i fatti grammaticali. Non ammetteva che la sintassi fosse una parte distinta della grammatica. Col mio metodo genetico, io li faceva uscire naturalmente dalle analisi fatte, ricomponendo per virtú del verbo, e passando, con moto celere e trionfante, alle proposizioni, ai periodi e al discorso. La mia grammatica era un andare su su dalle parti piú semplici verso il discorso, il grande risultato della scienza, il principio e il fine. Di questa grammatica non mi è rimasta che una vaga reminiscenza. I giovani facevano un sunto delle lezioni, e un sunto da me corretto era il "libro della scuola", come lo si chiamava. Uno di questi sunti mi è venuto alle mani, per gentilezza del signor Tagliaferri, allora mio discepolo. Poco ci ho capito: già con questi occhi malati poco capir posso. Oh! come questi sunti mi paiono pallidi dirimpetto a quelle lezioni nelle quali compariva tutta l'anima. Avevo preso per costume di non ripetere mai un corso, e perciò quella grammatica rimase boccheggiante cosí come era stata abbozzata una volta, uno schizzo piú che un disegno finito, rimasto lí in aria, mentre io, incalzato da nuove aspirazioni, metteva mano ad altri lavori. Pure, fu tanto l'entusiasmo grammaticale mio e dei giovani miei, che moveva quasi il riso, e ci chiamavano per ischerno "i grammatici", come chiamavano "linguaiuoli" o "frasaiuoli" gli scolari dei Puoti. La grammatica non s'insegnava che ai bimbi, e mi biasimavano che insegnassi grammatica a giovani fatti. "Ma c'è o non c'è una scienza della grammatica? - strillava io inferocito e con molti gesti. - E questa grammatica generale, comparata, filosofica a chi la insegnerete voi? Ai bimbi non di certo. Non è a lamentare che nei quadri universitari non ci sia la grammatica generale?"
In verità, io era il solo che insegnassi una grammatica di quella fatta, e, se molte osservazioni erano piú sottili che vere, se il metodo era forzato, se il contenuto era monco, se quella costruzione temeraria avea dell'affrettato e dell'imperfetto, se molte di quelle cose non attecchivano e non lasciavano orma, certo è che, fatta a quel modo, svegliava e alzava l'ingegno. Quel disprezzo delle apparenze; quel guardare di sotto alle forme; quel pigliare per punto fermo il contenuto, il pensiero, il significato; quei conati dietro all'unità, cercando il simile e il regolare in quel mare d'irregolarità e di eccezioni; quel continuo esercizio di composizione e scomposizione rinvigoriva gl'intelletti e li predisponeva alla scienza. Se in questa grammatica abbondava la scienza, molto scarsa era la parte dell'applicazione e dell'esempio. Io credeva che una gran parte della grammatica si dovesse studiare in modo pratico, leggendo, scrivendo, parlando. Ridotta la grammatica a generalità scientifica, ciò che propriamente si diceva "arte" io lo andava mostrando nelle letture, nelle composizioni e nelle conversazioni, con esercizi svariati e ingegnosi.
Capitolo diciottesimo
LETTURE E COMPOSIZIONI
Facevo la mia lezione di grammatica alla buona, seduto, senza gesti e senza intonazione oratoria, in modo familiare e didascalico. Il corso durò due buoni anni. Finita la lezione, facevo un po' di lettura. Caldo ancora di fantasmi grammaticali, cercavo gli esempli e le applicazioni nel libro, ricorrendo spesso alla lavagna, perché mi piaceva di parlare ai sensi, e non ristavo finché la cosa non era chiara a tutti. Avevo molta attitudine alle minuzie; sminuzzavo tutto, e su ciascuna minuzia esercitavo il mio cervello sottile. Quelli che mi sentivano filosofare in grammatica, e tracciare le cose a grandi tratti, non si persuadevano come foss'io quel medesimo cosí minuto nelle minime particolarità grammaticali. La stessa minuteria era nelle cose della lingua. Dopo di avere analizzato e rovistato in tutti i sensi il fatto grammaticale, mi divertivo con le parole, e con la mia infinita erudizione, attinta ai testi di lingua, di ciascuna parola dicevo i derivati e i composti, i sensi antichi e nuovi, le somiglianze e le differenze, tanto che mi chiamavano "il dizionario vivente". Talora la lettura non era che di un periodo solo, e prendeva una buona ora, e non la finivo piú, e mi ci scaldavo io, e ci si scaldavano gli altri. E quando, riscossomi e cavato l'oriuolo, vedevo l'ora e facevo la faccia attonita, quei cari giovani mi sorridevano dicendo: "Professore, quando vi ci mettete!..." Il fatto è che in quella scuola non si sentiva la noia, perché dicevo cose novissime con un calore, con una unzione che li teneva tutti a me, vivendo tutti la stessa vita.
In quell'anno lessi dei brani del Pandolfini, del Compagni e di Frate Guido da Pisa, e terminai con la famosa leggenda del carbonaio di Iacopo Passavanti. Nella prima lettura non andai piú in là del primo periodo del Governo della famiglia, e ci feci sopra le piú nuove e le piú sottili avvertenze, indicando le differenze di tutti quei sostantivi ammassati l'uno su l'altro, che esprimevano delicate gradazioni di una stessa cosa, e parevano simili ed erano diversi, e spiegavo anche il perché del loro collocamento. Spesso tiravo fuori il capo da queste nebbie di minute osservazioni, e mi trovavo in puro cielo, nel cielo luminoso dell'arte, e m'entusiasmavo io, e tutti si entusiasmavano, mutando io voce e colore e accento. Mi rimane ancora oggi l'impressione viva che fece la lettura del convito del Pandolfini. Quando lessi: "spento il fumo alla cucina, è spento ogni grado e grazia", e quando, con intonazione solenne, uscii in quel "solitudine e deserto", quella vivace gioventú non si poté contenere, e proruppe in applausi, affollandomisi intorno. Quella descrizione magnifica degli apparecchi del convito, dove tutto è pieno di senso, ch'io annotava e scolpiva, si trasformava nella mia calda analisi in una scena drammatica. Un'impressione piú durevole forse fece la descrizione graziosa di una festa, nella quale il nostro messer Agnolo Pandolfini colse la moglie che s'era imbellettata. Fece ridere quella "faccia imbrattata a qualche padella in cucina", e tutti colsero il garbo e la bonomia che è verso la fine, quando il marito, vedendola piangere, dice: "Io lasciai che s'asciugasse le lagrime e il liscio". Pure, questo benedetto libro non l'ho aperto piú dopo quel tempo, sono passati tanti anni e tante vicende, e queste frasi mi tornano alla memoria, e mi tornano quelle letture come se le facessi ora, sí forte fu l'impressione.
Una volta la settimana si faceva il lavoro. Di rado davo un tema; il piú delle volte se lo sceglievano loro. Io tornava a casa carico come un ciuco. Il dí appresso mi levavo di buon mattino, e cominciavo la lettura di tutti quei componimenti. Avevo fatto l'occhio ai diversi caratteri, tanto che anche oggi dalle scritture piú orribili me la soglio cavare. Mettevo in quel lavoro un'infinita pazienza, perché infinita era la mia coscienza: mi sarebbe parso un delitto l'andare in fretta o leggere a salti. Mettevo nel margine le correzioni con le debite osservazioni, e talora tiravo in lungo, perché volevo farmi ben capire. Fatta quella fatica, tornavo da capo a legger tutto, spesso aggiungendo altre postille; poi sceglievo in quella selva di errori quelli che davano occasione ad avvertenze grammaticali o di lingua, e che era bene che tutti sentissero. Questa era la mia occupazione di tutto il dí. Nel dima...
[Pagina successiva]