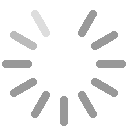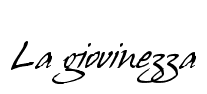[Pagina precedente]...a lui, mentre egli leggeva. Il principe era una bella persona, di modi squisiti. Parecchi segretari gli erano attorno, ai quali dettava: aveva l'aria della fretta. "Va bene", disse a me, sorridendo, con un gesto della mano, che significava: "Ora potete andare". Ma io non capii, e rimaneva lí piantato e teso. "Va bene, - replicò egli, calcando sulla parola, - dite al marchese che mi farò un intrigante per voi". Io, ignaro degli usi e timido e goffo, non mi movevo, credendo non mi fosse lecito andar via senza sua licenza. Egli, visto il mio imbarazzo, disse: "Addio, signor De Sanctis, mi saluti il marchese". Chinai appena il capo, e teso teso me ne uscii. Per le scale mi andavo correggendo, e dicevo che avrei dovuto far questo o quello. "Il principe si sarà fatta una gran risata a spese mie", conchiusi. In effetti, il marchese mi riferí che il principe mi aveva battezzato un tedesco. Entrando io tra gli altri giovani, egli, ridendo, esclamò: "Ecco il professor tutt'un pezzo". Talora mi chiamava per celia uno svizzero. Io mi faceva rosso rosso e non rispondeva. Intanto quel bravo marchese s'era fatto di fuoco per me.
Un giorno stavamo a pranzo, core a core, Enrico ed io. Fumavano quei bei maccheroni di zita, ed io li divorava con gli occhi, quando si udí sonare il campanello. "Chi è? chi non è?" Annarella corre e torna subito. "Gli è un signore tutto ricamato d'oro, che vuol sapere se abita qui De Sanctis". "Ma è uno sbaglio", diss'io. "Ricamati d'oro non vengono a casa nostra, - rifletté Enrico, - vanno a casa di principi". "E costui dev'essere qualche principe, - notai io. - Annarella, digli che ha sbagliato". Annarella torna, e dice che quel galantuomo non ha sbagliato, e che la casa è questa, e che cerca Francesco De Sanctis, e ha una carta per lui. "Alla buon'ora! Fatti dare dunque questa carta". Tornò e vidi un plico con un gran bel suggello, che mi fece l'effetto dell'uomo ricamato d'oro, e quasi non volea romperlo. "Fai presto", gridava Enrico battendo i piedi. E io aprii e vidi il nome del re con tanto di lettere. "Sarà un passaporto", dissi. Ma quando vidi ch'era il decreto di mia nomina a professore del Collegio Militare, ci levammo in piè e ci abbracciammo, e se non era per vergogna di Annarella, ci saremmo messi a ballare, cosí pazza allegrezza c'invase. Annarella, ci guardava trasognata, con la bocca mezz'aperta, come volesse dire e non dire. "Ah! quel signore", dicemmo a due, e fummo là dove quel brav'omo ci attendeva. "Grazie, grazie", diss'io con effusione. "Signurí 'o rialo", diss'egli, cavandosi il berretto. Io guardai Enrico, Enrico guardò me: in due potemmo appena fare un carlino. Egli partí borbottando, e forse dicea: "Che sfelienzi!". E noi ci guardammo, e ridemmo tutti e due, vedendo quel principe ricamato d'oro divenire un usciere gallonato, che faceva il pezzente. Annarella voleva sapere cosa era seguito. "È seguito, - diss'io, - che domani avrò tanti danari, che non saprò cosa farne". "Eh! ne farete un abito a Rosa, la mia cara figliuola". Glielo promisi; e mangiammo i maccheroni freddi con buonissimo appetito.
Era già qualche mese ch'io dava lezione ai figli del marchese Imperiale, Augusto e Checchino. Giunsi là gioioso, e narrai la mia buona ventura al padre. "Chi è stato il tuo Santo?" mi domandò. Io non capiva. "Il tuo merito è grande, senza dubbio, ma senza non si va avanti". Io capii e dissi: "Il mio Santo è stato Basilio Puoti".
Capitolo quindicesimo
IL COLLEGIO MILITARE E IL CAFFÈ DEL GIGANTE
Quando zio Carlo seppe la mia nomina a professore nel Real Collegio Militare, pianse e ricordò ch'egli aveva cominciato la sua carriera professore alla Real Paggeria, dov'era il Collegio di Marina. "E Ciccillo, tomo tomo, fa il suo cammino", conchiuse. Una certa apparenza d'insensibilità e una certa tensione nei modi mi avevano procacciato in casa quel nome di tomo tomo, e anche di tomo sesto.
A me stesso parve gran cosa quella nomina. Forse c'era quel pensiero del mensile fisso, che trae molti agli uffici di Stato; forse era curiosità, come d'una condizione nuova e ignota. Il fatto è che, quando venne il tempo, poco dormii la notte e, con aria impaziente, giunsi in carrozzella nel Collegio. Trovai al primo corridoio l'aiutante maggiore, un bassotto rugoso, con una cera punto militare, che mi guidò all'ultima camera, a sinistra. Quei ragazzotti si levarono in piè, e io salii alla cattedra posta vicino all'ingresso. "Sedete", gridò l'aiutante maggiore, quando mi fui seduto io, e tutti fecero come un sol tonfo, con un rumore eguale. L'aiutante mi fece il saluto militare, e via. Io ero lí, rosso e confuso per la novità, e quelli mi spiavano, cambiandosi cenni birichini con l'occhio. Quando cominciai a parlare, essi mormoravano tutti insieme: "Chiosa chiosa". Io non capivo, e stavo lí tra la stizza e la vergogna, e piú ero stizzito io, piú loro erano impertinenti, e facevano rumore coi piedi, e sghignazzavano, e si berteggiavano, guardando me. Quell'ora fissata per la lezione mi parve una eternità. Quando venne l'aiutante, respirai e scesi frettoloso, a capo basso. Quella prima giornata non avea niente di trionfale; pochi badarono a me; l'aiutante mi si mostrò freddo. Aggiungi che l'aiutante mi disse: "Signor maestro", appena con un cenno di capo, mentre si levò il berretto gallonato con un profondo saluto e con un "Signor professore", quando entrava il mio successore. Questa differenza tra maestro e professore non era solo di stipendio, ma di grado e di dignità, ciò che mi pungeva.
La sera, caduto dalle nubi dorate delle mie illusioni, fui in casa di monsignor Sauchelli, maestro come me, e di lettere come me. "Monsignore, - diss'io, - i vostri alunni sono cosí birichini come i miei?" Egli indovinò, e fece una risata, guardandomi con una cera di benignità equivoca, che il sangue mi fuggí dal viso. "Tu hai poco mondo, - disse lui, prendendomi la mano; - non occorre che tu la prenda cosí sul tragico; ti spiegherò io la cosa". E mi narrò che il mio predecessore era un tal Carlo Rocchi, un povero prete piú che sessagenario, messo al ritiro, divenuto zimbello di quei ragazzi vivaci. "Cosí tu li trovi male avvezzi. Poi, ci sono i soffioni che cospirano contro il marchese Puoti, e fanno la sua caricatura presso quei giovanetti, e dicono che un giorno si lasciò dire che il vero maestro dee far le chiose al libro. Mi sono spiegato?" "Capisco perché gridavano: chiosa chiosa". "Poi, - disse lui, squadrandomi da capo a pié, - tu non hai cera imperatoria; il tuo contegno è troppo umile, troppo semplice; con quei monelli si vuole stare in guardia, essere bene apparecchiato, non andare alla buona". Seguí snocciolandomi consigli buoni quanto inutili. La natura mi aveva fabbricato cosí, e a farle contro era peggio.
Il dí appresso andai prevenuto e apparecchiato. Volevo fare l'aspetto imponente; ma in quella imponenza non c'era la calma, e c'era una stizza ridicola. Alzavo la voce, e quelli facevano coro. Talora il baccano era tale, che correva l'aiutante con in bocca un: "Cosa c'è?" Minacciava il piantone; ma quelli cosí piantati facevano tanti attucci col viso, che ridevano tutti, e io non sapevo perché, e m'irritavo piú. Quando io non capivo, facevo un tale atto di sorpresa, e in quella sorpresa c'era tanta bonomia e sincerità, che quelli ridevano piú forte: i bricconcelli leggevano sulla faccia tutti i miei pensieri. La miopia mia accresceva il disordine, perché vedevo il male spesso dove non era, e castigavo l'uno per l'altro, tra risa, grida e proteste. Allora per la prima volta mi armai il naso di due formidabili occhiali, che a ogni mio movimento brusco ballavano, e mi facevano parere tanto curioso: quel gran coso su quel volto scarno e pallido. Ma feci male il conto, perché ero uso a vivere dentro di me, ed ero cosí immerso nel mio pensiero, che non potevo distrarre gli occhi e volgerli in giro, e gli occhiali ci stavano per comparsa.
Però, passata la prima foga, m'accorsi che in certi momenti quei giovanotti mi prestavano attenzione, quando sentivano da me qualche fattarello, o qualche spiegazione chiara, o qualche lettura piacevole o commovente, e allora stavano cheti come olio, e talora i piú curiosi davano sulla voce ai piú impertinenti o distratti. Pensavo: "il torto non è tutto loro, ma è anche un po' il mio, che non so interessarli". E m'ingegnai, e posi tutto il mio insegnamento sulla lavagna per attirare l'attenzione e l'occhio di tutti. Quelle maledette regole grammaticali io le ridussi in poche, moltiplicando le applicazioni e gli esempi, e sempre lí sulla lavagna. Misi una certa emulazione, invitandoli alla mutua correzione. Mi persuasi che quello resta chiaro e saldo nella memoria, che è ordinato sotto categorie e schemi, logicamente. Cosí nacquero i miei quadri grammaticali, categorizzando, subordinando e coordinando tutto. Mi ricordai i metodi mnemonici di zio Carlo. Se non che, quelli venivano da combinazioni esterne, superficiali e convenzionali, e i miei venivano dall'intimo nesso delle idee. La mia mente abborriva dai fatti singoli e dai metodi empirici, e correva diritto alle leggi, ai rapporti, riducendo i particolari sotto specie e generi. I miei quadri erano appunto una sintesi, che si andava decomponendo in analisi, e uno degli esercizi piú cari ai giovani era, posta la sintesi, di lasciare ad essi l'analisi, che li svegliava, stimolava l'ingegno, accendeva la gara tra loro. Questi quadri avevano un altro lato buono, che non erano materia morta e noiosa nei libri, ma nascevano lí vivi sulla lavagna, formati da me e dai giovani, ciascuno per la sua parte, con una collaborazione paziente. Cosí non lasciavo un momento d'ozio al loro cervello, e li tenevo piacevolmente avvinti alla lavagna, esercitando a un tempo i sensi, l'immaginazione e l'intelletto, e facilitando in loro i due grandi istrumenti della scienza, l'analisi e la sintesi. L'aria della scuola era mutata; quei giovinetti si pavoneggiavano e facevano la scuola agli altri, insegnando loro tante cose nuove; io poi solleticavo il loro amor proprio, lodando, incoraggiando. In pochi mesi mi sbrigai della grammatica, e capii che lo studio della grammatica cosí come si suol fare, per regole, per eccezioni e per casi singoli, è una bestialità piena di fastidio, sí che metteva in furore i giovani, quando sentivano dire: "Ora veniamo alla grammatica". Vedevo pure che la lettura li annoiava terribilmente, e faceva lo stesso effetto sopra di me, mi annoiava terribilmente. In quello studio di parole e di frasi non c'era sugo. Vidi che loro andavano appresso alle cose e non alle parole; e scelsi allora dei brani, nei quali la materia fosse interessante, spiegando loro il senso e il nesso delle idee, e le gradazioni piú delicate del pensiero, incarnato nelle parole. Posi da banda le analisi grammaticali e l'analisi logica, noiosissime, e feci l'analisi delle cose, a loro gustosissima. Solevo scegliere i luoghi piú acconci a lusingare l'immaginazione, a movere il cuore, saltando spesso i cancelli dell'"aureo Trecento", e andando giú giú sino a Manzoni. Olimpia e Bireno, Cloridano e Medoro, Eurialo e Niso, la presa di Troia, il pianto di Andromaca, la morte di Ettore, Egisto e Clitennestra, Ifigenia, Lucrezia e Virginia, Olindo e Sofronia, i giardini di Alcina e di Armida, la pazzia di Orlando, la morte di Rodomonte o di Argante, il giardino del Poliziano, il Mattino del Parini, il Saul, la Lucia, la Cecilia, l'Ermengarda erano letture favorite, che li facevano uscir di sé, ed io, stupito io stesso da queste novità, mi dicevo: "Meno male che il marchese non ne sa nulla!" Io leggevo bene; la mia voce andava al cuore; quell'ora di lezione, già cosí lunga, passava con un: "È già finito?" E quei bravi ragazzi restavano scontenti, e domandavano in grazia una mezz'oretta di piú, e gli alunni delle altre classi si affollavano all'ingresso, e volevano sentire anche loro. Lasciai pure quei temi soliti di composizione simili a quei testi insulsi di lettura che si usavano nelle scuole, e che facevano "spens...
[Pagina successiva]