LA GIOVINEZZA, di Francesco De Sanctis - pagina 29
...
.
Cosí misi un po' d'ordine in casa, e potei con cuore tranquillo passar le vacanze sull'Arenella, in una villetta.
Venivano a visitarmi i miei giovani, e passavano con me la giornata, e tanto per non perder l'uso, facevo lezioni alla peripatetica, per il Vomero e per Antignano.
La sera mi recavo a una villa vicina, dove si faceva tavola da gioco.
Venivano parecchi amici da Napoli e si formava una compagnia scelta e allegra.
Là rividi il Pisanelli, mio antico compagno nella scuola del marchese, e già innanzi nella carriera forense.
Era un bel giovane, persona alta e svelta, volto pallido, pieno di distinzione, con occhi languidi, dolcissimo di favella e di modi.
Faceva crocchio intorno a sé e, come si direbbe oggi, posava.
Gli occhi delle signorine erano sopra di lui.
Vestiva con eleganza, profumato, con la chioma ben pettinata.
Io lo guardavo incantato.
Uso a stare cosí alla buona e alla naturale, semplice di parola e di modi, mi sentivo piccolo dirimpetto a lui; mi pareva una divinità, ma, come dissi poi ai giovani col mio linguaggio scolastico, un tipo di eleganza un po' manierata.
Si fece un po' di conversazione.
Tra quella gente lambiccata io ero una figura insignificante, stavo tra la folla, non facevo spicco e nessuno mi badava.
Poco fatto alla conversazione, sgraziato e confuso in tutti quegli usi convenzionali di una società elegante, stavo piú volentieri a guardare le vicende del gioco, senza capirci un ette.
Conoscevo un po' la scopa e lo scopone; ma non capii mai il mercante, che si giocava in casa dello zio, e tanto meno il mediatore e la calabresella, che non avevo visto mai.
Pure, a forza di guardare, ci capii un poco.
Una sera si giocava il mediatore, e mancava il quarto.
Pisanelli mi fece ressa, perché il quarto foss'io, e per cortesia presi posto.
Gioca e gioca, perdevo sempre, il piattino era tutto pieno.
"Che bella cosa una sola ora!"; disse Pisanelli, guardando il piattino.
"Sola!", gridai io, e Pisanelli gettò gli occhi sulle carte.
"Sola!, temerario", notò lui, con quella sua aria di maestro che m'imponeva.
Io non potei tirarmi indietro, ancorché tutti dicessero: "Riflettete!" Il mio amor proprio m'incapricciava.
Si fece un gran cerchio intorno a me.
Avevo molte carte simili; ma mi mancava il due, e, se questo non cadeva, l'era finita.
Io gitto il tre, e il cuore mi diceva: "Non cadrà il due".
Ma ecco, il due cade, e io gitto le carte col riso trionfale d'un imperatore che ha vinto la battaglia.
Ci fu un urlo, batterono le mani, e io mi misi in tasca non so quanti carlini, una cosa straordinaria.
E come sono piccoli gli uomini! Quella scena mi è rimasta impressa, e per piú tempo sono andato raccontando il caso bizzarro a questo e a quello, e anche oggi m'è venuto in mente.
Capitolo VENTESIMOSETTIMO
LA SCUOLA.
PROPOSTA DI MATRIMONIO IL MARCHESE E I GIORNALI
Anche quest'anno il marchese veniva tutti i mercoledí per la traduzione; talora anche il sabato, destinato all'esame dei componimenti.
Parecchi giovani erano molto innanzi per purità e castigatezza di scrivere, e la loro traduzione era scelta per lo piú come la migliore, sulla quale il marchese faceva poi la sua correzione.
Tra questi puri scrittori, che egli aveva in maggior conto, erano Vincenzo Siniscalchi, Francesco Corabi e Agostino Magliani.
Il marchese teneva ancora la sua scuola di perfezionamento, ma nella sola domenica.
Ci andavano alcuni giovani miei, come Bruto Fabbricatore, Matteo Vercillo, Alessandro Parlati, venuti a me fin dal primo anno, anche Siniscalchi, e credo pure De Meis.
Di questi, Fabbricatore lasciò la mia scuola, venne nella buona grazia del marchese, e gli rimase accanto, assistendolo in tutti i suoi lavori.
Era giovane laborioso, pratico della lingua, e per la natura della sua mente poco atto ad altro indirizzo.
Stava strettamente alle opinioni del marchese, ed era il suo piú fido interprete presso i giovani.
Anche don Francesco, che seppi essere il barone Corvo, assisteva alle mie lezioni, primo a venire, ultimo ad andar via.
Aveva preso molta dimestichezza coi giovani, e stava in mezzo a loro, come papà.
La sua modestia e il suo riserbo gli mantenevano riverenza, e non ricordo che alcuno abbia mai abusato di quella familiarità.
La disciplina si rallenta quando il movimento intellettuale stagna e l'attenzione non è tenuta viva da cose interessanti.
Ora, nella scuola non c'erano parentesi, non digressioni; anche parlando a uno, dicevo cose che tutti avevano interesse a sapere, e perché non solevo ripetermi mai, c'era del nuovo che tenea desta la curiosità.
Una, sera, cominciata già la lezione, entrava Ferdinando Vercillo.
Era un giovane elegante, guantato, ricercato nel vestire, e portava un cappello a punta allora in moda, e certi scarpini rumorosi.
Fu accolto dai giovani con un suono che voleva dir "zitto!", e che a me parve un sibilo.
Questo mi turbò assai.
Feci vive lagnanze, dicendo con voce commossa che l'era un fatto grave, senza esempio nella mia scuola.
Nessuno fiatò.
E io, eccitato dalle mie stesse parole, lasciai lí la lezione e non volli continuare, congedai tutti bruscamente.
Se ne andarono mogi, in silenzio.
Dopo mi fu spiegato il caso, e ripigliai le lezioni.
Questa era la disciplina della scuola.
E avvenne un altro scandalo, come io chiamavo queste cose.
Capitò un abate su' trent'anni, di cui non faccio il nome.
Uscito dalla scuola dei Gesuiti, egli veniva pettoruto, con l'aria di volerci inghiottire tutti.
E tutti gli fummo addosso, al primo suo lavoro.
Declamava certa orazione, in tre punti, col relativo esordio ed epilogo, con le solite amplificazioni, fermandosi dopo certi periodoni, che gli parevano magnifici e di molto effetto, tutto pavoneggiandosi; e piú prendeva il tuono solenne e piú ci metteva d'enfasi, e tanto piú erano romorose le risa.
L'abate, vedendosi sberteggiato, ricalcitrava, tutto rosso dalla stizza, e piú s'incolleriva lui, e piú si rallegravano gli altri.
Io feci il volto grave, e domandai ad uno dei piú allegri il suo giudizio.
Ma l'abate l'interrompeva con certe mosse di stupore: "Come! Ma lei non sa che questa è una regola rettorica! Questa è una ipotiposi.
Ma questo nel linguaggio di chi studia si chiama un'amplificazione".
E sghignazzava e si dondolava, facendo: ah! ah!, come per affogare le risate nel riso suo.
Lo spettacolo era nuovo e voleva una correzione.
Feci d'occhio a Francesco Corabi lí in prima fila, ch'era stato serio e prendeva delle note.
Costui era un ingegno secco di stretta logica e di analisi fine, acuto come un coltello e stringente come una tenaglia.
Ghermí il povero abate e ne fece un cencio.
Ben tentava qualche interruzione, ma lui non gli dava il tempo, e lo incalzava, e in breve il ritroso abate si vide tirato a tale altezza, che gli mancò l'aria e gli cascò il capo tra le mani.
Io usai parole dolci per consolarlo e fargli animo.
L'abate presuntuoso si fece piccino piccino, e come in fondo era un brav'omo, divenne un buon compagno e un buono scolaro, e se non fece miracoli, imparò almeno a scrivere naturalmente.
La scuola era venuta a quel punto che Proudhon chiamerebbe anarchia.
Era una piccola società abbandonata a se stessa, senza regolamenti, senza disciplina, senza autorità di comando, mossa dal sentimento del dovere, da stima e da rispetto reciproco, da quello ch'io chiamavo sentimento di dignità personale.
Ci eravamo educati insieme.
Io avevo per quei giovani un culto, sentivo con desiderio le loro osservazioni e i loro pareri, studiavo le loro impressioni.
Godevo tanto a vedermeli intorno con quei gesti vivaci, con quelle facce soddisfatte! Essi guardavano in me il loro amico e il loro coetaneo, e mi amavano perché sentivano di essere amati.
Io avevo il loro entusiasmo giovanile, i loro ideali, e, se in loro c'era una parte del mio cervello, da loro veniva a me una fresc'aura di vita e d'ispirazione.
Senza di loro mi sentivo nel buio, essi erano lo sprone che mi teneva vivo l'intelletto e lo riempiva di luce.
Scrissi nell'album di una signora: "Desiderando di piacere a qualcuno, tu piaci a te stesso e ti senti felice".
Patria, libertà, umanità, tutti i piú alti ideali che mi brillavano innanzi, si compendiavano in quest'uno: piacere alla scuola; e lí erano la mia espansione, la mia felicità.
Quante volte anche oggi rimemoro quei giorni, e dico: "Com'ero felice allora!" C'è nei giovani un sicuro istinto che li avvisa di tutto ciò ch'è nobile e sincero; ed è vero che i migliori giudici del maestro sono i discepoli, sono come il popolo, voce di Dio, giudice inappellabile di quelli che lo governano.
Il loro affetto era cosí delicato che, quando avveniva qualche sconcio, dicevano: "Non lo facciamo sapere al professore".
Pure c'era un'ombra.
Non mi credevano capace di favori, di protezioni indebite; ma cosa volete? quegli Eletti lí, per grazia mia, turbavano alcuni; un po' di gelosia, un po' di vanità e debolezza umana: quella distinzione per ordine, quel carattere ufficiale, come dicevano, non andava a garbo.
La gerarchia dell'ingegno c'era, non la potevano disconoscere; ma tant'è, volevano riconoscerla loro, non ammettevano una gerarchia a priori, quasi per diritto divino, come diceva Luigi La Vista.
Il quale un giorno saltò a dirmi: "Professore, sbarazzateci; questo nome di Eletti non ci va; vogliamo tutti lo stesso nome!" Cosí, dopo appena un anno, venne a noia una istituzione tanto nel suo principio magnificata.
Io con buona grazia feci cader l'uso, e non si parlò piú di Eletti.
"Ed eccoci in piena democrazia, tutti uguali", diceva Lavista, ch'era l'idolo della scuola.
Io dimagravo a vista d'occhio; talora mi vagava il cervello, cercando con gli occhi qua e là, senza uno scopo chiaro e consapevole.
Quello star solo e concentrato nella scuola, lontano da ogni umana compagnia, aveva la sua parte in quegli accessi di umor nero, di mala contentezza.
Gli amici mi vollero ammogliare.
Usavo da un pezzo in casa dell'avvocato Tommaso J., uno stecco d'uomo, che passava tutto il giorno in tribunale a far liti, il piú spesso per conto proprio.
Passava per uomo ricco, ma viveva con modestia e quasi con trascuratezza.
Abitava in una casa che si credeva sua: poche stanze antiche, sdrucite dal tempo e dall'incuria.
Noi altri non ci si guardava per il sottile; io distinguevo poco una stanza dall'altra, come poco una vivanda dall'altra: avevo altro pel capo.
Figlia di don Tommaso era Caterina, cresciuta cosí alla grossa e alla buona, un po' saputella, con un cervellino sottile e acuto, sullo stampo paterno.
Fatta grandina, dicevano che era tutta suo padre, perciò un po' bruttina.
Stavo lí come un amico di famiglia, e sentivo le grandi lodi di mamma per la figlia, e cercavo di scappar via quando sopravveniva il babbo, che m'empiva la testa di chiacchiere, parlandomi delle sue possessioni e delle liti, e non mi lasciava piú, capacissimo di prendermi sotto il braccio, e volermi per forza accompagnare sino a casa, per farmi la storia d'un processo e recitarmi la sua orazione.
Io sentivo di ciò una fiera noia, ma sapeva contenermi, e lui, immerso nelle sue cause, non se ne accorgeva.
Venne terzo fra noi don Raffaele, che m'investiva sempre col suo: "Allegramente!" Poi s'aggiunse il babbo, che veniva a Napoli di frequente, e conosceva don Tommaso, e s'intrometteva tra' discorsi, e, faceto, impaziente, gli rompeva la parola.
Cosí trovai un diversivo, e talora mi scaricava di don Tommaso, e lo regalavo a loro.
Avevo preso dimestichezza con la Caterina, senza intenzione, e talora si disputava di storia greca e romana, dove lei era una dottora.
La mamma rompeva le dispute con un motto d'elogio alla figlia, istruita con molta cura e con grande affetto, e pur facendo intendere che a lei, figlia unica, sarebbe spettato un ricco patrimonio.
Quando io venivo in malinconia, gli amici dicevano scherzando: "C'è il mal di cuore, il mal della Caterina".
Cosí, parlando del mio amore, finii col crederci anch'io, e mi trovai innamorato senza saperlo.
Don Tommaso stese sopra un gran foglio di carta avvocatessa una lista delle sue possessioni, che non finiva mai.
Ne aveva in Atripalda, ne aveva in Montesarchio, ne aveva, anche in Napoli.
Parlava come Carlo quinto.
Sovente tirava il discorso sopra i suoi feudi.
E una sera mi messe sotto il naso quella sua carta, credendo di abbarbagliarmi.
Mi accompagnò, secondo il solito, e tirandomi sotto il braccio, mi narrò non so qual causa strepitosa, e sull'uscio di casa mi consegnò quella famosa carta.
Vi gittai l'occhio sopra.
Era un carattere impossibile; ma, uso a deciferare tutti i geroglifici dei miei scolari, non mi atterrii.
Quel numeri, uno, due, tre, e via via fino a cinquanta o sessanta, mi davano il capogiro: era la lista dei suoi possedimenti.
A un certo punto mi seccai, e non andai oltre.
Non sono stato mai atto a leggere tutto un istrumento o un regolamento.
Leggo con piacere dov'è una serie d'idee che si muovono.
La mia natura abborre dai dettagli, salvo che non mi ci ficchi io, e non ci metta il mio cervello; allora mi ci delizio e divento minuto, anche troppo.
Quella infilata di titoli, di censi, di rendite, di fitti non mi entrava, non ci capivo nulla.
Pure, una cosa m'era rimasta, che don Tommaso avea molti feudi, e ch'io sarei divenuto un gran proprietario.
Non so quale influsso magico ha sullo spirito questa parola "proprietario".
In provincia un contadino si farebbe tagliare il naso anzi che cedere un pezzo di terra: "il danaro se ne va, la terra resta".
E quando hanno danari, li seppelliscono sotto terra, come per impedire la loro fuga.
Sono ancora in un'età primitiva: le banche, le cambiali, il credito sono diavolerie ch'essi scongiurano con un segno di croce.
Io era rimasto un po' contadino per questo rispetto: i miei danari volavano, non sapevo come, e ci avevo fatto il callo, sicuro che venivano gli altri.
Il mio sogno era: una casa mia, con un bel giardino; e, quando giravo per le alture di Napoli, e qualche villetta mi fermava, cadevo in fantasia e dicevo: "Oh fosse mia! Stare qui tra questi fiori, studiare sotto quelle ombre! Diventerei poeta".
Figurarsi qual fascino aveva quella carta sulla mia immaginazione! E corsi al marchese Puoti, e gliela porsi.
Quell'eccellente uomo, che mi teneva come suo figliuolo, disse: "Adagio! Fosse una canzone, ce ne intenderemmo tu ed io; ma è roba d'avvocati, e potrebb'essere una canzonatura, e saremmo canzonati tu ed io".
Si tenne la carta e chiese consiglio a suo fratello Giammaria, che teneva uno dei piú alti posti in magistratura, uomo proverbiale per rettitudine e puntualità nel suo uffizio, e, come noi si diceva allora, uomo all'antica, di cui si va perdendo lo stampo.
Dopo alcuni giorni mi chiamò a sé, e disse: "Sentite, don Francesco, non so se vi farà piacere o vi spiacerà, ma la verità è una, e come uomo di coscienza ve la debbo dire.
Tutte queste possessioni sono come i castelli di Spagna, che talora ci vengono in sogno.
Qualcosa c'è in questa carta, ma niente è liquido, niente corre liscio; qui c'è un semenzaio di liti perpetue, che non ne vedranno la fine i figli dei figli, come dice il vostro Tasso.
Don Tommaso ci gavazza dentro e ci s'imbrodola, perché nato fra le liti, e ci ha un gusto matto.
Ma voi, caro don Francesco, col vostro Tasso e col vostro Dante, cosa vorrete farne di tutta questa roba litigiosa? Finirete che gli avvocati si mangeranno tutto e vorranno il resto.
Dunque lasciate stare, non è cosa per voi".
Io rimasi come chi si sveglia da un bel sogno e si trova a bocca asciutta.
Lui vedendomi cosí sospeso, disse, restituendomi la carta: "Se poi amate quella creatura, l'è un altro affare; ma non c'entro piú io.
Però, se il vostro cuore dice di si, meglio pigliarla sola, che in compagnia di tutte queste liti".
Mi strinse la mano con un sorriso pieno di bonomia, e mi congedò.
Me ne andai solo e correndo, com'era mio uso, con la testa in tumulto.
Don Tommaso e la Caterina m'incalzavano nel cervello, e dall'altro lato c'era la lezione che cercava pure il suo posto.
Feci un grande sforzo, ché dovevo parlare del poema epico, e già mi frullavano alcune idee fin dal mattino.
Tentai ripigliare le fila, ma il matrimonio, le possessioni, don Tommaso me le guastavano, e per quel dí caddi in preda ai fantasmi, e non conclusi nulla di nulla.
La sera fui dalla Caterina per abito preso, e non fiatai della cosa; ma sulla faccia si leggeva il maledetto imbroglio ch'era nel mio spirito.
Capitò all'ultim'ora don Tommaso, e al solito volle accompagnarmi.
L'acuto sguardo della mamma notò la freddezza del mio addio alla Caterina, e disse: "Qualcosa qui c'è sotto; non me la dai a intendere".
"Niente, niente", diss'io, piú confuso e piú rosso a quelle parole.
Don Tommaso, assorto nelle sue liti, non s'era addato di nulla, e cominciava la sua solita litania; ma io mi sciolsi dal suo braccio, e dissi: "Don Tommaso, questa è la vostra carta".
Aveva le braccia lunghe, giocava spesso co' gomiti, e mi dié una gomitata, dicendo: "Eh! eh! cosa ti pare?" "Mi pare, - diss'io, facendo animo, - che dentro a questa carta c'è un semenzaio di liti".
"Semenzaio! - disse lui che non capiva la parola, - cosa vuoi dire?" "Voglio dire che delle vostre liti vedranno il termine i figli dei figli".
"Andate a fare con un maestro di scuola! - disse lui con dispetto.
- La lite è cosa ottima, perché guadagnando hai il cento per cento".
E qui s'incaloriva, e contava le sue cause vinte, e si prometteva grandi guadagni e vicina conclusione.
Io non risposi piú.
Andai ancora un pezzo in quella casa; non volevo si dicesse che per quistione di quattrini la lasciava; ma, non sapendo dissimulare, guardavo brusco e storto don Tommaso che m'era parso un paglietta imbroglione, come dicono a Napoli.
Lui ne fece qualche motto in famiglia; la mamma si inalberò e usci in parole grosse; nacque un pettegolezzo, e tutto finí.
Io volevo bene alla Caterina, ma non era di quell'amore che ti trascina; e poi in quell'età avevo innanzi tanti belli ideali, e gli occhi erano vaganti e distratti.
Il matrimonio era per me una velleità, un verme messomi nel cervello dagli amici; l'anima restava al di fuori, e, per dirla con frase moderna, non era giunto ancora per me il momento psicologico del matrimonio.
Ripensandoci ora, veggo che fui ingiusto col povero don Tommaso, ch'era in perfetta buona fede, tagliato cosí da natura, che viveva sazio e rubicondo tra le liti, e faceva illusione a sé e agli altri.
Intanto la scuola sentiva già gli effetti della nuova atmosfera letteraria che vi era penetrata.
Quantunque nelle mie letture entrassero sempre trecentisti e cinquecentisti, e scegliessi con accuratezza quei luoghi che piú mi parevano dover dare nel genio e fare effetto; pure quei secoli non solleticavano piú, e la gioventú si gittava con ardore sulla moderna letteratura.
Cercavamo ancora qualche vecchio autore, ma di quelli poco soliti a leggersi, e che davano occasione a ricerche interessanti.
Cosí ci fu uno studio sopra gli scrittori politici, e un altro su' nostri comici e novellieri.
Io davo questi temi letterari, perché occasione a letture e ricerche profittevoli.
Avendo terminato il mio corso sulla lirica con un'appendice intorno alla satira italiana, seguí uno studio animato dei nostri satirici, specie dell'Ariosto, andando su fino ai Sermoni del Gozzi e alle Satire dell'Alfieri: il suo Misogallo fu divorato, molti brani si sapevano a mente.
Io poi cercavo sempre qualche lettura nuova, che fosse un solletico alla curiosità.
Una sera lessi la lettera che sta innanzi ai Discorsi del Machiavelli, la quale aveva pieno me d'ammirazione, e destò in loro entusiasmo.
Pareva come un bel gioiello scavato di sotterra, e di cui nessuno aveva inteso a parlare.
Cominciò la moda del Machiavelli: si disputava intorno ai Discorsi, intorno al Principe.
Queste letture, coordinate con letture mie e con mie lezioni, avevano i loro effetti nei lavori.
Io abborriva dai metodi meccanici e dai sistemi; quelle regole fisse sul prima e sul poi non mi andavano; lasciavo molto alla spontaneità dei giovani, e nelle mie letture di scuola facevo di gran salti.
Volevo svegliare in essi l'iniziativa, la fede nel loro criterio.
Gli autori erano tutti di buona lega, ed il marchese, ancorché non ci fosse l'ordine da lui prefisso, lasciava correre.
Non ammetteva l'Ossian di Cesarotti, e non le Notti romane e non il Jacopo Ortis, e non il Bettinelli o il Baretti o l'Algarotti: erano autori scomunicati e infrancesati, che pur si leggevano, ma in gran segreto, come si fa dei libri proibiti.
Non è che non trovasse a ridire sopra altri autori meno sospetti, in ciascuno dei quali notava qualche taccherella; ma, infine, leggere Alfieri o Foscolo o Manzoni non era poi un affare di stato.
Meglio accetti erano Parini e Gozzi.
Un giorno giunse la sua tolleranza sino a far leggere il Manzoni.
E fin qui andava bene.
Ma, visto che la gioventú correva dietro alle novelle del Grossi e del Sestini, dove sentiva un odore di romanticismo, si strinse nella sua toga come Cesare, e divenne intollerante nel suo classicismo.
Allora, vietata la politica, comparivano i giornali letterari.
Oltre l'antico "Omnibus", erano sorti il "Poliorama" e l'"Omnibus pittoresco", e venivano in voga le "Strenne".
Uno sfogo ci voleva, e lo sfogo furono villanie e polemiche, che si gittavano al viso, segno di ozio billoso.
Piovvero racconti, novelle, romanzi tra il fantastico e il sentimentale, sciarade, logogrifi, volgarità e puerilità in prosa e in verso.
Si voleva il nuovo, e il nuovo era il genere romantico, e si diceva: racconto romantico, novella romantica.
Non era una nuova coltura che sorgesse spontanea, era un'eco confusa e inintelligente di un moto letterario sorto molti anni indietro, di cui ci veniva il rumore dalla Lombardia.
Il marchese sfogava la sua bile contro quei fogli, e non consentiva lettura di giornali a' suoi giovani.
Cosa era romanticismo non si sapeva cosí per l'appunto, e i letterati piazzaiuoli strillavano che bisogna scrivere come natura detta, mettere da parte le regole; e mi ricordo questa frase comune: "Le regole tarpano le ali al genio".
Questo intendevano per romanticismo.
Il Medio evo saliva in moda, la leggenda era un genere favorito, classico significava pedante.
E cosí si aveva un romanticismo a buon mercato.
Il marchese rendeva pan per focaccia, e covriva de' piú curiosi epiteti questi letteratucoli.
Tuffato ne' miei giornali politici francesi, poco leggevo quei fogli, e me ne venne subito il disgusto.
Quel non approfondire niente, quel saltellare di palo in frasca, con quei punti ammirativi e con quei puntini, ne' quali non c'erano altri sottintesi che la vacuità del cervello, quelle situazioni tese e violente: tutto mi pareva falso e strano.
Il marchese vietava la lettura dei giornali; io non facevo divieti, ma non dissimulavo il mio disgusto.
Quella predica contro le regole, quel mettere da banda gli studi, e confidare nella onnipotenza del genio, era un sistema comodo, che incendiava molte teste di paglia di studenti, accensibili come un zolfino.
La scuola tenne fermo; pure c'era non so quale inquietudine, un desiderio di cose nuove.
Si gittarono sulla letteratura francese: sentivo disputare di madame de Staël, di Chateaubriand, di Victor Hugo, di Lamartine.
Io mi mescolavo nella conversazione, e mi davo a quelle letture con pari avidità, scolaro tra gli scolari.
Non posso riafferrare piú le mie impressioni.
Rammento solo di lord Byron, che mi atterrí.
Tutto mi pareva gigantesco: situazione, azione, caratteri, affetti.
Quella profondità d'odio e d'amore, quella forza portata all'ultima sua espressione, quella eloquenza terribile di passioni indomite, smisurate, mi parve come la scoperta di un mondo nuovo, abitato da una razza superiore di umani.
Un sabato che ci capitò il marchese, Agostino Magliani lesse una novella.
Descrizioni, favole, racconti, epistole, dialoghi, discorsi erano i soliti generi di composizione; ma la novella era il genere favorito.
Intorno al modo di condurre la novella c'era un codice prestabilito, divenuto convenzionale.
C'erano le regole intorno alla preparazione, alla favola, allo snodamento, alla catastrofe, ai caratteri, agli affetti: regole che risalivano fino ai primi tempi della scuola del Puoti.
Per lo piú le novelle erano fatte sullo stampo boccaccevole; il marchese richiedeva semplicità nell'intrigo, e naturalezza negli affetti.
Il sugo era che, sotto il liscio di periodi misurati e rotondi, c'era superficialità d'immagini e di sentimenti.
E questo è bene, come esercizio di scrivere per giovani poco provetti, ai quali manca esperienza della vita e del cuore umano, per guardare piú addentro.
Ma nella mia scuola era sorto il ticchio di mostrare originalità nell'invenzione, e venivan fuori certe situazioni esagerate.
Il Magliani aveva scritto la sua novella con uno stile castigato e in lingua assai forbita, di che il marchese gli dié lode.
La situazione era un po' tesa; ma l'ingegno casto e misurato dello scrittore avea saputo togliere gli angoli, rintuzzare le punte, rammorbidirla e regolarla con peso e misura.
"Pare una situazione romantica in forma classica", scappò uno a dire.
Il marchese si fece verde.
"Ma questa è roba di lord Byron", rifletté un altro.
Il marchese non ci vide piú.
"Lord Byron? E voi leggete lord Byron? E voi, signor Magliani, copiate lord Byron?" Magliani si fece un pizzico, e rimase muto; io non dissi nulla, come di solito, non volendo col contrasto provocare la tempesta.
Ma la tempesta venne e scoppiò sul capo di tutti.
Se la prese con me, con la scuola, coi giornali, coi romantici e con lord Byron.
Poi venne la bonaccia, e, com'era di bonissime viscere, ci disse parole dolci e paterne.
Lo accompagnammo a casa, che s'era già rabbonito, e frizzava i giornalisti, e faceva il lepido ch'era una grazia.
Quella collera era la sua musa, che gli dilatava i polmoni e gli moveva l'immaginazione.
Avremmo riso, ma ci teneva la vista di quei lineamenti contratti, temevamo di recargli offesa.
Gli venivano osservazioni piccanti.
Diceva che i giornali imbarbarivano la lingua, sviavano da' forti studi corrompevano il gusto e il cuore.
Non concepiva come il governo lasciasse correre tanti vituperi su di una certa stampa, ch'egli chiamava un letamaio.
Il romanticismo era l'ultima rovina degli studi.
Egli aveva combattuto quella peste di oltralpe, ch'è il gallicismo, "ma il romanticismo è peggio, perché se quello vizia la lingua, questo rode come un tarlo la mente".
Chiamava bolle di sapone, fuochi fatui quello che oggi si direbbe eccentricità e fosforescenza.
Ripeteva in caricatura la famosa frase, che "non bisogna tarpar le ali al genio".
"E quanti geni, gridava, ci sono oggi piovuti di cielo! Scribacchiatori pullulati come vermi dalle cloache, degna loro stanza".
Ciò che piú gli spiaceva ne' romantici, era la dismisura negli affetti, ne' caratteri, nell'intrigo, nella favola.
Perciò ne voleva al Verri ed al Guerrazzi, e lodava la semplicità del Manzoni, che da persone di umile condizione, com'erano Renzo e Lucia, aveva saputo cavare potenti effetti.
Nella semplicità voleva il rilievo, e perciò motteggiava la Monaca di Monza del Rosini e le Guerre civili del Davila: "Quel loro scrivere mi pare una piscia, con riverenza parlando".
Lodava molto il Ranieri, ma notava non so che concetti nella sua prefazione al Leopardi, e non so che situazione violenta nell'Orfana della Nunziata, che avea fatta una grande impressione, non solo come un'opera letteraria, ma ancora come un'azione coraggiosa.
Comparivano certe leggende e novelle in pura lingua e in terso stile, ma non avevano grazia presso lui, per la natura dell'argomento; e diceva della Isolina di Roberto Savarese ch'era scritta assai bene, ma che c'era non so che puzzo di romanticismo, qualcosa della Ildegonda e simili piagnistei.
Pure il marchese poteva andar contento dell'opera sua.
Attorno a lui stavano riverenti i piú colti e stimati uomini della città: il marchese di Montrone, i fratelli Baldacchini, il Cappelli, il Campagna, l'Imbriani, il Poerio, la Guacci, il De Vincenzi, i Savarese, il Gasparrini, lo Scacchi, il Cassola ed altri, che non mi vengono sotto la penna.
Molti letterati di altre parti d'Italia gli facevano plauso.
La sua scuola aveva già messo buone radici fino nei seminari piú ritrosi.
Mi ricordo il seminario di Cava, dove il marchese era spesso invitato e festeggiato.
I suoi libri di testo erano sparsi nelle piú lontane scuole.
Ultimamente avea posto mano ad un dizionario domestico, che venne subito in favore presso gli studiosi.
Fiorivano molte scuole a sua immagine, come quella di Rodinò, e l'altra di Fabbricatore, ch'era la sua prediletta.
E già venivano in fama parecchi giovani valorosi, entrati in molta dimestichezza con lui, come Luigi Settembrini, Vito Fornari, Antonio Mirabelli.
Tutti onoravano in lui l'educatore della gioventú.
Mi ricordo il grande scalpore che fece, quando gli venne a mano un opuscolo di Luca suo fratello, in confutazione de Le ultime parole di un credente, un libro di molto strepito e letto avidamente: chiamava l'opera del fratello un basso atto di cortigianeria, verso il governo.
Da lui non venne mai niente di basso e di servile; poteva dunque esser contento.
Ma in quella nuova aria si sentiva affogare, e vi si dibatteva del suo meglio.
Se la prendeva con certuni come Cesare Malpica e Domenico Anzelmi, e con parecchi altri che beffeggiavano lui e la scuola; e queste erano miserie non degne della sua collera.
Capitolo ventesimottavo
IL GENERE NARRATIVO
Questa storia di bassi fondi non giungeva sino a noi.
Quello che c'era di novità non ci attirava, perché già da lungo tempo ci eravamo messi in una nuova atmosfera letteraria, con serietà d'intenti e di studi, e ci parevano ridicoli i pretesi novatori, non vedendo in loro che ignoranza e superficialità.
L'inverecondia delle polemiche ci moveva disprezzo e disgusto.
La persona di Basilio Puoti c'era divenuta piú veneranda, appunto per le basse contumelie di cui era fatto segno.
La conclusione fu che ci demmo con piú ardore agli studi, cercando con avidità tutti i libri nuovi intorno ai problemi letterari, di cui allora si parlava molto piú con presunzione che con competenza.
Questi libri circolavano nella scuola; se li prestavano, ne disputavano; io i miei li prestavo volentieri, e ne parlavo sempre, e non tacevo mai le fonti ove attingevo.
Quest'anno il mio corso fu intorno al genere narrativo, sotto il quale compresi il poema epico e la leggenda, il romanzo e la novella, la storia e la biografia, il romanzo storico.
Continuavo lo stesso metodo.
Prima era l'esame del contenuto in sé e nelle sue condizioni di tempo e di luogo, da cui si derivavano le forme, cioè a dire la situazione e l'ordine, i caratteri, lo stile, ecc.
Per dare un concetto adeguato del poema epico nelle sue vicissitudini, feci una specie di quadro storico dell'umanità, andando dalla famiglia al comune, dal comune alla nazione, dalla nazione ai grandi centri di civiltà.
Cosí classificai Omero, Virgilio, Dante, Ariosto, Tasso, Milton, Klopstock.
Toccai del Camoens come tipo di poeta nazionale.
Precedettero alcune considerazioni generali:
1.
Derivando le forme dal contenuto, nessun poema può essere tipo e modello di tutti gli altri, perché ciascuno ha un contenuto suo, e perciò forme sue.
2.
In poesia non ci sono tipi, ma individui, e nessun individuo somiglia a un altro.
I tipi sono astrazioni della critica.
Il tipo è una data qualità accentuata, com'è anche nella vita reale.
Il poeta non deve avere innanzi tipi, ma individui.
Il carattere tipico è insito nella persona poetica, senza consapevolezza del poeta.
Dire che Achille è il tipo della forza e del coraggio, e che Tersite è il tipo della debolezza e della vigliaccheria, è inesatto, potendo queste qualità avere infinite espressioni negl'individui.
Achille è Achille, e Tersite è Tersite, e appunto per questo sono compiute persone poetiche, le quali possono giovare ai poeti, non come esemplari da copiare, ma come ispirazione a invenzioni simili, a quel modo che la natura ispira i poeti, e i modelli sono utili ai pittori.
3.
Parimente l'umano, l'homo sum, fondamento assoluto e perciò immutabile di tutta la vita umana, reale e artistica, non esiste in natura e non esiste in arte.
Gli elementi etici e patetici che fanno di sé bella mostra nelle rettoriche, non sono che astrazioni; tolti dal vivo dov'erano incorporati, non sono che pezzi di anatomia, frammenti cadaverici.
L'uomo, come il tipo, è insito in ciascuna persona poetica, e senza coscienza dell'artista.
4.
Le regole sono anch'esse lavoro posteriore all'arte, e perciò sono anch'esse astrazioni.
Le regole piú importanti non sono le generalità, che si accomodano ad ogni contenuto, ma sono quelle che traggono il loro succo ex visceribus causae, dalle viscere del contenuto.
5.
Perciò il vero in arte non è assoluto come nella scienza, ma è relativo al contenuto, nelle condizioni in cui lo concepisce il poeta.
Le rappresentazioni poetiche sono vere, anche quando il contenuto è riconosciuto falso.
Gli Dei non esistono piú innanzi alla nostra coscienza, ma restano immortali in Omero.
6.
Il poema epico suppone una storia tradizionale, contemperata con l'atmosfera sociale in cui vive il poeta, e con le qualità del suo ingegno.
Suppone anche tutto un ciclo di poesie anteriori, una lunga e lenta elaborazione della materia, alla quale esso dà l'ultima forma.
Queste considerazioni, ch'io trovo nei sunti lasciatimi dai miei discepoli, sembrano oggi luoghi comuni.
E questo è il progresso.
Ciò che un giorno è una tesi lungamente dibattuta e studiata, fra venti anni diventa un luogo comune, che sarebbe pedanteria dimostrare e illustrare.
A quei tempi queste cose parevano bestemmie a molti; e io mi trovavo tra due fuochi, tra i classici e i romantici, o quelli almeno che si decoravano con questo nome senza alcuna serietà di studi.
La impostura è cosa vecchia.
Anche allora si empivano la bocca di autori neppur leggicchiati, e si apriva facile mercato di scienza raccolta negl'indici e ne' dizionari.
A quel tempo correvano certe opinioni tenute dogmi, nelle quali io stesso ero cresciuto.
Lascio le piú dozzinali e pedantesche, che si connettono ai primi anni de' miei studi scolastici.
Pochi anni piú tardi ero pieno di molte opinioni apprese nella scuola del Puoti, e ancora piú nelle rettoriche e poetiche dal Cinquecento in poi.
Il discorso del Tasso sul poema epico era per me un oracolo; mi piaceva anche la Perfetta poesia del Muratori, leggevo le opere del Castelvetro, e mi stillavo il cervello in quelle sottigliezze.
Pure ressi alla fatica, e v'imparai molti fatti peregrini, grammaticali e poetici.
La Ragion Poetica del Gravina mi parve un avvenimento, per novità e finezza di osservazioni e per chiarezza di esposizione, che mi dava quasi una illusione di posatezza e coerenza scientifica.
Il marchese lo ammirava molto, e finalmente trasfuse in me la sua ammirazione.
Poi mi vennero a mano le polemiche sull'unità di tempo e di luogo, e lessi con avidità i giudizi di Pietro Metastasio, il cui fare libero e spregiudicato mi piaceva: ma studiavo di occultare questa mia impressione al marchese, al quale Metastasio era antipatico.
Anche celatamente divorai le opere del Bettinelli, dell'Algarotti, del Baretti, del Cesarotti, scrittori barbari al dir del marchese, ma ne' quali sentivo piú piacere che in que' faticosi cinquecentisti.
Al contrario non mi fu possibile leggere sino alla fine il Napione e il Perticari, cosí cari al marchese.
Tirai fino a Vincenzo Monti, le cui polemiche con la Crusca mi riuscirono gustose.
Queste letture avevano prodotto un guazzabuglio nella mia mente.
Molte opinioni e pregiudizi furono scossi, ma non cancellati.
Cominciò in me l'età benefica del dubbio e dell'esame.
Il progresso naturale del mio spirito, e piú che altro la mia abitudine alla meditazione, il non fissarmi in alcuno scrittore, e il pensare da me, mutarono in gran parte le mie impressioni e i miei giudizi.
Sentivo nelle sottigliezze del Castelvetro il lambiccato e il falso, e nella gravità del Gravina il presuntuoso e il pedantesco.
Nelle opere spigliate o scorrette del Metastasio, del Bettinelli, del Monti sentivo leggerezza e superficialità, con un odore talvolta di ciarlataneria.
Quando cominciò la mia scuola, mi capitarono le critiche del Galilei sulla Gerusalemme Liberata.
Alcune mi parvero stiracchiate; ma in altre trovai garbo e buon senso piú che in nessun altro nostro scrittore, e capii l'eccellenza dell'Ariosto sopra i suoi precursori e imitatori, e sopra il Tasso.
Fino a quel tempo leggevo l'Ariosto come un poeta piacevole nella sua stranezza, e non ci avevo mai pensato sopra, e talora mi domandavo, maravigliato, in che fosse superiore all'Amadigi o all'Orlando innammorato, ch'io leggevo con ugual piacere, e perché molti lo ponessero innanzi al Tasso, delizia dei miei primi anni e modello di perfezione agli occhi miei.
Basti dire che sapevo a memoria dal primo all'ultimo verso la Gerusalemme, e dell'Orlando furioso appena alcuni brani mi rimanevano impressi.
Debbo al Galilei un concetto piú sano e piú preciso dello scrivere poetico.
Questo era lo stato del mio spirito, quando diedi principio alle mie lezioni.
Intorno a me si aggirava il rumore delle vecchie opinioni.
L'unità d'azione, di tempo e di luogo era un assioma; l'Iliade era il modello immutabile di tutti i poemi possibili.
C'erano regole fisse, dalle quali non era lecito scostarsi.
Sotto nome di princípi correvano generalità applicabili a tutt'i casi, come certe ricette.
La Divina Commedia non era un poema, l'Orlando furioso neppure: poesie divine sí, ma contro alle regole; e non sapevano raccapezzarsi sotto qual genere andassero allogate.
C'era la gran lite degli episodi, e si pretendeva che la Divina Commedia fosse una serie di episodi, e non si leggevano che alcuni di essi, stimati piú belli.
Dante era poco meno che un barbaro.
Poco si leggevano gli stranieri; Shakespeare passava addirittura per barbaro, e Lope de Vega per un ciarlone.
Rousseau e Voltaire erano nomi scomunicati.
Ignoti quasi una gran parte degli scrittori dal secolo decimottavo in poi.
Poco si leggeva, meno si studiava, molte erano le chiacchiere.
La nostra ignoranza degli scrittori stranieri dava proporzioni eccessive al merito degl'italiani.
Alfieri era superiore a tutti i tragici, e Goldoni a tutti i comici, e la Basvilliana veniva comparata alla Divina Commedia: non si distingueva il mediocre dall'eccellente.
Queste tendenze erano pure nei miei scolari, e si può comprendere il perché di quella mia introduzione, che oltrepassava nei suoi intenti il poema epico, e abbracciava tutta l'arte.
A tale generalità di regole e di modelli io sostituivo la particolarità di un contenuto determinato dalle condizioni esterne e dalle facoltà del poeta.
Ciascun contenuto ha la sua situazione, la sua forma organica, e in quell'organismo bisogna cercar la sua regola.
Il contenuto è come un individuo, il quale, appunto perché individuo, è dissimile da ogni altro, e ha nel suo organismo il segreto de' suoi pensieri e delle sue azioni.
Facevo notare del pari la grande analogia tra le formazioni poetiche e le formazioni naturali.
Come la materia, determinata dalle sue forze o leggi, e dalle condizioni esterne, raggiunge una forma vitale; cosí il contenuto poetico, la materia cioè o l'argomento, determinato dalle forze del poeta e dalle condizioni esterne in cui egli vive, si specializza, prende una data situazione, acquista la sua forma, diviene un organismo.
La poesia, come la natura, è un lavoro di concentrazione e di diffusione insieme, e lo paragonavo a un circolo, dove la concentrazione nel centro produce la diffusione ne' raggi, e anche al sole, luce concentrata che si diffonde nei pianeti.
Io metteva molto calore in queste lezioni, con un moto di braccia, con una energia d'accento, come se avessi un avversario dinanzi a me.
La gioventú mi seguiva con attenzione religiosa, come s'io fossi un predicatore di culti nuovi.
Certo, in quella estetica improvvisata, ch'io andava predicando da tre anni, c'era un tantino di esagerazione.
Invaghito della individualità di ciascun contenuto, davo poca importanza alle specie e a' generi, al comune e all'universale, alle relazioni, alle somiglianza, a' contrasti.
Ma la conseguenza fu buona.
I giovani si avvezzarono a far getto delle vuote generalità, a metter da parte regole e modelli, a studiare gli scrittori, inviscerandosi in essi.
C'era meno presunzione e piú studio.
Quelle generalità non erano solo nella scuola antica o classica.
Peggio facevano certi novatori, i quali cercavano il segreto dell'arte nei concetti e ne' tipi.
Si fondavano sul Vico, che cercava nell'arte le idee e i tipi, e giudicavano il valore delle opere poetiche secondo la verità e la grandezza delle loro idee e l'eccellenza de' loro tipi, trascurando in tutto la forma e l'espressione.
Perché s'era abusato delle forme, essi le cancellavano, e riducevano la poesia a concetti e tipi generici.
Questo pareva a me una esagerazione peggiore, perché, se quelli guardavano nella poesia le forme piú grossolane, questi le sottraevano tutta la parte viva, sí che ella vania in astrazioni filosofiche.
Ora io combattevo anche con maggior calore queste esagerazioni.
Non potevo con pazienza sentir dire che l' Iliade rappresenta lo stato di famiglia, e che Achille rappresenta la forza.
Mi pareva che tutte queste rappresentanze fossero generalità astratte, e che a dir questo non si dicesse ancor nulla che valesse a darci un giudizio adeguato dello scrittore.
Mi trovavo tra i retori e i filosofi, e mostravo il viso agli uni e agli altri, studiando di tenermi in bilico tra i due estremi, coi miracoli del mio contenuto.
E mi messi a studiare l'organismo de' poemi, derivandolo dal contenuto cosí com'era situato e formato nella mente del poeta.
Quel mio quadro storico dell'umanità dava il contenuto in sé o astratto; ora io considerava la sua vita nelle forme poetiche.
Analizzai il contenuto pre-omerico, secondo le orme di Vico, e ne dedussi che Omero era la mente di quel contenuto.
Escludevo che l'Iliade fosse compilazione di rapsodie, fatta da qualche erudito.
Le grandi poesie hanno le loro fonti in cicli poetici anteriori, perché tutto si lega, e la storia, come la natura, non procede per salti: gradazioni progressive generano da ultimo il gran poeta, che dà a tutta la serie la forma definitiva.
Cosí Dante è il gran poeta delle visioni religiose; Petrarca è il gran poeta dei trovatori; Ariosto dié l'ultima mano alla serie cavalleresca.
Chiamare compilazioni le ultime e grandi poesie, solo perché non sono creazioni miracolose, ma produzioni di lunga e lenta elaborazione, è una esagerazione manifesta.
Come l'uomo è l'ultima e piú progredita forma della serie animale, cosí le grandi figure storiche dànno, ciascuna, l'ultima mano alla elaborazione de' secoli.
Citavo il motto del mio caro Leibnizio, che il presente è figlio del passato e padre dell'avvenire.
Esposi la potente unità organica dell'Iliade, e, ricordando un detto del mio buon maestro Fazzini, dicevo "essere cosí impossibile che quel poema fosse un accozzamento di rapsodie, come è impossibile che il mondo fosse un accozzamento fortuito di atomi".
Venendo a' tipi omerici, dicevo che bisognava tenere un procedimento contrario a quello del Vico.
Vico tirava dal vivo della poesia i tipi e le idee, perché costruiva una scienza della storia; noi dovevamo rituffare nella forma quei tipi e quelle idee, per avere l'intendimento dell'arte.
Perciò polverizzavano l'arte quelli che la riducevano a concetti puri, fraintendendo il Vico.
Mostrai che Achille non era un tipo generico ed esemplare, ma un tipo individualissimo, prodotto da que' tempi, come gli Dei e gli eroi, foggiato dal poeta in quell'atmosfera, della quale viveva egli medesimo; perciò non possibile ad imitarsi in altri tempi e da altri poeti.
Raffrontai quella forza barbara, indisciplinata e appassionata, co' sensi umani e anche delicati di Ettore, e commossi la scuola leggendo il famoso addio di Ettore, dove si rivelano il marito, il padre e il patriota.
Di Virgilio lessi il sogno del terzo libro e il fatto d'Eurialo e Niso, tirandone argomento a varie osservazioni di stile, giudicando io Virgilio come il piú grande stilista dell'antichità.
Feci l'architettura della Divina Commedia, mostrando quanta serietà di disegno era in quel viaggio, base sulla quale si ergeva l'edificio della storia del mondo, e piú particolarmente italiana e fiorentina.
Notai nell'Inferno una legge di decadenza sino alla fine, e nel cammino del poema una legge di progresso sino alla dissoluzione delle forme e alla conoscenza della immaginazione, superstite il sentimento.
Mi preparai la via, combattendo i metodi de' piú celebri comentatori, che andavano a caccia di frasi, di allegorie e di fini personali.
Notai che la grandezza di quella poesia è in ciò che si vede, non in ciò che sta occulto.
Lessi la Francesca, il Farinata, l'Ugolino, il Pier delle Vigne, il Sordello, l'apostrofe di San Pietro e altri brani interessanti, facendovi sopra osservazioni che non dimenticai piú, e furono la base sulla quale lavorai parecchi miei Saggi critici.
Posso dire che la mia Francesca da Rimini mi uscí tutta di un getto in due giorni, e fu l'eco geniale di queste reminiscenze scolastiche.
È inutile aggiungere che queste lezioni novissime sulla Divina Commedia destarono vivo entusiasmo.
I sunti, fatti da' miei discepoli e rimastimi, ne rendono una immagine pallidissima e, come dice Dante, "fioca al concetto".
Originali furono pure le mie lezioni sull'Orlando furioso.
Analizzando le qualità di quel contenuto cavalleresco, ne dedussi che quello che la turba chiamava disordine era ordine, e quello che la turba chiamava irregolarità era regola.
Tirai da quel contenuto la situazione e la forma di quella vasta varietà; e, posta quella situazione, trovavo regolare quella pluralità di azioni, che a' piú sembrava un peccato mortale.
Confutai le argomentazioni del Tasso nel suo Discorso sul poema epico, e chiamai lo scrittore un gran poeta e un mediocre critico.
Questo mi tirò addosso una tempesta.
Stefano Cusani, Giambattista Ajello, soprattutto Stanislao Gatti, dal piglio impertinente e ironico, me ne vollero, quasi avessi profferita una bestemmia.
Non potevo patire che il Tasso chiamasse l'Orlando furioso un poema senza principio e senza fine, e ci sentivo quella pedanteria che lo condusse alla Gerusalemme conquistata.
La controversia s'infuocò, e finí con un distinguo, ammettendo io che il Tasso era un critico valoroso secondo que' tempi.
In quella varietà ariostesca mostrai che avevano la lor parte legittima il licenzioso ed il ridicolo, dato sempre quel contenuto e quella situazione.
Notai che quel suo cotal riso a fior di labbra, quasi volesse prendersi beffe del suo argomento, era una ironia spontanea e incosciente di tempi adulti, che si rivelò con chiarezza riflessa nel Don Chisciotte.
Notai infine l'inesauribile varietà de' suoi colori, la limpidezza delle sue fantasie e delle sue forme, la forza fresca e allegra della produzione.
Lessi la famosa scena della Discordia, l'entrata di Rodomonte in Parigi, la morte di Zerbino, la pazzia di Orlando, l'andata di Astolfo alla luna, il combattimento di Biserta, Olimpia e Bireno, Cloridano e Medoro, la morte di Rodomonte.
In queste letture io ero minuto ne' piú delicati particolari dello stile e della lingua; e dicevano ch'era un altro, perché pareva che dalle piú alte contemplazioni scendessi nelle piú umili sfere.
La verità è ch'io mi sentivo sempre il maestro, sempre in contatto co' discepoli, e in quelle letture m'ingegnavo d'accostarmi piú a loro, di dir cose che non avevano trovato luogo nelle lezioni.
Esaminando il contenuto nella Gerusalemme, m'incontrai nella grossa questione dell'influenza del Cristianesimo sull'arte.
Allora non conoscevo ancora i fanatici panegirici, mescolati con sottigliezze dottrinarie, di Guglielmo Schlegel, e m'aiutavo da me.
Notai il carattere cosmopolitico, universale, cattolico della nuova religione, che oltrepassava le nazioni e creava l'umanità; i grandi centri di popoli, che allargavano l'orizzonte del poema epico; il concetto di fratellanza e di carità, che aboliva la schiavitú e stringeva in un solo patto tutti i figli di Eva; la consacrazione del dolore e del sacrificio, come via di redenzione; l'emancipazione dello spirito dalla materia; l'aspirazione a forme piú elevate e piú musicali, sino al puro sentimento.
Questo fu materia di parecchie lezioni.
E mi ci scaldai tanto che, dovendo padre Juppa, mio discepolo e uomo serafico per mansuetudine e innocenza di costumi, fare una predica su' benefizii del Cristianesimo, volli fargliela io medesimo, e riuscí un bello e dotto panegirico, molto lodato.
Mostrai quanta potenza l'idea cristiana ebbe nello spirito di Dante, e come la Divina Commedia fosse appunto la storia ideale del Cristianesimo.
Da questo desunsi i caratteri del contenuto, che il Tasso avea scelto per argomento.
Ma il Tasso non si obbliò in esso, e non lo fece suo, come Dante fece nella Divina Commedia, e come fece l'Ariosto nell' Orlando furioso.
Il Tasso non vi entrò con animo libero, e portò seco appresso le regole di Aristotile e la voga cavalleresca.
Cresciuto in mezzo a' retori, che si vantavano critici, volle fare un poema secondo le regole, e, scegliendo una materia nuova, volle innestarvi la parte cavalleresca.
Voleva in somma conciliare Omero e l'Ariosto, fare un Ariosto corretto e regolare, piú conforme alle leggi del verisimile e al senso storico.
Fu punito, perché trovò critici piú severi di lui, che accusarono il poema di scorrezione, e non lo trovarono né omerico, né aristotelico.
La parte cavalleresca fu trovata una intrusione e una dissonanza in argomento sacro, e si aggiunse che, diminuendo le proporzioni di quella fantastica cavalleria, per ridurle piú vicine al probabile, immeschiní la materia, senza farla piú corretta.
Cosí avvenne che parecchi gli preposero per regolarità il Trissino, e, quanto alla cavalleria, l'Ariosto gli rimase al di sopra.
E, poiché il suo spirito partecipava a quella critica ne' punti fondamentali, dopo vana resistenza, vi si rassegnò; e, per correggere gli errori del poema, volle rifarlo di pianta, e scrisse la Gerusalemme conquistata.
Il poeta era scomparso sotto la rigidità del critico.
Volendo accostarsi piú al verosimile e allo storico, guastò la verità poetica, e, correndo dietro all'ombra di bellezze teologiche, fece olocausto di bellezze profane, ch'erano la parte piú geniale del poema.
Seguendo regole convenzionali, perdette d'occhio le regole eterne dell'arte.
Non corresse, ischeletrí il poema.
Il Tasso era un poeta geniale, di molta immaginazione e sensibilità, dotato piú di dolcezza che di forza, e altissimo a far sue tutte le idee cristiane, la cui nozione fondamentale è la carità.
Abbattutosi in quel contenuto cristiano, ebbe poca virtú di trasfondersi in esso e cercare ivi le sue ispirazioni.
Si fece trascinare dalla moda e dalla critica, e, spirito poco resistente, visse in perpetua lotta tra questi elementi ostili.
Volle sottoporre a modelli omerici un contenuto di natura affatto diversa, e la moda, tirandolo appresso a' poeti cavallereschi e tormentandolo con l'immagine rivale dell'Ariosto, gli velò in parte la novità e la divinità del suo contenuto.
Quando, in età piú matura, volle porvi rimedio, era troppo tardi, e non attinse del nuovo contenuto che le parti esteriori e accidentali.
Nondimeno si deve alla ispirazione cristiana la parte piú eletta del suo poema: il fatto di Sofronia, la morte di Clorinda, e un cotal poco anche il suo Tancredi.
Lessi l'episodio di Sofronia, e mostrai l'intima sua commessura col poema, indicando la vanità di quella rassegna militare a imitazione omerica, ch'egli vi sostituí nella Gerusalemme conquistata.
Notai certi moti psichici, indizio di una intimità rara nei nostri poeti.
Cosí Tancredi prende superbia a vedere in maggior copia il sangue del suo nemico; Solimano piange alla vista del suo paggio ucciso; Argante, cominciando il duello, guarda a Gerusalemme caduta.
Anche è notevole una certa serietà di sentimento, quantunque l'espressione sia rettorica, com'è ne' lamenti di Tancredi e ne' furori d'Armida.
L'organismo del poema, come tessitura, è perfetto, e l'ottava, se non ha l'onda melodica del Poliziano e dell'Ariosto, è però piú nutrita e s'imprime piú facilmente nella memoria.
Nel vezzoso e nel molle non ha eguale, come si vede anche nell'Aminta.
Il suo viaggio alle Isole fortunate è un capolavoro, e le molli lascivie di que' giardini e di que' palagi magici sono una vera magia di stile.
Conchiusi che il Cristianesimo, nella sua ingenuità e spontaneità, aveva avuto la sua poesia nel Vangelo; e che quel contenuto, calato in mezzo a un'atmosfera ostile, impregnata d'indifferenza, di superstizione e d'ipocrisia, sperduto tra elementi poetici e critici, alieni dalla sua natura, non poté assimilarsi uno spirito entusiasta e malato, naufrago fra quelle correnti.
...
[Pagina successiva]

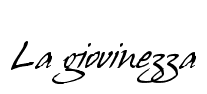 Libri online
Libri online