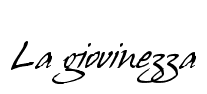[Pagina precedente]...gio piccante, peperoni gialli e una caraffa di vino asciutto furono per me un pranzo da re.
Mi levai arzillo e mi venne la chiacchiera con quei mulattieri, pastori e contadini, che trincavano, giocavano e bestemmiavano. Presto mi si fecero familiari, e m'invitarono a bere, e cioncai e giocai con loro, e non mi parve scendere dalla mia altezza. La natura non mi aveva dato un'aria signorile e di comando, e con la mia sincerità mi presentavo tal quale, senza apparecchio e senza malizia. "Evviva lo Signorino!" dicevano; e s'erano rabboniti tra loro, e io stringeva quelle grosse mani, come per dare un pegno di fratellanza.
A quel tempo era il regno dei galantuomini; i contadini, in povertà e in servitú, erano trattati come i loro asini; io non ne sapevo nulla, ed ero soddisfatto e quasi sorpreso dei loro evviva. Rialzato d'animo e di forza, mi messi a caracollare per la discesa, e via via giunsi a un torrente, che si menava dietro grosse pietre e faceva gran fracasso. Il contadino, presa la briglia, andava innanzi, tirati su i calzoni; io mi tiravo su le gambe per non bagnarmi, e perdendo l'equilibrio, caddi rovescioni nell'acqua, e il contadino mi afferrò e si disperava, e io gli dicevo: "Dio non peggio". Era un motto di papà , rimastomi impresso. Non giunsi in paese che a ora tarda, di notte. Entrai in casa, sorridente, con le braccia aperte. Non mi attendevano, e maggiore fu la gioia. Mamma voleva pagare il mulattiere. "È pagato, - diss'io, e trassi di tasca un borsellino pieno di piastre, e gliele offersi, dicendo: - A voi, mamma, le primizie". La buona donna rideva tra le lagrime, e tutti avevano gli occhi sbarrati su di me, come fossi un principe.
La mattina mamma mi fece mille tenerezze. Si staccava il bambino dal petto, e mi avvicinava, ridendo, la mammella, con l'aria di chi dica: "Ti ricordi?" E mi contava tante cose, e io, stando presso al letticciuolo, negl'intimi penetrali della memoria ritrovavo certe notti lunghe, ch'io mi svegliavo con grida e con pianti clamorosi, e lei veniva e mi toglieva in collo e diceva, palpandomi: "Non aver paura, mamma è con te". Io guardavo, guardavo, come volessi mettermela bene in mente. Ah! povera mamma, come le volevo bene! E ora m'intenerisco che l'ho innanzi a me, quella persona alta, asciutta e spigliata, con quella faccia bruna e le folte sopracciglia e gli occhi neri e dolci.
Presto la casa fu piena di gente. Molte strette di mano, molti baciozzi di zie e di comari. Il discorso si oscurò subito, ché il colera non invitato, entrava nella conversazione. Pretendevano che il morbo fosse apparso già in Avellino e in molti paesi vicini, e c'era chi sosteneva di averlo incontrato sulla via del cimitero, e della peggior natura, un vero colera fulminante; un contadino, appena colpito, morto. "Non lo chiamate troppo, che viene per davvero", diss'io. Quelli mi guardavano con sospetto, e volevano sapere da me perché, cosà giallo e tisico, mi avevano lasciato passare senza la quarantena; e i soprastanti del paese conchiudevano che bisognava chiudersi e non lasciare piú entrare nessuno, e per poco non mi volevano affumicare. Pochi dà appresso mi giunse notizia che il duca di Cassano, il giorno dopo ch'ero partito, colto da timor panico, s'era rifuggito sul Vomero, ed era morto subitamente. La notizia accese ancora piú le fantasie, e le facce erano oscure, e i discorsi lugubri. Io aveva la testa piena di grilli e non sapeva star solo. Mi vennero a noia paese e paesani, e presi il volo. La mattina seguente volli partire. Mamma, ancorché fosse innanzi l'alba, e il freddo grande, volle accompagnarmi fino al cimitero, e là c'inginocchiammo e pregammo. Io avevo una gran tosse e lei mi si attaccò al collo, e mi stringeva forte, e mi diceva con lacrime: "Figlio mio, forse non ti vedrò piú". Ed era presaga! Non dovevamo piú rivederci.
Trovai in Napoli il colera un po' rimesso. Gli studenti tornavano, le scuole si riaprivano; la novità era l'edizione fatta di fresco delle poesie di Giacomo Leopardi. Io ne andavo pazzo, sempre con quel libro in mano. Conoscevo già la canzone sull'Italia. Allora tutto il mio entusiasmo era per Consalvo e per Aspasia. Avevo preso lezione di declamazione dal signor Emanuele Bidera, che aveva stampato sopra la sua arte un volume, zeppo di particolarità e minuterie. Io era tra' suoi scolari piú diligenti, e quando c'era visita di personaggi, il primo chiamato ero io. "Fatevi avanti, signor De Sanctis, declamatemi l'Ugolino". Quello là era il mio Achille. E io, teso e fiero, trinciando l'aria con la mano diritta, cominciavo: "La testa sollevò..." Non mancavano i battimani; ma un uomo di spirito mi disse: "Piangete troppo". Ricordo il motto, non ricordo la persona. Ed era un motto vero. Io peccavo per eccesso, volendo accentuare tutto e imitare tutto, suoni, immagini, idee. Consalvo mi fece dimenticare Ugolino. Lo andavo declamando anche per via, e parevo fin ebbro, come Colombo per le vie di Madrid, quando pensava al nuovo mondo. Lo declamavo in tutte le occasioni, e mi c'intenerivo. Sovente lo declamai in casa Fernandez, e mi ricordo che, per un delicato riguardo alle signorine, dove il poeta diceva "bacio", io mettevo "guardo".
Poco poi seppi che il gran poeta era morto. Come, quando, dove non si sapeva. Pareva che un'ombra oscura lo avvolgesse e ce lo rubasse alla vista. Le immaginazioni, percosse da tante morti, poco rimasero impressionate da quella morte misteriosa.
Capitolo tredicesimo
ZIO CARLO E ZIO PEPPE
Il colera aveva ripreso con piú di vigore. Ma avevo ben altro in capo. Lo stato della famiglia mi teneva tutto tirato a sé. C'era speranza che zio Carlo guarisse interamente con la stufa ai piedi, come diceva il medico; ma intanto una gran tristezza lo aveva preso, e stava tutto il dà taciturno. Teneva corrispondenza epistolare una volta per settimana con zio Peppe, ch'era in paese e governava la famiglia. Zio Carlo, veggendosi in grandi strettezze, sfogava il suo mal umore con zio Peppe, e gli chiedeva non belle frasi di condoglianza, ma soccorso di danaro. Zio Pietro chiedeva la sua parte, scrivendo: "Non posso resistere al clamore dei miei figli, ai quali manca il bisognevole". Zio Peppe s'ingegnava alla meglio, e mandava prosciutti e caciocavalli. Ma ci voleva altro a calmare quei clamori! Il bisogno era grande. Cominciarono le ire e le recriminazioni, cattive compagne dei cattivi giorni. Le ire si volgevano contro il babbo, che aveva fatto un debito garantito da zio Carlo, e che non badava ai fatti di casa, e che si mangiava la porzione sua e di zio Pietro. E se la pigliavano pure con me, che m'ero incocciato ad abitare con Enrico Amante. In fondo era una lotta tra le due famiglie, quella di Napoli e quella di Morra, sostenuta e capitanata dai due preti, quello di Morra e quello di Napoli. A me dicevano plagas del babbo, e di me scrivevano plagas a zio Peppe: "Che io faceva lo zio monaco, e stavo sempre mutolo, ed ero l'uomo del mistero, un fanatico sofistico, un testardo". Zio Peppe mi scriveva lettere agrodolci, e che dovevo essere piú buono, e fare a modo dello zio Carlo, e non lasciar la casa, e non essere avaro dei miei guadagni verso la famiglia. Io, presupponendo donde venissero le accuse, mi chiudevo ancora piú in me, e non dicevo verbo, e non mi lasciavo scorgere, con gli occhi a terra e il muso duro, ciò che imbestialiva gli zii. Scrivevo poi a zio Peppe col tuono di un imperatore. A quel tempo avevo piena fede in me, e perché guadagnavo già di bei quattrini, mi pareva essere un re; mi pareva che bastasse battere i piedi a terra per farne uscir danaro. E scrivevo non aver bisogno di alcuno, e bastare a me io, ed esser buono anche per gli altri. Quest'aria di gradasso non dispiaceva a zio Peppe, un po' gradasso anche lui, che fra tante tenebre vedeva in me un raggio di luce.
M'era venuto in capo, disperato com'ero dello zio Carlo, che forse zio Peppe potesse ristorare le sorti della casa, venendo in Napoli e dirigendo lui la scuola. Avevo un po' gelosia di mio cugino che s'era avviato per il foro: e perché non io pure? Poi, quel maestro di scuola mi sonava cosa miserabile nella mente piena di Demostene e di Cicerone, e sognavo trionfi con la toga indosso, come antico romano. Non mi spiaceva perciò che zio Peppe stesse là a fare le cose di scuola, e ch'io entrassi in pratica, come Giovannino. E scrissi a zio Peppe che gli avevo trovato una buona lezione, e gli dipingevo il suo nuovo stato coi piú bei colori. Ma non voleva muoversi, e mettersi negl'impicci. Forse aveva fiutato ch'io voleva caricar lui della soma che stava addosso a me; ma il disegno pareva bello a zio Pietro e a zio Carlo, che ci vedevano uno scopo. Però quegli stette duro, e allora tornarono alla carica e chiedevano la loro porzione. Sà e no; gli animi s'inasprirono, e zio Peppe scriveva a zio Carlo che gli piaceva di fare il vezzoso, e questi rispondeva all'altro che gli piaceva di fare l'indiano. Tra i due si ficcava zio Pietro, che gridava di non poter tollerare che la sua porzione andasse a benefizio dei terzi. Questi propositi si tenevano talora innanzi a me, che mi facevo verde. "Anch'io voglio la mia porzione", scriveva l'uno. "Voi rovinate la famiglia", rispondeva l'altro. "Ciccillo è che rovina la famiglia". "Ah! quel briccone di Ciccillo; gli scrivo subito". "Zio Peppe, volete andare a Santo Jorio? Vi è una magnifica situazione per voi", questa era la mia risposta. E tra scrivere, rispondere e riscrivere passava il tempo, e i bisogni crescevano e i cuori s'indurivano.
Io n'ero arrabbiatissimo; vedevo tutte le batterie rivolte contro di me, come se al mondo non ci fossi altro che io; e non c'era altro nel mio capo che io, babbo e famiglia mia. Ora che ci guardo, mi viene da ridere. Non pensavo che in quella farsa stizzosa ciascuno rappresentava la parte a cui lo chiamava il suo interesse, e che tutto era ragionevole e non poteva andare che cosÃ. Finalmente una parola che era nel desiderio degli uni e nel timore degli altri, fu lanciata fuori come una bomba: "La divisione, vogliamo la divisione!" E qui zio Peppe a strepitare ch'era uno scandalo, e che i panni sporchi si lavano in famiglia, e che vis unita fortior. Invano. A Napoli non si poteva piú vivere, a Morra c'era da rivendicare il proprio. Partirono. Seppi che il povero zio aveva fatto la quarantena. Quando fu lasciato entrare, ricomparve nella casa paterna, dopo molti anni di assenza e di lavoro, povero e malato, sostenuto a braccia. E io che ce l'avevo con lui! Ora mi rimprovero di essere stato un fanciullo crudele.
Giovannino andò in casa di zia Marianna; io da Enrico Amante a San Potito, in un secondo piano. Al primo piano abitava un tal Luigi Isernia, un avvocato amico di casa Puoti, col quale pensavo di poter fare la pratica forense, giacché quel grillo non m'era ancora uscito di capo. Quando zio Carlo seppe il fatto, mi scrisse: "Evviva la furia francese!" E voleva che io stessi da zia Marianna insieme con Giovannino, col quale ero cresciuto. Ma gli risposi, che quando i padri si dividono, non potevano i figli restare uniti. Cosà si divisero a Morra e ci dividemmo a Napoli.
Capitolo quattordicesimo
CASI FORTUNATI
Il secondo palazzo di là dal quartiere dove erano allora accasermati gli Svizzeri, era quello in cui Enrico e io prendemmo casa. Al secondo piano era un gran terrazzo, con frequenti spaccature impeciate. Su di una parte di questo terrazzo era stata improvvisata una casetta di quattro stanze e una cucina, piena d'aria e di luce, che a noi parve una reggia. Zio Carlo aveva dato i mobili di casa tutti a Giovannino, e a stento avevo potuto impetrare un letto. Con quello m'impossessai d'una stanza. In un'altra s'installò Enrico col suo letto e con alcuni vecchi mobili. Un vecchio divano con quattro sedie sdrucite decoravano il nostro salotto. A dritta veniva uno stanzone immenso, con una gran finestra in fondo, uscito pur allora dalle mani del fabbricatore, con le mura bianche di calce, e col tetto non incartato e col pavimento non mattonato. Là , entran...
[Pagina successiva]