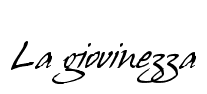[Pagina precedente]...zio e non so quanti altri dei piú ignorati. M'ero gittato anche sui cinquecentisti, sempre avendo l'occhio alla lingua. Il Gelli, il Giambullari, il Firenzuola, il Caro, il Castiglione, mi deliziavano. Nessuno dei miei compagni aveva tanto letto. E poi, ciascuno aveva le sue faccende; a molti quella scuola era una parentesi. Per me la mia faccenda era quella; non pensavo ad altro; stavo le intere giornate correggendo bozze di stampa, sfogliando dizionari e grammatiche. E a poco a poco, senza ch'io me ne accorgessi o ci pensassi, mi trovai il segretario e il favorito del marchese Puoti. Quello a cui prima non poneva la mira, come a cosa troppo alta, parve allora a me e a tutti cosa naturalissima. Non ch'io surrogassi qualcunaltro; nessun lasciò il suo ufficio; l'abate Meledrandi stava sempre lí col suo piglio beffardo e insolente. Il nome era pur quello, ma sotto al nome non c'era piú la cosa. Il marchese perdeva la pazienza, e l'interrompeva spesso. Una sera ch'egli faceva la lettura, il marchese era di pessimo umore, e lo correggeva aspramente, ripigliando la parola letta e pronunziandola lui, accompagnando la correzione con un certo suo intercalare favorito, che moveva a riso tutti. L'abate sbuffava, e non trovava loco, e non potendo piú tenersi, uscí a dire: "Ma insomma, ora debbo alzare la voce, ora no, debbo abbassarla; non so come uno si debba regolare con voi". Guardammo al marchese, e ci pareva che stesse lí lí per avventarglisi e pigliarlo pel collare; ma si contenne, e gli fece un'ammonizione senza intercalare, fredda e dura. Da quel dí Meledandri perdette autorità. Ritornò poi in Castellaneta, sua patria, e non ne seppi piú notizia.
Il marchese era tutto intento a compilare una grammatica a uso dei giovanetti, e si giovava dei miei studi e della mia erudizione. Mi presentò alla sua famiglia, e piú volte mi tenne a pranzo seco. Mi avevano posto per soprannome il grammatico. Io me ne teneva, e andava con la testa alta.
Capitolo NONO
COSE DI CASA
Intanto le cose di casa non andavano bene. Zio Carlo invecchiava; la famiglia s'era accresciuta; i mezzi scarseggiavano. Un bel giorno congedarono un maestro, e messero me a insegnare Storia Sacra. Di storie ne avevo lette infinite, senza critica e bevendomi tutto quello ch'era stampato. Avvenne che i miei scolari erano piú maliziosi di me, e quando io parlava con molta gravità delle foglie di fico o del vitello d'oro, quei birichini ridevano, e io m'incolleriva. La mente della famiglia era zio Pietro, gli anni e le fatiche avevano indebolito lo zio che lo lasciava fare, e lui aveva tirato a sé zia Marianna e regolava tutto. Era alto della persona, magro e asciutto. Venne dallo zio educato in Napoli, e non gli erano mancati studi letterarii e filosofici. Tornato dall'esilio, s'era messo a fare il medico, ma era già troppo innanzi con gli anni, e la clientela era scarsa. Aveva una cert'aria di civiltà, una certa sceltezza di maniere, che gl'imprimeva sul volto pallido non so quale distinzione. Era uomo accortissimo, con un certo saper fare. Tirava naturalmente pei figli, e tutto ciò che poteva sottrarre alla mia famiglia, non gli dispiaceva. In quel tempo Aniello suo secondogenito veniva già con noi alla scuola del Puoti; portava fresche da Roma le impressioni, e aveva, con una bella descrizione della Villa Borghese, attirata l'attenzione del marchese e dei compagni.
Giovannino e io eravamo nel termine degli studi legali. Zio Pietro pensava già ad allogare Giovannino presso un avvocato, per fargli la strada. Io poi nel suo pensiero doveva essere un aiuto dello zio per sorreggere la scuola in quei suoi vecchi anni. Cosí cominciai maestro di Storia Sacra.
Egli ne aveva parlato anche col marchese, al quale piaceva molto ch'io mi consacrassi alle lettere, e fin d'allora mi chiamava "il professorino". Io era l'occhio dritto dello zio non solo per i miei studi, ma per la mia tranquilla condotta, e non ricordo mai di aver ricevuto da lui alcun castigo. Naturalmente io era lo scudo della mia famiglia, e quando zio Pietro e zia Marianna dicevano male del babbo o mettevano in canzonatura mio fratello Paolino, zio li ammoniva con l'occhio, accennando alla mia presenza: il qual sentimento di delicatezza mi fece impressione. Essi mi sogguardavano e tacevano.
In questo mezzo era morto il professore di latino della Università, e s'era aperto il concorso. Zio Pietro stimolò molto lo zio perché concorresse anche lui. Zio vi consentí a malincuore, e passò ore angosciose tra preparazione, timori e speranze. Venne il dí. Si fecero gli scritti; poi si dovea tenere la lezione pubblica. Vi andò molta scolaresca, e vi andò zio Pietro, e vi andò il marchese e molti chiari uomini. A me batte il cuore, e non osai andare; pure i piedi mi tiravano là. Giunto alla chiesa del Gesú Nuovo, non proseguii, ed entrai e m'inginocchiai avanti all'inferriata dell'altare maggiore. Non so come, mi era venuta quell'idea. Rimasi lí per un pezzo col capo appoggiato ai ferri. Era già lungo tempo ch'io non usava a chiesa. La prima domenica che non sentii messa, quel pensiero mi stava come un chiodo in capo. Poi venne l'abitudine e l'indifferenza. Il governo che voleva per forza la fede della congregazione, ci rendeva odiosa ogni specie di culto. Pareva un atto servile. C'erano poi i malcreati che motteggiavano i giovani timorati di Dio.
Io avevo lasciato da parecchio ogni studio di filosofia, e mi stavano ancora in mente i principii religiosi, rimasti però in aria, senza alcuna base nella vita. Seguii l'andazzo. Non sentivo piú messa, non mi confessavo piú. Tutto questo, stando lí inginocchio, mi si affacciava come un rimprovero. Pensai che forse Dio per punire me non sosterrebbe lo zio nell'ardua prova. E mi posi fervidamente a pregare. Non erano avemarie e paternostri, come facevo piccino; era un'onda che mi gonfiava il cuore e si versava fuori. Stetti cosí un pezzo tra lacrime e preghiere. Uscí una messa ch'io sentii. Ma nel bel mezzo mi distrassi, e non seguii piú il prete, e seguii le ombre del mio cervello. Pensai a don Domenico Cicirelli e a quel tal Fortunato, e mi pareva gente sofistica e dappoco dirimpetto alla solenne e parlante grandezza di quella chiesa. Il mio sguardo si perdeva tra quelle volte, e mi pareva che tutte quelle facce di santi e di beati dipinti prendessero sangue e carne e guardassero me. Mi sovvenni del Figliuol prodigo, e m'intenerii, e non sapevo comprendere come avessi potuto tollerare gli sconci parlari dei cattivi compagni, e ripigliando l'antica usanza mi feci un gran segno di croce come per cacciarli via da me. Quel prete che diceva messa mi spirava divozione; guardavo con occhio amico quelle sottane lunghe e nere con quei berretti quadrati, e fino quel padre gesuita che disapprovò il mio latino, mi venne alla memoria e mi parve amabile nella sua severità. Finalmente, stanco di quel fantasticare, andai via, pensando che il mio nome era Francesco Saverio, quel Santo che fu Apostolo dell'Indie e decoro della compagnia di Gesú.
Andavo per via piú tranquillo, riconciliato con me stesso, pure non ben sicuro di aver fatto la mia pace con Dio, e mi promettevo di tornare colà a sentir messa il dí appresso. Continuando il cammino col vago disegno di andare fino all'Università, giunto alla svolta di San Sebastiano, mi voltai anch'io, e distratto e pensoso mi trovai in casa del marchese Puoti. Seppi ch'era tornato, e mi venne un batticuore, e salivo lentamente le scale come per pigliar tempo, non osando sapere da lui quello che pur tanto desideravo sapere; ma il timore era piú forte del desiderio. Giunsi ch'era già in camera tra un cerchio di giovani e diceva le sue impressioni. Io rimasi cosí sull'uscio, mezzo nascosto, e il marchese continuava con vivacità di parola e di gesto, con grandi atti pazienti di Gaetano che gli faceva la barba. "Il canonico Lucignani, - diceva lui, - ha fatto solo qualche cosa che valga; nella sua lezione c'era un passaggio felicissimo, e una bella interpretazione di un luogo di Quintiliano: gli altri hanno armeggiato". Quell'armeggiato mi sonò nell'orecchio come la sentenza oscura della Sibilla. "Come ha detto?" mi voltai con una gomitata a un compagno, e lui mi ripete: "Gli altri hanno armeggiato". Corsi in sala, dove si teneva la scuola, e presi in furia e in fretta il dizionario. Quell'armeggiare mi parevi dovesse significare combattere, battagliare, disputare la vittoria; mi rimaneva un filo di speranza per lo zio. La mia furia era tale che non mi riuscí subito trovare la pagina, e pestavo dei piedi. Finalmente mi venne innanzi quella maledetta pagina e quel maledetto armeggiare. Lessi che significava: fare opera vana, e divenni pallidissimo e caddi col capo sulla mano. Uscii a capo basso, come can frustato, senza pur vedere il marchese. Giunsi a casa, e lo zio era abbattutissimo e stanchissimo, e sentiva i conforti di D. Nicola del Buono che leggeva il suo scritto, pur facendo qualche appunto. Zio Pietro mormorava che D. Nicola era invidioso, e gli raggiava il volto, credendo alla vittoria di zio Carlo, e si voltò a me, dicendo, "Cosa ne dici tu, Ciccillo? Ah! tu non c'eri". Io non fiatai; ero inconsolabile, e chinai il capo, e mi ritirai in quell'angolo di casa, testimonio delle mie veglie e dei miei studi. Era sul tavolo un libro aperto, le Vite de' Santi Padri di Domenico Cavalca. Io presi il libro con dispetto e lo buttai giú, dicendo: "Al diavolo questi Santi Padri. Ho invocato oggi tutti i Santi dei paradiso. A che siete buoni voi altri Santi?" Poi mi pentii di quell'atto di superbia, e mi sovvenni che dovevo sentir messa il dí appresso, e raumiliato e stanco mi buttai sul letto e ingombra la mente di fantasmi m'addormentai.
Venne il dimane. Mi avviai e mi trovai innanzi al Gesú, ma indugiavo e non volevo entrare, e un pensiero mi diceva: "Sí, entra". Tra entrare e non entrare continuavo il cammino, e mi trovai dal marchese Puoti, e a chiesa non ci tornai piú.
Mio zio era rimasto percosso, s'era fatto piú curvo, e rompeva spesso in atti d'impazienza. Qualche volta vidi che lacrimava. Mi sembrò che fosse divenuto un po' freddo con me, e non mi volesse piú quel bene. Una sera, mentre io gli facevo le moine, si levò e mi percosse, e dovettero trarmi dalle sue mani. Cosa era nato? Anche oggi non lo so. Un'altra volta s'andava a fare una scampagnata sopra i Cacciottoli. Eravamo giunti al largo della Pigna Secca, quando dissero a zio che io portava una calzetta rotta, e zio s'infuriò e mi ordinò di ritirarmi a casa. Il mattino, secondo il solito, andai allo zio e dissi: "Zio, sono le sei e mezzo". Tornato piú tardi lo chiamai un'altra volta, egli si levò. Ero entrato in cucina allora allora, quando mi giunse una voce: "Ciccillo! Ciccillo!" Tesi l'orecchio, e la voce ripeté "Ciccillo!" Corsi e vidi che lo zio era per terra, e mi chinai per alzarlo, ed egli fece un gesto d'impazienza, come volesse dire: "Cosa puoi fare tu?" Corsi da zio Pietro, gridando: "Zio è caduto". Fummo tutti attorno a lui, e a gran fatica fu potuto rimettere a letto. Aveva perduto tutto il lato sinistro. Ecco subito salassi e sanguisughe e digiuni e cuffia di ghiaccio. Riebbe la parola, ci guardò, ci ravvisò. Noti lasciò piú il letto.
Capitolo DECIMO
LA CRISI
Fu quello un momento solenne nella mia vita. Non avevo mai pensato al dimane; tiravo innanzi alla spensierata e allegramente, come lo zio non dovesse mai morire, e le cose dovessero stare sempre cosí. Questo medesimo era in capo ai miei cugini. In casa era un allegria, una gara di studi e di esercizî geniali. Zio ci seguiva col suo occhio pieno d'affetto, e voleva, quando si levava il mattino, sentire da noi ripetizioni, conferenze, tutto ciò che imparavamo nei diversi rami dello scibile.
Stavo allora leggendo il Galateo ed il Cortigiano, e vago sempre di fatti guerreschi, la sera leggevo come un romanzo le Guerre di Fiandra del Bentivoglio e le Guerre civili del Davila. Quello studio delle frasi m'era venuto un po' a noia; le cose m'interessavano molto, e avevo la stessa ammi...
[Pagina successiva]