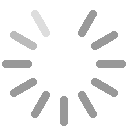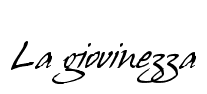[Pagina precedente]... lirica. Ci feci sopra una lezione che destò la piú viva impressione, e gli applausi mi suonano ancora nella mente. Cari e bei giorni quelli, che non ho ritrovati piú.
Leopardi era il nostro beniamino. Avevo acceso di lui tale ammirazione, che l'edizione dello Starita fu spacciata in pochi giorni. Quasi non v'era dí che, per un verso o per l'altro, non si parlasse di lui. Si recitavano i suoi Canti, tutti con uguale ammirazione; non c'era ancora un gusto cosí squisito da fare distinzioni; e poi, ci sarebbe parsa una irriverenza. Eravamo non critici, ma idolatri. Le canzoni patriottiche ci parevano miracoli di genio, ci aggiungevamo i nostri sottintesi. Quelle Silvie e quelle Nerine ci rapivano nei cieli, quel Canto del pastore errante ci percoteva di stupore. Una sola poesia non fu potuta digerire; né io né alcuno la potemmo leggere dall'un capo all'altro: I Paralipomeni. Anche la Batracomiomachia ci pesava. Vennero molti di fuori a sentire le mie lezioni sopra Leopardi, nome popolare in Napoli. Io lo chiamai il primo poeta d'Italia dopo Dante. Trovavo in lui una profondità di concepire e una verità di sentimento, di cui troppo scarso vestigio è nei nostri poeti. Lo giudicai voce del secolo piú che interprete del sentimento nazionale, una di quelle voci eterne che segnano a grandi intervalli la storia dei mondo. Esaminando il suo concetto, m'incontrai con Byron, che fece trionfale ingresso nella scuola, argomento prediletto di molti lavori. In quell'onda d'inganni e di disinganni, di aspirazioni e di disperazioni, cercai un capo saldo che mi desse il filo; e ne venne un ordine delle poesie, secondo le gradazioni dei suo concetto. Vedevo il suo pensiero svolgersi, a poco a poco, sino alla negazione universale, e anche in quello, a poco a poco, volli ficcare il naso, determinando le gradazioni e i passaggi.
In quel tempo la reazione contro l'idolatria delle forme conduceva all'idolatria del concetto, tenuto come criterio principale e quasi unico del valore di un'opera artistica. Si disputava se il concetto era buono o cattivo, volgare o nobile, vero o falso. Queste dispute sorgevano anche intorno al Leopardi. Io sostenni che il concetto non esiste in arte, non nella natura e non nella storia. Il poeta opera inconsciamente, e non vede il concetto, ma la forma, nella quale è involto e quasi perduto. Se il filosofo, per via di astrazioni, può cavarlo di là e contemplarlo nella sua purezza, questo processo è proprio il contrario di quello che fanno l'arte, la natura e la storia. Si può della storia, della natura e dell'arte fare una filosofia, ma è un lavoro ulteriore del pensiero su quelle produzioni spontanee. Perciò distinsi la forma dalle forme, e chiamai forma, non il concetto, ma la concezione, che è come l'embrione generato nella fantasia poetica. In questa produzione il poeta non sa quello che fa, appunto come la natura. I poeti primitivi sono assolutamente incoscienti, sono espressione spontanea e immediata di tempi tutto senso e immaginazione. Nei nostri tempi il critico e il filosofo coesistono nella mente, accanto al poeta: onde nasce una poesia riflessa. L'intelletto come tarlo penetra nella fantasia; ma nei grandi poeti la fantasia sommerge e sperde in sé il concetto, e lo profonda in modo nella forma, che solo piú tardi un'acuta riflessione può ritrovarlo. Anche oggi si disputa quale sia il concetto della Beatrice e della Margherita, il che dimostra l'eccellenza di quelle concezioni. Leopardi ha dovuto conquistarsi lui il suo concetto, e si vede il lavorío della mente dalle sue fluttuazioni. Ma quel concetto diventò sua passione e sua immagine, e qui è l'eccellenza della sua poesia. Il suo concetto è una faccia del secolo decimottavo e decimonono, lui incosciente, che lo attinse nella vigoria e originalità del suo pensiero. Ma è poeta, perché quel concetto è lui, è la sua carne e il suo sangue, il suo tiranno e il suo carnefice, ed è insieme il germe che, fecondato nella fantasia, genera le piú amabili creature poetiche. Le sue piú belle poesie sono quelle in cui la forma è vera persona poetica, di modo che il concetto vi apparisce come immedesimato ed obbliato nell'individuo, con appena un barlume della coscienza di sé. Cosí è nell'Infinito, nella Saffo, nel Bruto, nella Silvia, nella Nerina, nel Consalvo, nell' Aspasia. Quando il concetto non sia persona poetica, è necessario che sia almeno non una intellezione, ma uno stato appassionato dell'anima, o una visione della fantasia, com'è nei Salmi e nelle Profezie e negli Inni, e come nel canto Alla luna, in Amore e morte, nel Pensiero dominante. Al contrario, malgrado i fulmini di Pietro Giordani, tenni poesia mediocre La ginestra, dove la base poetica è occasionale, il concetto rimane nella sua astrattezza filosofica, e si esprime per via di argomentazioni e di ragionamenti. Dissi che, appunto presso al nostro vulcano, s'era spento quel vulcano poetico. Questa teoria della concezione, della fantasia, della situazione e della persona poetica; quest'obblio del concetto nella forma; questa incoscienza e spontaneità dell'artista fecero grande impressione, e sono rimasti sempre il capo saldo della mia critica. Accompagnavo le teorie con frequenti letture di quelle poesie, dove avevo modo di scendere nei piú fini particolari della composizione e dello stile.
Coronammo quelle lezioni con un pio pellegrinaggio alla tomba di Giacomo Leopardi. Divisi in piccoli gruppi, ci demmo la posta al di là della Grotta di Pozzuoli. Quei paesani ci guardavano con gli occhi grandi, e ci presero forse per una processione di devoti, che andavano in chiesa a sciogliere non so qual voto. Noi ci fermammo con religioso raccoglimento innanzi alla lapide, sulla quale è l'iscrizione di Antonio Ranieri, nome caro a noi, perché caro a Giacomo Leopardi.
Intanto in casa continuava la baldoria. Costretto a non interrotta meditazione per la novità delle mie lezioni, che mi tiravano il miglior sugo dal cervello, perché non aveva tempo né voglia di leggere, né libri adatti, e spesso tutto veniva da un'accanita riflessione in me stesso, lasciavo dietro di me i rumori di casa, e me ne andavo tutto solo a fantasticare per Capodimonte o per altri luoghi lontani, gesticolando, vagando talora con gli occhi distratti, e ripigliando poi il filo col mio solito: "Dunque, allons, pensiamo alla lezione". Quei buontemponi ch'erano attorno al greco, ne inventavano delle belle. Venne loro il ticchio d'imparare il ballo. Si fece una compagnia d'amici, e due volte la settimana era un diavoleto. Il bello e che vollero tirare anche me in quel gioco turbolento, e io mi ci acconciai di buona grazia, ricordando le lezioni del maestro Cinque. Non sapevo piú là del walzer tedesco; le chiamate della contraddanza poco mi volevano stare in mente. Non era ancora di moda la polka, ma c'era il walzer saltante e non so quali altre novità, e io con tutti quei sopraccapi ci metteva poco studio. Poi ero tutto d'un pezzo, come diceva il marchese, e non ci avevo grazia. Aggiungi una cert'aria professeur, come diceva il greco, l'aria del mestiere, che ti sale sulla faccia. I motteggi m'impacciavano di piú.
Si danzava quasi sempre nel gran salone, che qui chiamano galleria, sotto a cui stavano due stanze da letto di un commissario di polizia. A quel chiasso questi s'inalberò, e volle intimidirmi, abusando del suo ufficio. Io non sapevo nulla dei fatti suoi, anzi neppure chi abitasse in quella casa, sprofondato nelle mie lezioni. Un dí venne un feroce, come chiamavano la bassa gente di polizia, e m'invitò a recarmi presso l'ufficio. Era la prima volta che mi succedeva questo. La polizia era per me un nome scuro e pauroso, ma non altro che un nome; non ci avevo avuto mai che fare. Ci andai con la faccia scura: "Che sarà?" Trovai lí un signore grosso e tondo, che fece una brutta cera, e mi scaraventò certe parole grasse alla napoletana. Io restai grullo. Quando la tempesta finí, e mi fece capire cosa c'era sotto, io, sicuro del mio diritto, e poco pratico del mondo, risposi secco che in casa mia ero io il padrone, e potevo ballare a mia posta. L'amico, rauco per lo sforzo della voce e per la rabbia, balbettò che mi avrebbe insegnato lui l'educazione. Voltai le spalle e andai via sbuffando. Narrai il caso, e la compagnia si mise a far peggio, quasi a dispetto. Allora mi sentii chiamare in ufficio per "esibire il permesso della scuola". Questo mi impensierí. Io non avevo laurea né permesso, ero nel caso di quasi tutti i maestri, non perché la legge non ci fosse, ma per una cert'abitudine di tolleranza, che lasciava correre le cose. Capii onde veniva il tiro: quel signore lí non mi avrebbe lasciato piú quieto. Avrei potuto accopparlo, perché il prefetto di polizia aveva non so quale parentela con la famiglia Amante, a me affezionata, e poi c'era il marchese. I ballerini mi aizzavano, e qualche brutta idea di vendetta mi tentò un momento; ma la mia natura mite rifuggiva dalle soverchierie, e cercai un altro modo. Me ne aprii con un tale Albanesi, che faceva gli affari del mio padrone di casa. Costui sorrise del mio imbarazzo e della mia inesperienza, e disse che lasciassi fare a lui, e stessi tranquillo, che del permesso non si sarebbe parlato piú. Poi in tuono paterno aggiunse: "Ballate pure, ma in ogni cosa c'è modo". Non so che via tenne. L'effetto fu che quel signore, una volta che scendevo, si fe' trovare sull'uscio di casa, e mi tese la mano, e mi si profferse, dichiarandosi mio buon vicino, stimandomi un giovane dabbene, di cui aveva inteso a far molta lode. Io interrompeva e cercavo di venire al quatenus; ma lui fece un gesto con la mano, come volesse dire: "Al passato non ci si pensa piú". La parte d'uomo di spirito la fece lui, io feci la parte goffa. Il signor Albanesi non mi disse niente; io capii che se la intesero fra loro.
Intanto in fin di mese non mi trovavo mai bene a quattrini. Guadagnavo allora quanto non ho mai guadagnato in mia vita. Quei cinquanta ducati mi parevano inesauribili, ma pure quei danari del greco si liquefacevano come neve. S'erano introdotti in casa un disordine e una dissipazione a cui non vedevo fine. Mi credevo ricco, e mi trovai povero: maledissi il greco e i cinquanta ducati. Quei chiassi mi davano il capogiro; quel disordine mi stomacava; quella vita non era la mia, e ci stavo per forza. Pensai a ridurre le spese. Soppressi quel bicchiere di malaga che coronava il pranzo, una cattiva malaga che mi pareva sciroppo e mi facevano pagar salata. Il greco mi fece un ghigno, che mi saettò. Pensai che potesse recarlo a meschinità d'animo, e rallentai il freno. In quella baraonda montò la testa anche a me, e, chi il credería?, tornai ad Agnese. Colsi il pretesto che sua mamma venisse a lavarmi il bucato. Era imbruttita, con aria stanca di malata. Quel riso leggero non le veniva piú. Cercammo rianimarci l'uno e l'altra, ma la parola usciva fredda. E non la vidi piú. Verso la fine dell'anno, il fratello del greco mi scrisse una curiosa lettera, nella quale c'era qualche frase allusiva alla somma "enorme" dei cinquanta ducati. Quella parola "enorme" mi ferí, perché l'avevo trovata in bocca al greco, insinuatagli dai suoi compagni. E feci una risposta risentita, indicando la spesa che mi costava il greco. Mi portai da fanciullo, e ne venne un pettegolezzo. La fine fu buona: il greco andò via, e abitò in casa del fratello ch'era venuto in Napoli. Ci separammo con segni di cordiale amicizia: che infine quel povero diavolo non aveva altro torto che d'essere un capo scarico, ed era buono d'indole e di cuore, e si faceva voler bene da tutti. Cosí, finiti quei cinquanta ducati tentatori, mi sentii piú ricco. Rimaneva don Raffaele, che mi si era insediato in casa e spadroneggiava. Glielo feci capir bel bello; non se l'ebbe a male e rimanemmo amici.
Cominciai pure a essere un po' restío agl'imprestiti. Pareva che la borsa mia non fosse mia: ciascuno vi attingeva sotto nome d'imprestito. Quando incontravo qualcuno, quegli mi sfuggiva come un creditore. Mutai la servitú, ch...
[Pagina successiva]