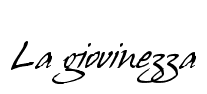[Pagina precedente]..." E mi narrò che, passando il carro dei principi, le maschere a furia di confetti avevano rotti i vetri al balcone, sfregiando signori e signore. Ora alcuni giovanotti per far vendetta apparecchiarono della calce, e quando il carro ripassò sotto al balcone, ve la gettarono tutta con parole e con gesti di minaccia. Figuriamoci. Le vie erano guardate da gendarmi a piedi ed a cavallo. Io capii il resto, "E... cosa sarà di noi ora?" Stava presso a me un gendarme, che mi domandò di quale paese ero. "Sono di Morra", diss'io. "E sono di Morra io pure, - disse lui, - e ti voglio dare un buon consiglio. Dateci qualcosa a noi altri, e vi faremo svicolare". La cosa fu sentita; si pose mano nel taschino, e io con molta premura diedi al mio bravo compaesano, chi lo sa?, due piastre, avanzo dei famosi trenta carlini. Ci fecero un bel sorrisetto, e colui disse a me, pigliando le due piastre: "Grazie, signorino". Noi con gli occhi a destra e a manca guardando i vichi; e quelli con gli occhi di traverso su di noi dicevano: "Avanti, avanti". Ci condussero in prefettura, e poi a Santa Maria Apparente. "Dove andiamo?" dicevo io. "Camminate, signorino, che è tardi; non dubitate". Salivo salivo che mi veniva l'affanno; quegli m'ammiccava; e io pensando che mi conduceva a casa mi trovai per un ponte tra brutti ceffi in un camerone oscuro, dove fummo gittati tutti come una balla. Sentimmo chiavare l'uscio con molto fracasso. Non dico che ci guardammo l'un l'altro stupiti; ché non ci si vedea.
Ma quei giovinastri urlavano a piena gola: "Ehi! ma non è questa la maniera. Custode, custode. Ma dateci almeno un lume". L'uomo aprà e si piantò sull'uscio con un lanternino in mano, gridando: "Cosa volete?" "Ma non c'è un letto, ma non c'è una sedia, ma non c'è un lume; ma che modo è questo? ma che abbiamo fatto?" E l'uomo dal lanternino si fece piú brutto e disse: "Belli figlioli, se fate ancora gl'ineducati, vi metterò giú giú, nel criminale, e v'insegnerò io l'educazione". E fece un gesto con la mano, che voleva significare, "vi darò le mazzate". La paura li ammansÃ; gli fecero cerchio, con aria supplichevole. E allora il cerbero si mansuefece, e lasciò intendere che coi danari si accomodava tutto. "Volete sedie? volete letti? volete buona cena e buon vino? pagate, pagate, signori; altrimenti ecco quello che passa il carcere"; e ci mostrò del pan muffito e nero, e una brocca d'acqua polverosa. Nessuno aveva in tasca piú un grano; ché i gendarmi si avevano preso tutto. Si venne a patti. Il custode farebbe la nota; e noi avremmo pagato tutto. Cosà fu portato del vino, del formaggio, buoni letti, delle sedie. Vennero certi altri, brutte facce, e si levavano il berretto, e si offrivano a servirci, e il custode a dire ch'eravamo signori e ci trattassero bene. Tutto andò per lo meglio. Quei birboni mezzo ubbriachi ci raccontavano tante brutte storielle di quel carcere, e che si davano le mazzate e che l'affare era grosso, nientemeno da lavori forzati, e non ci fecero chiudere occhio tutta la notte.
La mattina, appena mi reggevo in piè. Ero stato sempre raggomitolato in un cantuccio, con la mano sulla fronte, come estraneo a quella scena. Quando il freddo mi poteva, camminavo in fretta, e mi parlavano e non sentivo, ero assorto nel mio dolore, tormentato dal pensiero della famiglia: "Che avrà detto lo zio? povero zio!" Le lacrime mi tremavano negli occhi. Quel D'Amore aveva sparso ch'io poteva molto sul marchese Puoti, e che quella era la via della liberazione. Ed eccoli intorno a me, e io scrissi una bella lettera al marchese, narrando il fatto e dichiarando tutti innocenti. Si promise una bella moneta a uno di quei birboni, e la lettera fu portata. L'ansietà era grande; si contavano i minuti; carcerieri e carcerati sogghignavano, portando false notizie; ora era un prorompere di gioia, ora un impallidire mortale; e intanto la nota s'ingrossava. Ciascuno aveva scritto alla sua famiglia; e un po' di moneta circolava, appariva e spariva; l'ingordigia di quei bricconi era una botte senza fondo. Ed ecco si sente come un grande spalancare di porte: "Cosa è nato? sarà un noioso carcerato, sarà la grazia. Sà e no". Il custode si accosta gravemente e dice: "Chi è tra voi il signor De Sanctis?" "Ecco", - diss'io. - "Lei può andar via". "Come? come? lui solo?" fu il grido di tutti. E seguitavano che una era la causa, e se usciva uno, dovevano uscir tutti, e che la non andava cosÃ, e volevano ragione dal custode, come fosse lui il re. E vollero ch'io non uscissi, e che riscrivessi al marchese. A farla breve, verso sera che s'era fatto scuro, venne l'ordine per tutti. Mi abbracciavano; divenni ai loro occhi un pezzo grosso; il custode si levò il berretto. Ma non fummo lasciati uscir subito. Si venne al conto; e cominciò un vero battibecco alla napoletana sui prezzi con strilli e voci e gesti grossolani; i piú focosi minacciavano, e quelli ridevano. "Pagate, pagate, signori". Poi c'erano i cosà detti servi, che ci avevano rotto la testa tutta la notte; e c'era il custode che voleva il regalo, e altre brutte figure; ciascuno stendeva la mano e voleva la mancia. Bisognò mandare alle famiglie, e chieder nuovo danaro. Quando scendevamo pel ponte, quei ladroni fermi sulla gran porta ci facevano le sberleffe, e qualche voce ci giungeva, "bambocci, ragazzaglia", e non dico le parole sconce. Ma chi l'udiva? Quando fummo fuori, non ci pareva vero. Ciascuno corse a casa. Io non vidi zio Pietro e zia Marianna che mi venivano incontro, e corsi difilato allo zio che piangeva. Me ne disse delle belle; io non cercai difendermi, e stanco morto me ne andai a letto. La mattina mi levai fresco come una pasqua, e raccontai il fatto ai cugini e a zio Pietro, con certi miei ricami e abbellimenti. La poca pratica della vita, e la lettura dei romanzi mi avvezzavano a queste bugie della immaginazione.
Tornai muto e tristo. Non avevo piú gusto per la scuola; non aprivo piú un libro; avevo la testa vagabonda; non venivo a nessuna conclusione. Zio Pietro pretendeva che dessi a uso della famiglia anche quel po' po' di denaro che mi veniva da qualche lezione privata. Io non voleva. Divenni sospettoso, immaginavo le cose piú assurde a mio danno, e fin d'allora mi sentii solo. Ripensandoci su, vedo che quella concitazione di nervi, quell'umor nero e pieno di sospetti e di fantasmi, avea la sua origine da fanciullaggini. Ma tant'è. Il fanciullo mette nelle sue piccole quistioni quella serietà e quella passione che l'uomo mette nelle cose grandi. Io mi tenevo già un uomo, e non ero che un fanciullo. La natura non mi avea concesso né garbo, né malizia. Parlavo di prima impressione, e mi usciva tutto di bocca; poi mi pentivo, e mi promettevo maggior attenzione, per tornar sempre da capo. Guardavo in me; non guardavo nelle intenzioni e nelle malizie altrui, ed ero come un uomo posto in cosà mala luce, che scopre sé e non vede gli altri.
Capitolo undecimo
SOLO
Stavo cosà isolato in mezzo alla famiglia, con l'animo altrove. La mia vita era giorno per giorno, senza disegno, senza avvenire e senza studi. Dell'insegnare m'ero annoiato; pur facevo puntualmente il mio dovere, ma come si fa un mestiere. Le famiglie, vedendo continuare la malattia dello zio, e non confidando in un giovinetto che aveva egli stesso bisogno di scuola, menavano via i loro figli. Si fiutava poco lontana una catastrofe. Le difficoltà della vita inasprivano i caratteri. Io era come uccello che ha messe le prime piume, e sta per prendere il volo. Quella casa dove mi sentivo poco amato, mi pareva una prigione. Quando mi vedea in istrada, mi si schiariva la faccia, mi sentivo il respiro piú libero. Traevo profitto da ogni ritaglio di tempo, per fare le mie lezioni private, e ne avevo già parecchie. Il marchese, che mi aveva in grande stima, soleva affidare a me l'incarico di apparecchiare alle sue lezioni i giovani piú scarsi nell'italiano e nel latino. Cosà mi trovai maestro del Fernandez e di un tal C...
Costui era un furfante, che mi promise di pagare alla fine dell'anno, e dopo di avermi ben bene sfruttato, a me che gli ricordavo la promessa, rispose con una lettera villana, conchiudendo col minacciare. Rimasi attonito, come innanzi a cosa incredibile, e mostravo la lettera a tutti, e la collera mi schizzava dagli occhi, e tutti dicevano, stringendosi nelle spalle: "Cosa volete? gli è un camorrista". Era la prima volta che questa brutta parola mi giunse all'orecchio. L'indifferenza di tutti mi recò non meno stupore che l'audacia di quello. "Gli uni degni dell'altro", pensai. Per me, l'avrei preso per la gola. Non mi pareva possibile il trionfo della forza brutale sulla giustizia. Un dà scendevo per la via di San Sebastiano, ed ecco che mi viene di faccia quel tale, e io lo investo con parole pronte e focose. Colui, colto cosà all'improvviso, e forse colto dalla vigliaccheria propria dell'uomo insolente, si turbò, balbettò qualche parola, e tirò diritto. Quello per me fu uno sfogo, mi sentii piú leggiero.
In quell'anno non potevo andare dal marchese cosà di frequente, come per lo passato. Non mancavo alle mie lezioni la sera; ci andavo regolarmente tutti i giovedà e le domeniche, e lavoravo sempre con lui alla grammatica. Allora il marchese si faceva assistere da Gabriele Capuano, uno degli "Eletti", giovane di famiglia patrizia, di una educazione squisita, e bravo amico, al quale mi affezionai molto. Aveva quel certo sorriso di distinzione che esprime un'incosciente superiorità ; ma vi univa un cosà buon garbo, ch'io mi sentivo soggiogato, e pendevo dalle sue labbra. Andavo spesso e volentieri con lui; mi menò in sua casa, e presi a far lezioni di latino a suo fratello Ciccillo. Mi davano i soliti trenta carlini. Quest'amicizia mi fece molto bene in quello stato solitario dell'anima. Chiuso per natura, con lui mi si scioglieva lo scilinguagnolo, mi veniva la chiacchiera. Pure quel suo contegno piú cortese che affettuoso mi rendeva timido; non c'era abbandono.
In queste lezioni private avevo piú piacere che in quelle date in classe a casa mia. Il mio naturale affettuoso era piú appagato in conferenze, nelle quali il linguaggio di maestro era mescolato con l'accento d'amico. Ma uno dei miei piú vivi piaceri era il fare grandi passeggiate da solo a solo, cosa tanto piú cara, quanto piú rara. D'ordinario andavo per Capodimonte, e talora mi facevo una camminata a piedi fino a Portici o alla punta di Posillipo o su al Vomero. Camminavo frettoloso, a testa bassa, abbandonato alla immaginazione, e facevo la faccia brutta quando qualcuno mi si avvicinava. Andavo occhieggiando qua e là , ma con lo sguardo distratto, senza scopo: ero tutto dentro di me. Talora qualcuno piú ostinato mi si attaccava a' panni, e voleva per forza entrare in conversazione. Io non era buono a parlare di altro che di studi, e mi ci riscaldavo e gridavo forte e gestivo ancora piú, a gran sorpresa e noia del mal capitato, che andava via pensando: costui è troppo grand'uomo per me. I discorsi di moda e di avventure galanti, i sozzi parlari mi seccavano: giungevano appena al mio orecchio. Anche quel parlar dei fatti altrui, quel contare le scempiaggini o le monellerie di questo o di quello mi trovava distratto.
I momenti piú deliziosi li passavo nella scuola del marchese. Pochi andavano via; c'erano sempre nuovi venuti; la discussione de' lavori mi allettava; la lettura era sempre di cose nuove; piú che una scuola, pareva quello un trattenimento letterario; era una varietà , quasi uno svago nella monotonia della mia vita. Il marchese s'era un po' infastidito de' novizi e si volgeva piú volentieri agli "Eletti" e agli "Anziani"; la moltitudine ci stava come gli spettatori nella platea. Cominciavano i trecentisti a esser messi in disparte; si venne al Quattrocento e al Cinquecento e anche un po' al Seicento. Quelle letture fatte alla buona, accompagnate dai gesti e dalle esclamazioni del marchese, facevano in me una impressione incancellabile. Non avevo letto ancora nulla del Poliziano; una sera furono lette alcune delle sue ott...
[Pagina successiva]