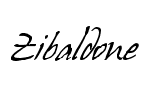[Pagina precedente]...lli che formarono le prime monete, cioè rame o ferro ec.) bruttissime ancora a vedersi. E quanto spazio passasse effettivamente prima di tutto ciò, si deduce anche dal fatto, e dal vedere che a' tempi d'Omero, o almeno a' tempi troiani (benchè certo non incolti), o mancava, o era di poco e raro uso la moneta.
E qui torno a domandare se la natura poteva ragionevolmente porre sì grandi, numerosi, incredibili ostacoli al ritrovamento di un mezzo necessario e principale per ottener quella che noi chiamiamo [1172]perfezione e felicità del genere umano, cioè l'incivilimento; e dico al ritrovamento dell'uso della moneta.
Osservate poi, nella stessa moderna perfezione delle arti, le immense fatiche e miserie che son necessarie per proccurar la moneta alla società . Cominciate dal lavoro delle miniere, ed estrazion dei metalli, e discendete fino all'ultima opera del conio. Osservate quanti uomini sono necessitati ad una regolare e stabile infelicità , a malattie, a morti, a schiavitù (o gratuita e violenta, o mercenaria) a disastri, a miserie, a pene, a travagli d'ogni sorta, per proccurare agli altri uomini questo mezzo di civiltà , e preteso mezzo di felicità . Ditemi quindi 1. se è credibile che la natura abbia posta da principio la perfezione e felicità degli uomini a questo prezzo, cioè al prezzo dell'infelicità regolare di una metà degli uomini. (e dico una metà , considerando non solo questo, ma anche gli altri rami della pretesa perfezione sociale, che costano il medesimo prezzo.) Ditemi 2. se queste miserie de' nostri simili sono consentanee a quella medesima civiltà , alla quale servono. È noto come la schiavitù sia [1173]difesa da molti e molti politici ec. e conservata poi nel fatto anche contro le teorie, come necessaria al comodo, alla perfezione, al bene, alla civiltà della società . E quello che dico della moneta, dico pure delle derrate che ci vengono da lontanissime parti, mediante le stesse o simili miserie, schiavitù ec. come il zucchero, caffè ec. ec. e si hanno per necessarie alla perfezione della società . V. p.1182.
E vedete da questo, come la civiltà (secondo il costume di tutte le false teorie) contraddica a se stessa anche in teorica, ed oltracciò non possa sussistere senza circostanze che ripugnano alla sua natura, e sono assolutamente incivili, anzi barbare in tutta la verità e la forza del termine. Sicchè la perfetta civiltà non può sussistere senza la barbarie perfetta, la perfezione della società senza la imperfezione (e imperfezione nello stesso senso e genere in cui s'intende la detta perfezione); e tolta questa imperfezione, si taglierebbero le radici alla pretesa perfezione della società .
Torno a domandare se tali contraddizioni ed assurdi è presumibile che fossero ordinati e disposti primordialmente dalla natura, intorno alla perfezione, vale a dire al ben ESSERE della principal creatura terrena, cioè l'uomo.
[1174]E notate che l'uso della moneta quanto è necessario a quella che oggi si chiama perfezione dello stato sociale, tanto nuoce a quella perfezione ch'io vo predicando; giacchè il detto uso è l'uno de' principalissimi ostacoli alla conservazione dell'uguaglianza fra gli uomini, e quindi degli stati liberi, alla preponderanza del merito vero e della virtù ec. ec. e l'una delle principalissime cagioni che introducono, e appoco appoco costringono la società all'oppressione, al dispotismo, alla servitù, alla gravitazione delle une classi sulle altre, insomma estinguono la vita morale ed intima delle nazioni, e le nazioni medesime in quanto erano nazioni. (16. Giugno 1821.). Quel che si è detto della moneta si può dire di mille altri usi ec. necessari alla società o civiltà , e pur d'invenzione ec. difficilissima, come la scrittura, la stampa ec.
Ho detto più volte che la letteratura francese è precisamente letteratura moderna, ed è quanto dire che non è letteratura. Perchè considerando bene vedremo che i tempi moderni hanno filosofia, dottrina, scienze d'ogni sorta, ma non hanno propriamente letteratura, e se l'hanno, non è moderna, ma di carattere antico, ed è quasi un innesto dell'antico sul moderno. L'immaginazione ch'è la base della letteratura strettamente considerata, [1175]sì poetica come prosaica, non è propria, anzi impropria de' tempi moderni, e se anche oggi si trova in qualche individuo, non è moderna, perchè non solamente non deriva dalla natura de' tempi, ma questa l'è sommamente contraria, anzi nemica e micidiale. E vedete infatti che la letteratura francese, nata e formata in tempi moderni, è la meno immaginosa non solo delle antiche, ma anche di tutte le moderne letterature. E per questo appunto è letteratura pienamente moderna, cioè falsissima, perchè il predominio odierno della ragione quanto giova alle scienze, e a tutte le cognizioni del vero e dell'utile (così detto), tanto nuoce alla letteratura e a tutte le arti del bello e del grande, il cui fondamento, la cui sorgente e nutrice è la sola natura, bisognosa bensì di un mezzano aiuto della ragione, ma sommamente schiva del suo predominio che l'uccide, come pur troppo vediamo nei nostri costumi, e in tutta la nostra vita d'oggidì.
(16. Giugno 1821.)
Quanto più cresce il mondo rispetto all'individuo, tanto più l'individuo impiccolisce. I nostri antichi, conoscendo pochissima parte di mondo, [1176]ed essendo in relazione con molto più piccola parte, e bene spesso colla sola loro patria, erano grandissimi. Noi conoscendo tutto il mondo, ed essendo in relazione con tutto il mondo, siamo piccolissimi. Applicate questo pensiero ai diversissimi aspetti sotto i quali si verifica che essendo cresciuto il mondo, l'individuo s'è impiccolito sì fisicamente che moralmente; e vedrete esser vero in tutti i sensi che l'uomo e le sue facoltà impiccoliscono a misura che il mondo cresce in riguardo loro.
(16. Giugno 1821.)
Ho detto altrove che il troppo, spesse volte è padre del nulla. Osserviamolo ora nel genio e nelle facoltà della mente. Certi ingegni straordinarissimi che la natura alcune volte ha prodotti quasi per miracolo, sono stati o del tutto o quasi inutili, appunto a cagione della soverchia forza o del loro intelletto o della loro immaginazione, che finiva nel non potersi risolvere in nulla, nè dare alcun frutto determinato.
1. Questi tali geni sommi hanno consumato rapidamente il loro corpo e le stesse loro facoltà mentali, lo stesso genio. La soverchia delicatezza de' loro organi li rende e più facili a consumarsi, e più facili a guastarsi, rimanendo inferiori di facoltà agli organi i meno delicati, e i più imperfetti. Testimonio Pascal, morto di 39 [1177]anni, ed era già soggetto a una specie di pazzia. Testimonio Ermogene che forse fu uomo insigne e straordinario, sebbene il suo secolo non gli permettesse di parer tale anche a noi, durante quel poco di tempo che gli durò l'uso delle sue facoltà mentali. Testimonio quel Genetlio di cui parla Esichio Milesio e Suida, il quale non era che un portento di memoria; ma quello ch'io dico dell'intelletto o della fantasia, dico pure della memoria, e si sono spesso veduti uomini che erano portenti di memoria da giovani, divenir maraviglie di dimenticanza da vecchi, o ancor prima. V. il Cancellieri, Degli uomini di gran memoria ec. S'io volessi qui noverare gli uomini insigni che hanno sofferto dal lato del loro fisico, non per altro che a cagione del loro troppo ingegno; e le morti immature che paiono essere inevitabili agli uomini di genio straordinariamente prematuro, e prematuramente sviluppato e coltivato, non finirei mai. V. in proposito del Chatterton famoso poeta morto di 19 anni, lo Spettatore di Milano, Quaderno 68. p.276. Parte straniera.
2. Questi geni straordinari, penetrano in certi [1178]misteri, in certe parti della natura così riposte; scuoprono e vedono tante cose, che la stessa copia e profondità delle loro concezioni, ne impedisce la chiarezza tanto riguardo a essi stessi, quanto al comunicarle altrui; ne impedisce l'ordine, insomma vince le loro stesse facoltà , e non è capace, a cagione dell'eccesso, di essere determinata, circoscritta, e ridotta a frutto. La forza della loro mente soverchia la capacità della stessa mente, perchè insomma la natura, e la copia delle verità esistenti è molto maggiore della capacità e delle facoltà dell'uomo. E il troppo vedere, il troppo concepire, rende questi tali ingegni, sterili e infruttuosi; e se scrivono, i loro scritti o sono di poco conto, ed anche aridi espressamente e poveri (come quelli di Ermogene); o certo minori assai del loro ingegno. Come quegli animali inetti alla generazione per l'eccesso della forza generativa (i muli). E la stupidità della vita è ordinariamente il carattere di tali persone, o mentre ancora son giovani, o da vecchi, come narrano che fosse detto a Pico Mirandolano. Quello che dico dell'intelletto e della filosofia, dico pure della immaginazione e delle arti che ne derivano. Esempio del Tasso, della sua pazzia, dell'essere i suoi [1179]componimenti, quantunque bellissimi, certo inferiori alla sua facoltà , ed a quegli stessi degli altri tre sommi italiani, a niuno de' quali egli fu realmente minore. E lo stesso dico eziandio di qualunque altra facoltà e disciplina particolare.
(17. Giugno 1821.)
Non è verisimile che la lingua chinese si sia conservata la stessa per sì lunga serie di secoli, a differenza di tutte le altre lingue. Eppure i suoi più antichi scrittori s'intendono mediante le stesse regole appresso a poco, che servono ad intendere i moderni. Ma la cagione è che la loro scrittura è indipendente quasi dalla lingua, come ho detto altrove, e (come pure ho detto) la lingua chinese potrebbe perire, e la loro scrittura conservarsi e intendersi nè più nè meno. Così dunque io non dubito che la loro antica lingua, malgrado l'immutabilità straordinaria di quel popolo, se non è perita, sia certo alterata. Il che non si può conoscere, mancando monumenti dell'antica lingua, benchè restino monumenti dell'antica scrittura. La quale ha patito bensì anch'essa, e va soffrendo le sue diversificazioni; ma i caratteri (indipendenti dalla lingua nel chinese) non essendo nelle mani e nell'uso del popolo, (massime nella China, [1180]dove l'arte di leggere e scrivere è sì difficile) conservano molto più facilmente le loro forme essenziali e la loro significazione, di quello che facciano le parole che sono nell'uso quotidiano e universale degl'idioti e de' colti, della gente d'ogni costume, d'ogni opinione, d'ogni naturale, d'ogni mestiere, d'ogni vita, e accidenti di vita. (A questo proposito ecco un passo di Voltaire portato dal Monti Proposta ec. vol.2. par.1. p.159. Quasi tutti i vocaboli che frequentemente cadono nel linguaggio della conversazione, ricevono molte digradazioni, lo svolgimento delle quali è difficile: il che ne' vocaboli tecnici non accade, perchè più preciso e meno arbitrario è il loro significato.) E lo vediamo pur nel latino, perduta la lingua, e conservati i caratteri, quanto alle forme essenziali, e al valore. Così nel greco ec. Ora nella China, conservato l'uso, la forma, e il significato de' caratteri antichi, è conservata la piena intelligenza delle antiche scritture, quando anche oggi si leggessero con parole e in una lingua tutta diversa da quella in cui gli Antichi Chinesi le leggevano.
(17. Giugno 1821.)
Dell'antico significato di fabula onde favella, e di ????? v. le note Variorum al 1. lib. di Fedro, prologo, verso ult.
(18. Giugno 1821.)
Noi diciamo fuso sostantivo mascolino singolare, e fusa plurale femminino, secondo la proprietà della lingua nostra di dare a parecchie voci nel plurale, la desinenza del neutro plurale latino, del che vedi il Ciampi De usu linguae italicae saltem a saeculo sexto, dove mostra come molti di questi nostri plurali femminini in a derivino da un latino popolare [1181]ec. Queste tali desinenze italiane pare che indichino de' neutri latini corrispondenti, e quel fusa dell'italiano pare che indichi un neutro latino fusum, o almeno il suo plurale fusa, come da brac...
[Pagina successiva]