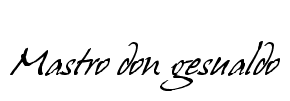[Pagina precedente]...li altri, ma stringevasi nelle spalle e se la cavava con simili risposte:
- Che volete? Ciascuno fa il suo interesse. Vuol dire che il barone Rubiera ci ha trovato il suo vantaggio a sposare la signora Alòsi.
La verità era che don Ninì aveva dovuto pigliarsi l'Alòsi per salvare quel po' di casa che don Gesualdo voleva espropriargli. E' vero che adesso era diventato giudizioso, tutto dedito agli affari; ma sua madre, sepolta viva nel seggiolone non lo lasciava padrone di un baiocco; si faceva dar conto di tutto; voleva che ogni cosa passasse sotto i suoi occhi; senza poter parlare, senza potersi muovere, si faceva ubbidire dalla sua gente meglio di prima. E attaccata alla sua roba come un'ostrica, ostinandosi a vivere per non pagare. Il debito intanto ingrossava d'anno in anno: una cosa che il povero don Ninì ci perdeva delle nottate intere, senza poter chiudere occhio, alle volte: e alla scadenza, capitale e usura, rappresentavano una bella somma. Il canonico Lupi, che andò in nome del baronello a chiedere dilazione al pagamento, trovò don Gesualdo peggio di un muro: - A che giuoco giochiamo canonico mio? Sono più di nove anni che non vedo né frutti né capitale. Ora mi serve il mio denaro, e voglio esser pagato.
Don Ninì pel bisogno scese anche all'umiliazione d'andare a pregare la cugina Bianca, dopo tanto tempo. La prese appunto da lontano. - Tanto tempo che non s'erano visti! Lui non aveva faccia di comparirle dinanzi, in parola d'onore! Non cercava di scolparsi. Era stato un ragazzaccio. Ora aveva aperto gli occhi, troppo tardi, quando non c'era più rimedio, quando si trovava sulle spalle il peso dei suoi errori. Ma proprio non poteva pagare in quel momento. - Son galantuomo. Ho di che pagare infine. Tuo marito sarà pagato sino all'ultimo baiocco. Ma in questo momento proprio non posso! Tu sai com'è fatta tua zia! che testa dura! Ne abbiamo avuti dei dispiaceri per quella testa dura! Ma infine non può campare eternamente, poveretta, com'è ridotta...
Bianca era rimasta senza fiato al primo vederlo, senza parole, facendosi ora pallida e ora rossa. Non sapeva che dire, balbettava, sudava freddo, aveva una convulsione nelle mani che cercava di dissimulare, stirando macchinalmente le due cocche del grembiule. A un tratto ebbe uno sbocco di sangue.
- Cos'è? cos'è? Qualcosa alle gengive? Ti sei morsicata la lingua?
- No, - rispose lei. - Mi viene di tanto in tanto. L'aveva anche don Diego, ti rammenti? Non è nulla.
- Bene, bene. Intanto fammi questo piacere; parlane a tuo marito. In questo momento proprio non posso... Ma son galantuomo, mi pare!... Mia madre, da qui a cent'anni, non ha a chi lasciare tutto il suo.
Bianca cercava di scusarsi. - Suo marito era il padrone. Faceva tutto di testa propria, lui. Non voleva che gli mettessero il naso nelle sue cose. - Allora perché sei sua moglie? - ribatté il cugino. - Bella ragione! Uno che non era degno di alzarti gli occhi in viso!... Deve ringraziare Iddio e l'ostinazione di mia madre se gli è toccata questa fortuna!... Dunque farai il possibile per indurlo ad accordarmi questa dilazione?
- E tu cosa gli hai detto? - domandò don Gesualdo trovando la moglie ancora agitata dopo quella visita.
- Nulla... Non so... Mi son sentita male...
- Bene. Hai fatto bene. Sta tranquilla che agli affari ci penso io. Serpi nella manica sono i parenti... Hai visto? Cercano di te, solo quando ne hanno bisogno; ma del resto non gli importa di sapere se sei morta o viva. Lascia fare a me che la risposta gliela mando coll'usciere, a tuo cugino...
Così era venuto quel matrimonio, ché il barone Rubiera prima aveva messo sottosopra cielo e terra per trovare i denari da pagare don Gesualdo; e infine donna Giuseppina Alòsi, la quale aveva delle belle terre al sole, aveva dato l'ipoteca. Don Gesualdo, ottenuta la sua brava iscrizione sulle terre, non parlò più di aver bisogno del denaro.
- Col tempo... - confidò alla moglie. - Lasciali tranquilli. Loro non pagano né frutti né capitali, e col tempo quelle terre serviranno per la dote d'Isabella. Che te ne pare? Non è da ridere? Lo zio Rubiera che pensa a mettere insieme la dote della tua figliuola!...
Egli aveva di queste uscite buffe alle volte, da solo a solo con sua moglie, quando era contento della sua giornata, prima di coricarsi, mettendosi il berretto da notte, in maniche di camicia. A quattr'occhi con lei mostravasi proprio quel che era, bonaccione, colla risata larga che mostrava i denti grossi e bianchi, passandosi anche la lingua sulle labbra, quasi gustasse già il dolce del boccone buono, da uomo ghiotto della roba.
Isabella fatta più grandicella passò dal Collegio di Maria al primo educatorio di Palermo. Un altro strappo per la povera mamma che temeva di non doverla più rivedere. Il marito, onde confortarla, in quello stato, le disse: - Vedi noi ci ammazziamo per fare il suo meglio, ciascuno come può, ed essa un giorno non penserà neppure a noi. Così va il mondo. Anzi devi metterti in testa che tua figlia non puoi averla sempre vicina. Quando si marita anderà via dal paese. Qui non ce n'è uno che possa sposarla, colla dote che le darò. Se ho fatto tanto per lei, voglio almeno sapere a chi lo dò il sangue mio. Adesso che ti parlo è già nato chi deve godersi il frutto delle mie fatiche, senza dirmi neppure grazie.
Aveva il cuore grosso anche lui, poveraccio, e se sfogavasi a quattr'occhi colla moglie alle volte, per discorrere non si rifiutava però a fare ciò ch'era debito suo. Andava a trovare la sua ragazza a Palermo, quando poteva, quando i suoi affari lo permettevano, anche una volta all'anno. Isabella s'era fatta una bella fanciulla, un po' gracile ancora, pallidina, ma con una grazia naturale in tutta la personcina gentile, la carnagione delicata e il profilo aquilino dei Trao; un fiore di un'altra pianta, in poche parole; roba fine di signori che suo padre stesso quando andava a trovarla provava una certa suggezione dinanzi alla ragazza la quale aveva preso l'aria delle compagne in mezzo a cui era stata educata, tutte delle prime famiglie, ciascuna che portava nell'educandato l'alterigia baronale da ogni angolo della Sicilia. Al parlatorio lo chiamavano il signor Trao. Quando volle saperne il perché, Isabella si fece rossa. La stessa storia del Collegio di Maria anche lì. E la sua figliuola aveva dovuto soffrire le stesse umiliazioni a motivo del parentado. Per fortuna la signorina di Leyra, che Isabella s'era affezionata coi regalucci, aveva preso a difenderla a spada tratta. Essa conosceva di nome la famiglia dei Trao, una delle prime laggiù, ove il duca suo fratello possedeva dei feudi. La duchessina aveva il nome e il parlare alto, sebbene stesse in collegio senza pagare, talché le compagne lasciarono passare il Trao. Ma don Gesualdo dovette lasciarlo passare anche lui, e farsi chiamare così, per amore della figliuola, quando andava a trovarla. - Vedrai come si è fatta bella la tua figliuola! - tornava poi a dire alla moglie che era sempre malaticcia.
Essa la rivide finalmente all'uscire del collegio, nel 1837, quando in Palermo cominciavano già a correre le prime voci di colèra, e don Gesualdo era corso subito a prenderla. Fu come un urto al petto per la povera madre, dopo tanto tempo, quando udì fermarsi la lettiga dinanzi al portone. - Figlia mia! figlia mia! - colle braccia stese, le gambe malferme, precipitandosi per la scala. Isabella saliva correndo, colle braccia aperte anche lei. - Mamma! mamma! - E poi avvinghiate l'una al collo dell'altra, la madre sballottando ancora a destra e a sinistra la sua creatura come quand'era piccina.
Indi vennero le visite ai parenti. Bianca era tornata in forze per portare in trionfo la sua figliuola, in casa Sganci in casa Limòli, da per tutto dove era stata bambinetta, prima d'entrare in collegio, ora già fatta grande, col cappellino di paglia, le belle treccie bionde - un fiore. Tutti si affacciavano per vederla passare. La zia Sganci, divenuta sorda e cieca, le tastò il viso per riconoscerla: - Una Trao! Non c'è che dire. - Lo zio marchese ne lodò gli occhi, degli occhi blù che erano due stelle. "Degli occhi che vedevano il peccato", disse il marchese, il quale aveva sempre pronta la barzelletta. Allorché la condussero dallo zio don Ferdinando, Isabella che soleva spesso rammentare colle compagne la casa materna, negli sfoghi ingenui d'ambizione, provò un senso di sorpresa, di tristezza, di delusione al rivederla. Entrava chi voleva dal portone sconquassato. La corte era angusta, ingombra di sassi e di macerie. Si arrivava per un sentieruolo fra le ortiche allo scalone sdentato, barcollante, soffocato anch'esso dalle erbacce. In cima l'uscio cadente era appena chiuso da un saliscendi arrugginito; e subito nell'entrare colpiva una zaffata d'aria umida e greve, un tanfo di muffa e di cantina che saliva dal pavimento istoriato col blasone, seminato di cocci e di rottami, pioveva dalla vòlta scalcinata, veniva densa dal corridoio nero al pari di un sotterraneo, dalle sale buie che s'intravedevano in lunga fila, abbandonate e nude, per le strisce di luce che trapelavano dalle finestre sgangherate. In fondo era la cameretta dello zio, sordida, affumicata, col soffitto sconnesso e cadente, e l'ombra di don Ferdinando che andava e veniva silenzioso, simile a un fantasma.
- Chi è?... Grazia... entra...
Don Ferdinando apparve sulla soglia, in maniche di camicia, giallo ed allampanato, guardando stupefatto attraverso gli occhiali la sorella e la nipote. Sul lettuccio disfatto c'era ancora la vecchia palandrana di don Diego che stava rattoppando. L'avvolse in fretta, insieme a un fagotto d'altri cenci, e la cacciò nel cassettone.
- Ah!... sei tu, Bianca?... che vuoi?...
Indi accorgendosi che teneva ancora l'ago in mano, se lo mise in tasca, vergognoso, sempre con quel gesto che sembrava meccanico.
- Ecco vostra nipote... - balbettò la sorella con un tremito nella voce. - Isabella... vi rammentate?... E' stata in collegio a Palermo...
Egli fissò sulla ragazza quegli occhi azzurri e stralunati che fuggivano, di qua e di là , e mormorò:
- Ah!... Isabella?... mia nipote?...
Guardava inquieto per la stanza, e di tanto in tanto, come vedeva un oggetto dimenticato sul tavolino o sulla seggiola zoppa, del refe sudicio, un fazzoletto di cotone posto ad asciugare al sole, correva subito a nasconderli. Poi si mise a sedere sulla sponda del lettuccio, fissando l'uscio. Mentre Bianca parlava, col cuore stretto, egli seguitava a volgere intorno gli occhi sospettosi, pensando a tutt'altro. A un tratto andò a chiudere a chiave il cassetto della scrivania.
- Ah!... mia nipote, dici?...
Fissò di nuovo sulla giovinetta lo stesso sguardo esitante, e chinò gli occhi a terra.
- Somiglia a te... tale e quale... quand'eri qui...
Sembrava che cercasse le parole, cogli occhi erranti evitando quelli della sorella e della nipote, con un tremito leggiero nelle mani, il viso smorto e istupidito. Un istante, mentre Bianca gli parlava all'orecchio, supplichevole, quasi le spuntassero le lagrime, egli di curvo che era si raddrizzò così che parve altissimo, con un'ombra negli occhi chiari un rimasuglio del sangue dei Trao che gli colorava il viso scialbo.
- No... no... Non voglio nulla... Non ho bisogno di nulla... Vattene ora, vattene... Vedi... ho tanto da fare...
Una cosa che stringeva il cuore. Una rovina ed un'angustia che umiliavano le memorie ambiziose, le fantasie romantiche nate nelle confidenze immaginarie colle amiche del collegio, le illusioni di cui era piena la bizzarra testolina della fanciulla, tornata in paese coll'idea di rappresentarvi la prima parte. Il lusso meschino della zia Sganci, la sua casa medesima fredda e malinconica, il palazzo cadente dei Trao che aveva spesso rammentato laggiù con infantile orgoglio, tutto adesso impicciolivasi, diventava nero, povero, triste. Lì, dirimpetto, era la terrazza dei Margarone, che tante volte aveva rammentato vasta, inondata di sole, tutta fiorita, piena di ragazze allegre che la sbalordivano allora, bambina, collo sfoggi...
[Pagina successiva]