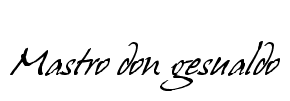[Pagina precedente]...o, si rodeva in silenzio; non osava ribellarsi al cognato e alla sorella; pensava ai suoi guai. Ci aveva un cane, lì nella pancia, che gli mangiava il fegato, il cane arrabbiato di San Vito martire, che lo martirizzava anche lui. Inutilmente Speranza, amorevole, cercava erbe e medicine, consultava Zanni e persone che avevano segreti per tutti i mali. Ciascuno portava un rimedio nuovo, dei decotti, degli unguenti, fino la reliquia e l'immagine benedetta del santo, che don Luca volle provare colle sue mani. Non giovava nulla. L'infermo badava a ripetere:
- Non è niente... un po' di colica. Ho avuto dei dispiaceri. Domani mi alzerò...
Ma non ci credeva più neppur lui, e non si alzava mai. Era ridotto quasi uno scheletro, pelle e ossa; soltanto il ventre era gonfio come un otre. Nel paese si sparse la voce che era spacciato: la mano di Dio che l'agguantava e l'affogava nelle ricchezze. Il signor genero scrisse da Palermo onde avere notizie precise. Parlava anche d'affari da regolare, e di scadenze urgenti. Nella poscritta c'erano due righe sconsolate d'Isabella, la quale non si era ancora riavuta dal gran colpo che aveva ricevuto poco prima. Speranza, che era presente mentre il fratello s'inteneriva sulla lettera, sputò fuori il veleno:
- Ecco! Ora vi guastate il sangue, per giunta! Potreste andarvene all'altro mondo... solo e abbandonato, come uno che non ha nè possiede!... Chi vi siete trovato accanto nel bisogno, ditelo? Vostra figlia vi manda soltanto belle parole... Suo marito però va al sodo!
Don Gesualdo non rispose. Ma di nascosto, rivolto verso il muro, si mise a piangere cheto cheto. Sembrava diventato un bambino. Non si riconosceva più. Allorchè Diodata, sentendo ch'era tanto malato, volle andare a visitarlo e a chiedergli perdono per la mancanza che gli avevano fatto i suoi ragazzi, la notte della sommossa, rimase di stucco al vederlo così disfatto, che puzzava di sepoltura, e gli occhi che a ogni faccia nuova diventavano lustri lustri.
- Signor don Gesualdo... son venuta a vedervi perché mi hanno detto che siete in questo stato... Dovete perdonare... a quegli screanzati che vi hanno offeso... Ragazzi senza giudizio... Si son lasciati prendere in mezzo, senza sapere quello che facessero... Dovete perdonare per amor mio, signor don Gesualdo!...
E si vedeva che parlava sincera, la poveretta, con quel viso, mandando giù, per nasconderle, le lagrime che a ogni parola le tornavano agli occhi, cercando di pigliargli la mano per baciargliela. Egli faceva un gesto vago, e scuoteva il capo, come a dire che non gliene importava, oramai. In quella sopravvenne Speranza, e fece una partaccia a quella sfacciata che veniva a tentarle il fratello in fin di vita, per cavargli qualcosa, per pelarlo sino all'ultimo. Una sanguisuga. Ci s'era ingrassata alle spalle di lui! Non le bastava? Ora calavano i corvi, all'odor del carname. Il malato chiudeva gli occhi per sfuggire quel supplizio, e agitavasi nel letto come al sopraggiungere di un'altra colica. Talché Diodata se ne andò senza poterlo salutare, a capo chino, stringendosi nella mantellina. Speranza tornò al fratello, tutta amorevole e sorridente.
- Per assistervi adesso ci avete qui noi... Non vi lasceremo solo, non temete,.. Tutto ciò che avete bisogno... Comandate. Che ne fareste adesso di quella strega? Vi mangerebbe anima e corpo. Neanche il viatico potreste ricevere, con quello scandalo in casa!
Lei lo assisteva meglio di una serva, e lo curava con amore, senza guardare a spesa né a fatiche. Vedendo che nulla giovava, arrivò a chiamare il figlio di Tavuso, il quale tornava fresco fresco da Napoli, laureato in medicina, - un ragazzotto che non aveva ancora peli al mento e si faceva pagare come un principe. - Però don Gesualdo gli disse il fatto suo, al vedergli metter mano alla penna per scrivere le solite imposture:
- Don Margheritino, io vi ho visto nascere! A me scrivete la ricetta? Per chi mi pigliate, amico caro!
- Allora, - ribattè il dottorino infuriato, - allora fatevi curare dal maniscalco! Perché mi avete fatto chiamare? - Prese il cappello, e se ne andò.
Ma siccome il malato soffriva tutti i tormenti dell'inferno, nella lusinga che qualcheduno trovasse il rimedio che ci voleva, per non far parlare anche i vicini che li accusavano di avarizia, dovettero chinare il capo a codesto, chinare il capo a medici e medicamenti. Il figlio di Tavuso, Bomma quanti barbassori c'erano in paese, tutti sfilarono dinanzi al letto di don Gesualdo. Arrivavano, guardavano, tastavano, scambiavano fra di loro certe parolacce turche che facevano accapponar la pelle, e lasciavano detto ciascuno la sua su di un pezzo di carta - degli sgorbi come sanguisughe. Don Gesualdo, sbigottito, non diceva nulla, cercava di cogliere le parole a volo; guardava sospettoso le mani che scrivevano. Soltanto, per non buttare via il denaro malamente, prima di spedire la ricetta, prese a parte don Margheritino, e gli fece osservare che aveva un armadio pieno di vasetti e boccettine, comperati per la buon'anima di sua moglie. - Non ho guardato a spesa, signor dottore. Li ho ancora lì, tali e quali. Se vi pare che possano giovare adesso...
Non gli davano retta neppur quando tornava a balbettare, spaventato da quelle facce serie: - Mi sento meglio. Domani mi alzo. Mandatemi in campagna che guarirò in ventiquattr'ore. - Gli dicevano di sì, per contentarlo, come a un bambino. - Domani, doman l'altro. - Ma lo tenevano lì, per smungerlo, per succhiargli il sangue, medici, parenti e speziali. Lo voltavano, lo rivoltavano, gli picchiavano sul ventre con due dita, gli facevano bere mille porcherie, lo ungevano di certa roba che gli apriva dei vescicanti sullo stomaco. C'era di nuovo sul cassettone un arsenale di rimedi, come negli ultimi giorni di Bianca, buon'anima. Egli borbottava, tentennando il capo. - Siamo già ai medicamenti che costano cari! Vuol dire che non c'è più rimedio. - Il denaro a fiumi, un va e vieni, una baraonda per la casa, tavola imbandita da mattina a sera. Burgio, che non c'era avvezzo, correva a mostrare la lingua ai medici, come venivano pel cognato; Santo non usciva più nemmeno per andare all'osteria; e i nipoti, quando tornavano dai poderi, si pigliavano pei capelli: liti e quistioni fra di loro che facevano a chi più arraffa, degli strepiti che arrivavano fin nella camera dell'infermo, il quale tendeva l'orecchio, smanioso di sapere quello che facevano della sua roba, e anche lui si metteva a strillare dal letto:
- Lasciatemi andare a Mangalavite. Ci ho tutti i miei interessi alla malora. Qui mi mangio il fegato. Lasciatemi andare, se no crepo!
Ci aveva come una palla di piombo nello stomaco, che gli pesava, voleva uscir fuori, con un senso di pena continuo; di tratto in tratto, si contraeva, s'arroventava e martellava, e gli balzava alla gola, e lo faceva urlare come un dannato, e gli faceva mordere tutto ciò che capitava. Egli rimaneva sfinito, anelante, col terrore vago di un altro accesso negli occhi stralunati. Tutto ciò che ingoiava per forza, per aggrapparsi alla vita, i bocconi più rari, senza chiedere quel che costassero, gli si mutavano in veleno; tornava a rigettarli come roba scomunicata, più nera dell'inchiostro, amara, maledetta da Dio. E intanto i dolori e la gonfiezza crescevano: una pancia che le gambe non la reggevano più. Bomma, picchiandovi sopra, una volta disse: - Qui c'è roba.
- Che volete dire, vossignoria? - balbettò don Gesualdo, balzando a sedere sul letto, coi sudori freddi addosso.
Bomma lo guardò bene in faccia, accostò la seggiola, si voltò di qua e di là per vedere s'erano soli.
- Don Gesualdo, siete un uomo... Non siete più un ragazzo, eh?
- Sissignore, - rispose lui con voce ferma, calmatosi a un tratto, col coraggio che aveva sempre avuto al bisogno. - Sissignore, parlate.
- Bene, qui ci vuole un consulto. Non avete mica una spina di fico d'India nel ventre! E' un affare serio, capite! Non è cosa per la barba di don Margheritino o di qualcun altro... sia detto senza offenderli, qui in confidenza. Chiamate i migliori medici forestieri, don Vincenzo Capra, il dottor Muscio di Caltagirone, chi volete... Denari non ve ne mancano...
A quelle parole don Gesualdo montò in furia: - I denari!... Vi stanno a tutti sugli occhi i denari che ho guadagnato!... A che mi servono... se non posso comprare neanche la salute?... Tanti bocconi amari m'hanno dato... sempre!...
Ma però volle stare a sentire la conclusione del discorso di Bomma. Alle volte non si sa mai... Lo lasciò finire, stando zitto, tenendosi il mento, pensando ai casi suoi. Infine volle sapere:
- Il consulto? Che mi fa il consulto?
Bomma perse le staffe: - Che vi fa? Caspita! Quello che vi può fare... Almeno non si dirà che vi lasciate morire senza aiuto. Io parlo nel vostro interesse. Non me ne viene nulla in tasca... Io fo lo speziale... Non è affar mio... Non me ne intendo. Vi ho curato per amicizia... - Come l'altro tentennava il capo, diffidente, col sorriso furbo sulle labbra smorte, il farmacista mise da banda ogni riguardo. - Morto siete, don minchione! A voi dico!
Allora don Gesualdo volse un'occhiata lenta e tenace in giro, si soffiò il naso, e si lasciò andar giù sul letto supino. Di lì a un po', guardando il soffitto, aggiunse con un sospiro:
- Va bene. Facciamo il consulto.
La notte non chiuse occhio. Tormentato da un'ansietà nuova, con dei brividi che lo assalivano di tratto in tratto, dei sudori freddi, delle inquietudini che lo facevano rizzare all'improvviso sul letto coi capelli irti, guardando intorno nelle tenebre, vedendo sempre la faccia minacciosa di Bomma, tastandosi, soffocando i dolori, cercando d'illudersi. Parevagli di sentirsi meglio infatti. Voleva curarsi, giacché era un affar serio. Voleva guarire. Ripeteva le parole stesse dello speziale: denari ne aveva; s'era logorata la vita apposta; non li aveva guadagnati per far la barba al signor genero; perché se li godessero degli ingrati che lo lasciavano crepare lontano: Lontano dagli occhi, lontan dal cuore! Il mondo è fatto così, che ciascuno tira l'acqua al suo mulino. Il mulino suo, di lui, era di riacquistare la salute, coi suoi denari. C'erano al mondo dei buoni medici che l'avrebbero fatto guarire, pagandoli bene. Allora asciugavasi quel sudore d'agonia, e cercava di dormire. Voleva che i medici forestieri che aspettava il giorno dopo gli trovassero miglior cera; contava le ore; gli pareva mill'anni che fossero lì dinanzi al suo letto. La stessa luce dell'alba gli faceva animo. Poi, allorché udì le campanelle della lettiga che portava il Muscio e don Vincenzo Capra si sentì slargare il cuore tanto fatto. Si tirò su svelto a sedere sul letto come uno che si senta proprio meglio. Salutò quella brava gente con un bel sorriso che doveva rassicurare anche loro, appena li vide entrare.
Essi invece gli badarono appena. Erano tutti orecchi per don Margheritino che narrava la storia della malattia con gran prosopopea; approvavano coi cenni del capo di tanto in tanto; volgevano solo qualche occhiata distratta sull'ammalato che andavasi scomponendo in volto, alla vista di quelle facce serie, al torcer dei musi, alla lunga cicalata del mediconzolo che sembrava recitasse l'orazione funebre. Dopo che colui ebbe terminato di ciarlare s'alzarono l'uno dopo l'altro, e tornarono a palpare e a interrogare il malato, scrollando il capo, con certo ammiccare sentenzioso, certe occhiate fra di loro che vi mozzavano il fiato addirittura. Ce n'era uno specialmente, dei forestieri, che stava accigliato e pensieroso, e faceva a ogni momento uhm! uhm! senza aprir bocca. I parenti, la gente di casa, dei vicini anche, per curiosità , si affollavano all'uscio, aspettando la sentenza, mentre i dottori confabulavano a bassa voce fra di loro in un canto. A un cenno dello speziale, Burgio e sua moglie andarono a sentire anch'essi, in punta di piedi.
- Parlate, signori miei! - esclamò allora il pover'uomo pallido come un morto. - Sono io il malato, infine! Voglio sapere a che punto sono.
Il Muscio abbozzò un ...
[Pagina successiva]