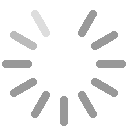[Pagina precedente]...ate chi sa come dalle mille bocche del Serraglio, tutta la città parlava, e forse fin d'allora s'andavano raccogliendo le prime fila della congiura che lo rovesciò dal trono due anni dopo. La sua caduta, come dicono i Musulmani, era già scritta, e con essa la sentenza che fu poi pronunziata sopra di lui e sopra il suo regno. La quale non è molto diversa da quella che si potrebbe dare su quasi tutti i Sultani degli ultimi tempi. Principi imperiali, spinti verso la civiltà europea da un'educazione superficiale, ma varia e libera, e dal fervore della giovinezza desiderosa di novità e di gloria, vagheggiano, prima di salire sul trono, grandi disegni di riforme e di rinnovamenti, e fanno il proposito fermo e sincero di dedicare a quel fine tutta la loro vita, che dovrà essere una vita austera di lavoro e di lotta. Ma dopo qualche anno di regno e di lotte inutili, circondati da mille oracoli, inceppati da tradizioni e da consuetudini avversati dagli uomini e dalle cose, spaventati dalla grandezza non prima misurata dell'impresa, se ne sdanno sfiduciati, per domandare ai piaceri quello che non possono avere dalla gloria, e perdono a poco a poco, in una vita tutta sensuale, perfino la memoria dei primi propositi e la coscienza del loro avvilimento. Così accade che al sorgere d'ogni nuovo Sultano si faccia sempre, e non senza fondamento, un pronostico felice a cui segue sempre un disinganno.
Abdul-Aziz non si fece aspettare. All'ora fissata, s'udì uno squillo di tromba, la banda intonò una marcia di guerra, i soldati presentarono le armi, un drappello di lancieri uscì improvvisamente dalla porta del palazzo, e si vide apparire il Sultano a cavallo, che venne innanzi lentamente, seguito dal suo corteo.
Mi passò dinanzi a pochi passi, ed ebbi tutto il tempo di considerarlo attentamente.
La mia immaginazione fu stranamente delusa.
Il re dei re, il sultano scialacquatore, violento, capriccioso, imperioso, - che era allora sui quarantaquattr'anni, - aveva l'aspetto di una buonissima pasta di turco, che si trovasse a fare il sultano senza saperlo. Era un uomo tarchiato e grasso, un bel faccione con due grandi occhi sereni e una barba intera e corta, già un po' brizzolata di bianco; aveva una fisonomia aperta e mansueta, un atteggiamento naturalissimo, quasi trascurato; e uno sguardo quieto e lento in cui non appariva la minima preoccupazione dei mille sguardi che gli erano addosso. Montava un cavallo grigio bardato d'oro, di bellissime forme, tenuto per le briglie da due palafrenieri sfolgoranti. Il corteo lo seguiva a grande distanza, e da questo solo si poteva capire che era il Sultano. Il suo vestimento era modestissimo. Aveva un semplice fez, un lungo soprabito di color scuro abbottonato fin sotto il mento, un paio di calzoni chiari e gli stivali di marocchino. Veniva innanzi lentissimamente, guardando intorno con un'espressione tra benevola e stanca, come se volesse dire agli spettatori: - Ah! se sapeste come mi secco! - I musulmani s'inchinavano profondamente; molti europei si levavano il cappello: egli non restituì il saluto a nessuno. Passando dinanzi a noi, diede uno sguardo a un ufficiale d'alta statura che lo salutava colla sciabola, un altro sguardo al Bosforo, e poi uno sguardo più lungo a due giovani signore inglesi che lo guardavano da una carrozza, e che si fecero rosse come due fragole. Osservai che aveva la mano bianca e ben fatta, ed era appunto la mano destra, colla quale, due anni dopo, si aperse le vene nel bagno. Dietro di lui passò uno stuolo di pascià, di cortigiani, di pezzi grossi, a cavallo; quasi tutti omaccioni con gran barbe nere, vestiti senza pompa, silenziosi, gravi, cupi, come se accompagnassero un convoglio funebre; dopo, un drappello di palafrenieri che conducevano a mano dei cavalli superbi; poi uno stuolo d'ufficiali a piedi col petto coperto di cordoni d'oro; passati i quali, i soldati abbassarono le armi, la folla si sparpagliò per la piazza, ed io rimasi là immobile, cogli occhi fissi sulla cima del monte Bulgurlù, pensando alla singolarissima condizione in cui si trova un sultano di Stambul.
È un monarca maomettano, pensavo, e ha la reggia ai piedi di una città cristiana, Pera, che gli torreggia sul capo. È sovrano assoluto d'uno dei più vasti imperi del mondo, e ci sono nella sua metropoli, poco lontano da lui, dentro ai grandi palazzi che sovrastano al suo Serraglio, quattro o cinque stranieri cerimoniosi che la fanno da padroni in casa sua, e che trattando con lui, nascondono sotto un linguaggio reverente una minaccia perpetua che lo fa tremare. Ha nelle mani un potere smisurato, gli averi e la vita di milioni di sudditi, il mezzo di soddisfare i suoi più pazzi desiderii, e non può cambiare la forma della sua copertura di capo. È circondato da un esercito di cortigiani e di guardie, che bacerebbero l'orma dei suoi piedi, e trema continuamente per la propria vita e per quella dei suoi figliuoli. Possiede mille donne fra le più belle donne della terra, ed egli solo, tra tutti i musulmani del suo impero, non può dare la mano di sposo a una donna libera, non può aver che figli di schiave, ed è chiamato egli stesso: - Figlio di schiava, - da quello stesso popolo che lo chiama "ombra di Dio". Il suo nome suona riverito e terribile dagli ultimi confini della Tartaria agli ultimi confini del Maghreb, e nella sua stessa metropoli v'è un popolo innumerevole, e sempre crescente, su cui non ha ombra di potere e che si ride di lui, della sua forza e della sua fede. Su tutta la faccia del suo immenso impero, fra le tribù più miserabili delle provincie più lontane, nelle moschee e nei conventi più solitarii delle terre più selvaggie, si prega ardentemente per la sua vita e per la sua gloria; ed egli non può fare un passo nei suoi stati, senza trovarsi in mezzo a nemici che lo esecrano e che invocano sul suo capo la vendetta di Dio. Per tutta la parte del mondo che si stende dinanzi alla sua reggia, egli è uno dei più augusti e più formidabili monarchi dell'universo; per quella che gli si stende alle spalle, è il più debole, il più pusillo, il più miserevole uomo che porti una corona sul capo. Una corrente enorme d'idee, di volontà, di forze contrarie alla natura e alle tradizioni della sua potenza, lo avvolge, lo soverchia, trasforma sotto di lui, intorno a lui, suo malgrado, senza che se n'avveda, consuetudini, leggi, usi, credenze, uomini, ogni cosa. Ed egli è là, tra l'Europa e l'Asia, nel suo smisurato palazzo bagnato dal mare, come in una nave pronta a far vela, in mezzo a una confusione infinita d'idee e di cose, circondato d'un fasto favoloso e d'una miseria immensa, già non più nè due nè uno, non più vero musulmano, non ancora vero europeo, regnante sopra un popolo già in parte mutato, barbaro di sangue, civile d'aspetto, bifronte come Giano, servito come un nume, sorvegliato come uno schiavo, adorato, insidiato, accecato, e intanto ogni giorno che passa spegne un raggio della sua aureola e stacca una pietra dal suo piedestallo. A me pare che se fossi in lui, stanco di quella condizione così singolare nel mondo, sazio di piaceri, stomacato d'adulazioni, affranco dai sospetti, indignato di quella sovranità malsicura ed oziosa sopra quel disordine senza nome, qualche volta, nell'ora in cui l'enorme Serraglio è immerso nel sonno, mi butterei a nuoto nel Bosforo come un galeotto fuggitivo, e andrei a passar la notte in una taverna di Galata in mezzo a una brigata di marinai, con un bicchiere di birra in mano e una pipa di gesso fra i denti, urlando la marsigliese.
Dopo una mezz'ora, il Sultano ripassò rapidamente in carrozza chiusa, seguito da un drappello d'ufficiali a piedi, e lo spettacolo fu finito. Di tutto, quello che mi fece un senso più vivo, furono quegli ufficiali in grande uniforme, che correvano saltellando, come una frotta di lacchè, dietro la carrozza imperiale. Non vidi mai una prostituzione simile della divisa militare.
Questo spettacolo del passaggio del Sultano, è ora, come si vede, una cosa assai meschina. I sultani d'altri tempi uscivano in gran pompa, preceduti e seguiti da un nuvolo di cavalieri, di schiavi, di guardie dei giardini, d'eunuchi, di ciambellani, che visti di lontano, presentavano l'aspetto, come dicevano i cronisti entusiastici, "d'una vasta aiuola di tulipani." I sultani d'oggi invece par che rifuggano dalle pompe come da un'ostentazione teatrale della grandezza perduta. Io mi domando sovente che cosa direbbe uno di quei primi monarchi se, risorgendo per un momento dal suo sepolcro di Brussa o dal suo turbè di Stambul, vedesse passare uno di questi suoi nepoti del secolo diciannovesimo, insaccato in un soprabito nero, senza turbante, senza spada, senza gemme, in mezzo a una folla di stranieri insolenti. Io credo che arrossirebbe di rabbia e di vergogna, e che in segno di supremo disprezzo gli farebbe, come Solimano I ad Hassan, tagliare la barba a colpi di scimitarra, che è la più crudele ingiuria che si passa fare a un osmano. E veramente, fra i sultani d'ora e quei primi, i cui nomi risonarono in Europa tra il secolo XII e il XVI come scoppi di folgore, corre la stessa differenza che tra l'impero ottomano dei nostri giorni e quello dei primi secoli. Quelli raccoglievano davvero in sè la gioventù, la bellezza e il vigore della loro razza; e non erano soltanto un'immagine vivente del proprio popolo, una bella insegna, una perla preziosa della spada dell'islamismo; ma ne costituivano per sè soli una vera forza, e tale, che non c'è chi possa disconoscere nelle loro qualità personali una delle cagioni più efficaci del meraviglioso incremento della potenza ottomana. Il più bel periodo è quello della prima giovinezza della dinastia che abbraccia centonovantatrè anni da Osmano a Maometto II. Quella fu davvero una catena di principi fortissimi, e fatta una sola eccezione, e tenuto conto dei tempi e delle condizioni della razza, austeri e saggi e amati dai propri sudditi; spesso feroci, ma di rado ingiusti, e sovente anche generosi e benefici verso i nemici; e tutti poi quali si capisce che dovessero essere dei principi di quella gente, belli e tremendi d'aspetto, leoni veri, come le loro madri li chiamavano "di cui il ruggito faceva tremare la terra." Gli Abdul-Megid, gli Abdul-Aziz, i Murad, gli Hamid non sono che larve di padiscià in confronto di quei giovani formidabili, figli di madri di quindici e di padri di diciott'anni, nati dal fiore del sangue tartaro e dal fiore della bellezza greca, persiana, caucasea. A quattordici anni comandavano eserciti e governavano provincie, e ricevevano in premio dalle proprie madri delle schiave belle ed ardenti come loro. A sedici anni erano già padri, a settanta lo diventavano ancora. Ma l'amore non infiacchiva in loro la tempra gagliardissima dell'animo e delle membra. L'animo era di ferro, dicevano i poeti, e il corpo era d'acciaio. Avevano tutti certi tratti comuni, che si perdettero poi nei loro nepoti degeneri: la fronte alta, le sopracciglia arcate e riunite come quelle dei persiani, gli occhi azzurrini dei figli delle steppe, il naso che si curvava sulla bocca purpurea "come il becco d'un pappagallo sopra una ciliegia" e foltissime barbe nere, per le quali i poeti del serraglio si stillavano a cercar paragoni gentili o terribili. Avevano "lo sguardo dell'aquila di monte Tauro e la forza del re del deserto; colli di toro, larghissime spalle, petti sporgenti che poteva contenere tutta l'ira guerriera dei loro popoli", braccia lunghissime, articolazioni colossali, gambe corte ed arcate, che facevano nitrir di dolore i più vigorosi cavalli turcomanni, e grandi mani irsute che palleggiavano come canne le mazze e gli archi enormi dei loro soldati di bronzo. E portavano dei soprannomi degni di loro: il lottatore, il campione, la folgore, lo stritolatore d'ossa, lo spargitore di sangue. La guerra era dopo Allà il primo dei loro pensieri, e la morte era l'ultimo. Non avevano il genio dei grandi capitani, ma erano dotati tutti di quella prontezza di risoluzione che quasi sempre vi su...
[Pagina successiva]