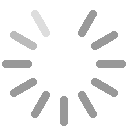[Pagina precedente]... quale, lungo la riva del Bosforo, s'innalza il palazzo famoso dove risiedono i Sultani.
È la più grande mole di marmo che riflettano le acque dello stretto dalla collina del Serraglio alle bocche del Mar Nero, e non si abbraccia tutta con uno sguardo che passandovi davanti in caicco. La facciata, che si stende per la lunghezza di circa un mezzo miglio italiano, è rivolta verso l'Asia, e si vede biancheggiare a una grande distanza fra l'azzurro del mare e il verde cupo delle colline della riva. Non è propriamente un palazzo perchè non c'è un unico concetto architettonico; le varie parti sono slegate e vi si mescolano in una confusione non mai veduta lo stile arabo, il greco, il gotico, il turco, il romano, quello del nascimento; e colla maestà dei palazzi reali d'Europa, la grazia quasi femminea delle moresche di Siviglia e di Granata. Piuttosto che il "palazzo" si potrebbe chiamare "la città imperiale" come quella dell'Imperatore della China; e più che per la vastità, per la forma, pare che debba essere abitato, non da un solo monarca, ma da dieci re fratelli od amici, che vi passino il tempo fra gli ozi e i piaceri. Dalla parte del Bosforo presenta una serie di facciate di teatri o di templi, sulle quali v'è una profusione indescrivibile d'ornamenti, buttati via, come dice un poeta turco, dalle mani d'un pazzo; che rammentano quelle favolose pagode indiane, su cui l'occhio si stanca al primo sguardo, e sembrano l'immagine degli infiniti capricci amorosi e fastosi dei principi sfrenati che vivono tra quelle mura. Sono file di colonne doriche e ioniche, leggiere come aste di lancia; finestre inquadrate in cornici a festoni e in colonnine accannellate; archi pieni di fogliami e di fiori che s'incurvano su porte coperte di ricami; terrazze gentili coi parapetti scolpiti a giorno; trofei, rosoni, viticci; ghirlande che s'annodano e s'intrecciano, vezzi di marmo che s'affollano sui cornicioni, lungo le finestre, intorno a tutti i rilievi; una rete d'arabeschi che si stende dalle porte ai frontoni, una fioritura, uno sfarzo e una finezza di fregi e di gale architettoniche, che danno ad ognuno dei piccoli palazzi di cui è composto il grande edifizio multiforme, l'apparenza d'un prodigioso lavoro di cesellatura. Pare che non debba essere un tranquillo architetto armeno quello che n'ebbe il primo concetto; ma un sultano innamorato il quale l'abbia visto in sogno, dormendo tra le braccia della più ambiziosa delle sue amanti. Dinanzi si stende una fila di pilastri monumentali di marmo bianco, uniti da cancellate dorate, che rappresentano un intreccio delicatissimo di rami e di fiori, e che viste di lontano sembrano cortine di trina, che il vento debba portar via. Lunghe gradinate marmoree discendono dalle porte alla sponda e si nascondono nel mare. Tutto è bianco, fresco, nitido come se il palazzo fosse fatto d'ieri. L'occhio d'un artista ci potrà vedere mille errori d'armonia e di gusto; ma l'insieme di quella mole smisurata e ricchissima, il primo aspetto di quella schiera di reggie bianche come la neve, niellate come gioielli, coronate da quel verde, riflesse da quelle acque, lascia un'impressione di potenza, di mistero e d'amore, che fa quasi dimenticare la collina dell'antico Serraglio. Quelli che ebbero la fortuna di penetrare fra quelle mura, dicono che il di dentro corrisponde alla facciata: che son lunghe sfilate di sale dipinte a fresco di soggetti fantastici e di colori ridenti, con porte di cedro e d'acagiù scolpite e ornate d'oro, che s'aprono su interminabili corridoi rischiarati da una luce dolcissima, dai quali si va in altre sale colorate di foco da cupolette di cristallo porporino, e in stanze da bagno che sembrano scavate in un solo blocco di marmo di Paros; e di qui su terrazze aeree, che pendono sopra giardini misteriosi e sopra boschetti di cipressi e di rose, dai quali, per lunghe fughe di portici moreschi, si vede l'azzurro del mare; e finestre, terrazze, loggie, chioschetti, tutto ribocca di fiori, per tutto c'è acqua che schizza e ricasca in piogge vaporose sulla verzura e sui marmi, e da ogni parte s'aprono vedute divine sul Bosforo, di cui l'aria viva spande in tutti i recessi della reggia enorme un delizioso fresco marino.
Dalla parte di Funduclù v'è una porta monumentale, sopraccarica d'ornamenti; il Sultano doveva uscire da quella porta e attraversare la piazza.
Non c'è altro re sulla terra che abbia una così bella piazza per fare una uscita solenne dalla sua reggia. Stando ai piedi della collina, si vede da un lato la porta del palazzo, che sembra un arco di trionfo d'una regina; dall'altro la moschea graziosa di Abdul-Megid, fiancheggiata da due minareti gentili, in faccia, il Bosforo; di là, le colline dell'Asia, verdissime, picchiettate d'infiniti colori dai chioschi, dai palazzi, dalle moschee, dalle ville, che presentano l'aspetto d'una grande città parata a festa; più lontano, la maestà ridente di Scutari, colla sua corona funebre di cipressi; e fra le due rive, un incrociarsi continuo di legni a vela, di navi da guerra imbandierate, di vaporini affollati che paiono colmi di fiori, di bastimenti asiatici di forme antiche e bizzarre, di lancie del Serraglio, di barchette signorili, di stormi d'uccelli che radono le acque: una bellezza piena d'allegria e di vita, dinanzi alla quale lo straniero che aspetta l'uscita del corteo imperiale, non può che immaginare un Sultano bello come un angelo e sereno come un fanciullo.
Mezz'ora prima, v'erano già nella piazza due schiere di soldati vestiti alla zuava, che dovevano far ala al passaggio del Sultano, e un migliaio di curiosi. Non c'è nulla di più strano della raccolta di gente che si vede per il solito in quell'occasione. C'erano ferme qua e là parecchie splendide carrozze chiuse, con dentro delle turche "dell'alta signoria" guardate da giganteschi eunuchi a cavallo, immobili accanto gli sportelli; alcune signore inglesi in carrozze da nolo scoperte; varii crocchi di viaggiatori col cannocchiale a tracolla, fra i quali vidi il contino conquistatore dell'albergo di Bisanzio, venuto forse, il crudele! per fulminare d'uno sguardo di trionfo il suo rivale potente e infelice. Tra la folla giravano parecchie figure cappellute, con un album sotto il braccio, che mi parvero disegnatori venuti per schizzare furtivamente le sembianze imperiali. Vicino alla banda musicale c'era una bellissima signora francese, vestita un po' stranamente, d'aspetto e di atteggiamenti arditi, che stava dinanzi a tutti, che doveva essere un'avventuriera cosmopolitica venuta là per dar nell'occhio al Gran Signore, poichè le si leggeva sul viso "la trepida gioia d'un gran disegno". C'erano di quei vecchi turchi, sudditi fanatici e sospettosi, che non mancano mai al passaggio del loro Sultano, perchè vogliono proprio assicurarsi coi loro occhi che è vivo e sano per la gloria e la prosperità dell'universo; e il Sultano esce appunto ogni venerdì per dare al suo buon popolo una prova della propria esistenza, potendo accadere, come accadde più volte, che la sua morte naturale o violenta sia tenuta segreta da una congiura di corte. C'erano dei mendicanti, dei bellimbusti musulmani, degli eunuchi sfaccendati, dei dervis. Fra questi notai un vecchio alto e sparuto, dagli occhi terribili, immobile, che guardava verso la porta del palazzo con un'espressione sinistra; e pensai che aspettasse il Sultano per piantarglisi davanti e gridargli in faccia come il dervis delle Orientali al Pascià Alì di Tepeleni: - Tu non sei che un cane e un maledetto! - Ma di questi ardimenti sublimi non si dà più esempio dopo la sciabolata famosa di Mahmud. C'erano poi varii gruppi di donnine turche, in disparte, che parevano gruppi di maschere, e quella solita accozzaglia di comparse da palco scenico che è la folla di Costantinopoli. Tutte le teste si profilavano sull'azzurro del Bosforo, e probabilmente tutte le bocche dicevano le stesse parole.
Si cominciava a parlare appunto in quei giorni delle stravaganze d'Abdul Aziz. Già da un pezzo si parlava della sua insaziabile avidità di denaro. Il popolo diceva: - Mamhud avido di sangue, Abdul-Megid di donne, Abdul-Aziz d'oro. - Tutte le speranze che s'erano fondate su di lui, principe imperiale, quando, ammazzando un bue con un pugno, diceva: - Così ammazzerò la barbarie, - erano già svanite d'un pezzo. Le tendenze a una vita semplice e severa, di cui aveva dato prova nei primi anni del suo regno, amando, come si diceva, una donna sola, e ristringendo inesorabilmente le spese enormi del Serraglio, non erano più che una memoria. Forse erano anche anni ed anni che aveva smesso affatto quegli studi di legislazione, d'arte militare e di letteratura europea, di cui s'era fatto tanto scalpore, come se in essi riposassero tutte le speranze della rigenerazione dell'Impero. Da molto tempo non pensava più che a sè stesso. Ogni momento correva la voce di qualche sua escandescenza contro il ministro delle finanze che non voleva o non poteva dargli tutto il denaro ch'egli avrebbe voluto. Alla prima obbiezione scaraventava addosso alla malcapitata Eccellenza il primo oggetto che gli cadeva nelle mani, recitando per filo e per segno, con quanta voce aveva in gola, la formola antica del giuramento imperiale: per il Dio creatore del cielo e della terra, per il profeta Maometto, per le sette varianti del Corano, per i centoventiquattromila profeti di Dio, per l'anima di mio nonno e per l'anima di mio padre, per i miei figli e per la mia spada, portami del danaro o faccio piantare la tua testa sulla punta del più alto minareto di Stambul. E per un verso o per un altro veniva a capo di quel che voleva, e il danaro estorto in quella maniera, ora lo ammucchiava e se lo covava gelosamente come un avaro volgare, ora lo profondeva a piene mani in capricci puerili. Oggi era il capriccio dei leoni, domani delle tigri, e mandava incettatori nelle Indie e nell'Affrica; poi per un mese filato cinquecento pappagalli facevano risonare i giardini imperiali della stessa parola; poi gli pigliava il furore delle carrozze e dei pianoforti che voleva far sonare sorretti dalla schiena di quattro schiavi; poi la mania dei combattimenti dei galli, a cui assisteva con entusiasmo, e appendeva di sua mano una medaglia al collo dei vincitori, e cacciava in esilio, di là dal Bosforo, i vinti; poi la passione del gioco, dei chioschi, dei quadri; la corte pareva tornata ai tempi del primo Ibraim; ma il povero principe non trovava pace, non faceva che passare da una noja mortale a un'inquietudine tormentosa; era torbido e triste; pareva che presentisse la fine infelice che lo aspettava. A volte si ficcava nel capo di dover morire avvelenato, e per un pezzo, diffidando di tutti, non mangiava più che ova sode; altre volte, preso dal terrore degl'incendi, faceva togliere dalle sue stanze tutti gli oggetti di legno, persino le cornici degli specchi. In quel tempo appunto si diceva che, per paura del fuoco, leggesse di notte al lume d'una candela piantata in un secchio d'acqua. E malgrado queste follie, di cui si diceva che fosse la prima cagione una cagione che non c'è bisogno di dire, egli conservava tutta la forza imperiosa della volontà antica, e sapeva farsi obbedire e faceva tremare i più arditi. La sola persona che potesse sull'animo suo era sua madre, donna d'indole altera e vana, che nei primi anni del suo regno faceva coprire di tappeti di broccato le strade dove passava suo figlio per andare alla moschea, e il giorno dopo regalava tutti quei tappeti agli schiavi che li andavano a levare. Però, anche nel disordine della sua vita affannosa, fra l'uno e l'altro dei suoi grandi capricci, Abdul Aziz aveva pure dei capricci piccolissimi, come quello di volere sopra una data porta un dipinto a fresco di natura morta, con quei certi frutti e quei certi fiori, combinati in quella data maniera, e prescriveva accuratamente ogni cosa al pittore, e stava là lungo tempo a contare le pennellate, come se non avesse altro pensiero al mondo. Di tutte queste bizzarrie, frangi...
[Pagina successiva]