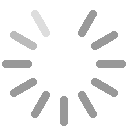[Pagina precedente]... da alte persone non viene esercitata, se non per proprio diletto; inoltre, le sue creazioni abbisognano pure d'esecutori, poichè quelle carte notate sono mute per se stesse, se a farle parlare non vengono gli strumenti. E la musica vocale, che dee pur preferirsi a tutte l'altre, le quali altro non sono che una imperfetta imitazione di essa, la musica vocale è schiava nata dello scrittore; ed anzi (come già era in Grecia per lo più) non si dovrebbe ella mai scompagnar dal poeta.
Si lascino dunque proteggere dai principi queste quattro arti, che per se stesse o sussistere non possono, o non abbastanza fiorire; e che, anzi, dalla protezione e dai premi ottengono incoraggimento e miglioramento, senza che all'artefice ne scemi punto la fama. Ma le alte e sacre lettere, sdegnino, abborriscano, e sfuggano ogni protezione, come a loro mortifera; poichè pur tanto debbono elle scapitarvi, e per se stesse, e per gli artefici loro.
I principi, senza avvedersi forse della vera ragion che li muove, ricompensano in fatti le arti, e le fanno anzi stromento della loro grandezza. Non possono dissimulare a se stessi, che una vasta e bene architettata reggia, in cui, fra l'oro e i ben ideati arredi, campeggino molti dipinti e statue sublimi, ella è la maggiore e la più nobile parte del loro essere. Ben sanno i principi, che la stoltezza del volgo reputa veramente grande colui che in mezzo a cose preziose e grandi si ricovera. Ma sfuggono essi bensì di proteggere, di ricompensare, e d'accogliere i veramente alti scrittori; perchè al confronto di questi, appariscono vie più sempre minori essi stessi. Se il tiranno Dionisio avesse albergato nella sua reggia Platone, chi avrebbe più badato a Dionisio?
E benchè la scultura e pittura con una certa maschia libertà e filosofia possano lumeggiare i più utili tratti della storia antica, e consecrare le più libere imprese, nulladimeno, come arti mute, elle vengono lasciate fare, e di esse poco si teme. Un principe non darà forse per tema a un pittore la morte di Lucrezia; ma pure ne ricompenserà l'autore, e ne collocherà il quadro nella sua reggia, ancorchè il gran Bruto col ferro in mano, e pieno di mal talento contra i tiranni, nel quadro primeggi. Ma quello scrittore, che sovra Bruto dicesse tutto ciò che l'eccellente pittore dee e vuole farne pensare, e che la maestà di un tanto uomo richiede, non sarebbe certamente, nè egli nè il suo libro, egualmente ricompensato ed accolto nella reggia. E ciò perchè? perchè assai più dicono sopra Bruto le poche parole di Livio, di quello che mai esprimerà o farà pensare un Bruto dipinto, o scolpito; e il fosse pur anco da Michelangelo stesso, il quale solo era degno di ritrarlo. E le parole di Livio son queste: Juro, nec illos, nec alium quemquam regnare Romae passurum.(3)
CAPITOLO SESTO.
CHE IL LUSTRO MOMENTANEO SI PUÒ OTTENERE PER VIA DEI POTENTI;
MA IL VERO ED ETERNO, DAL SOLO VALORE.
Io non saprei dar principio migliore a questo capitolo, che citando alcune parole di Tacito. Meditatio et labor in posterum valescit; canorum et profluens, cum ipso scriptore simul extinctum est.(4)
Non credo io, nè pretendo asserire ed espor cose nuove; benchè forse non siano state trattate finora con questo stesso ordine: anzi, a me pare, che i medesimi artefici, così delle lettere, come delle arti, le sappiano tutte, quanto e più di me. E così mi fo io a credere, perchè altro non si legge nelle loro vite, fuorchè ora gli uni per compiacere ai principi protettori li lodarono non gli stimando; ora gli altri ricevettero da essi il tema dei loro poemi, libri, o quadri; questi lasciarono guastare i proprj disegni di templi, di palazzi, di pubbliche moli, dal capriccio, dall'ignoranza e presunzione dei protettori, ordinatori, o pagatori di esse: e tutti si vedono, in somma, aver sempre maladetto l'ora e il momento e la necessità, (dicon essi) che gli avea condotti a impacciarsi con gente che nulla intendendo, e tutto potendo, assai più atta riesce ad atterrire che a consigliare altrui.
Da codeste loro stesse moltiplicate e giuste doglianze, io dunque ne ritraggo la certezza, che gli uomini per lo più, anche riflettendo, e conoscendo, e palpando la vera cagione delle cose, pure ci si ingannano poi se medesimi; e rimane lor dubbio tuttavia se sappiano essi o no, che pur vi si ingannano. Questo accade semplicemente, perchè i più degli uomini non vogliono riconoscere nel presente il passato, e nel passato l'avvenire: o, per dir meglio, perchè non vogliono essi per lo più veder altro che il presente, ed anche male osservarlo.
E la ragione trivialissima, messa in campo da tutti; che il presente ci tocca assai più da presso; non si può assolutamente tollerare in bocca di nessun artefice di cose grandi: d'un uomo cioè, in cui suppongo, e deve albergare, una nobile e ardentissima fiamma d'amor di gloria, la quale, se non sola, almeno prima motrice a lui sia. Che se il poeta, l'oratore, o lo storico, o il filosofo, ardiscono pur pronunziare, ch'essi hanno bisogno di pane, con viso giustamente adirato rispondono loro i non vili: "E perchè dunque, abbisognando di pane, non vi destinaste voi da prima ad una qualche opera servile di mano? più certo era il pane; non era infame il mezzo; e non avreste così dovuto arrossire in riceverlo".
Ma, ben mi avveggo che dai più degli uomini, sotto il nome sacrosanto di pane, si ricercano, e vogliono acquistarsi molti superflui comodi. Così, sotto il nome di fama, null'altro si va cercando dai più che un'aura passeggiera di vana glorietta, per cui correndo il loro nome per bocca dei loro contemporanei, accarezzati e considerati da essi ne vengano. E questa effimera distinzione, a cui non so qual nome si aspetti, per mezzo di una mediocre virtù protetta da una assoluta potenza, si ottiene. Ma il tempo, vendicator d'ogni torto, la riduce anche in polve ben presto, insieme colla stolta superbia e colla debile fama del protettore.
L'uomo che è nato capace d'esser sommo in un'arte, se alla naturale capacità egli aggiunge la tenace risoluzione di volersi far tale, io credo che prima d'ogni altra cosa egli debba piacere a se stesso; e per ciò, innanzi tutto, conoscere, stimare, e temere se stesso. Gli altri, sono uomini anch'essi; ma i più son minori di lui, e i pochi suoi eguali, o sono da invidia e da altre passioncelle acciecati, o essendo in tutto dediti a speculazioni diverse dalle sue, raramente sono giudici competenti, illuminati, e caldamente spassionati, dell'arte sua.
Il bello, sinonimo perfettamente del vero, è uno in ogni arte: ciascun uomo più o meno lo sente; ma chi può mai tanto sentirlo, quanto colui che lo può eseguire? Mille ostacoli impediscono il retto giudizio degli altri; ma, freddato interamente quell'impeto che allo scrittore era necessario pur tanto al creare, nulla può impedire in appresso il suo retto giudizio su le proprie opere; purchè soltanto egli voglia giudicarle da quella prima impressione che ne riceve il suo intelletto nel rileggerle, o farsele rileggere, allorchè non sono più affatto presenti alla di lui memoria. Il che può accadere facilmente a quel tale scrittore che avrà il savio metodo di far succedere l'una sua opera all'altra, per modo che lungamente le prime riposino. Ma, e dove vò io d'una in altra cosa saltando? al mio fine vò sempre; e troppo l'ho io nel cuore, perchè dalla mente ei mi sfugga. Il sommo artefice, cioè l'imitatore e ritrattore della natura, più forse quale ella potrebbe essere, che quale ella è pigliandola a parte a parte; l'artefice, dico, dee ascoltar quasi tutti, e non dispregiar mai nessuno; ma, formato ch'egli ha se stesso su gli ottimi che lo han preceduto, dee, più che ad ogni altro, piacere a quegli ottimi, e a se stesso; e ciò necessariamente importa, che egli piacerà poi a venti nazioni, a venti generazioni di uomini, in vece di piacere alla parte guasta di una. Né il sommo artefice dee così fare per orgoglio, ma per l'intima conoscenza del cuore umano ch'egli avrà acquistata leggendo, riflettendo, e pesando le passate cose; e per una intima conoscenza di se stesso, e delle proprie forze, ch'egli avrà acquistata esercitandole, e comparando se ai grandi di cui legge, e le cose sue alle loro, e le loro vicende alle sue. Ed ecco come il sublime sguardo dell'uomo che sommo vuol farsi, vede e misura ad un tratto il passato, il presente, e l'avvenire; conosce se stesso negli altri; gli altri in se stesso; e la natura, la verità, il retto, ed il bello conosce nella loro maggiore estensione, per quanto ad uom si conceda. Ora, un artefice che così fattamente pensa, si lascierà egli proteggere nell'esercizio di un'arte per se stessa sublime, a cui vede palpabilmente dagli esempj passati che la protezione ha arrecato minoramento di fama, e nel suo autore, e nell'opera? E colui, che ha necessità di appoggio per sostentarsi, può egli avere spinto tant'oltre il suo imparziale ragionare e riflettere? ed essendosi pure spinto fin là, non sceglierà egli piuttosto ogni altra via, che quella di un'arte sublime, per procacciarsi il più infimo indispensabile sostentamento?
L'uomo, che con qualche dritto si lusinga di conoscere il vero, e che si sente il nerbo di esporlo con forza ed eleganza, o dee avere il bastante per vivere, o contentarsi del pochissimo, o rinunziare all'impresa, o guastarla.
Ma io dicitor di paradossi parrò, se esemplificando non provo, o almeno non identifico il mio pensiero. "La fama di Virgilio è somma; chi non se ne appagherebbe? chi l'ha agguagliato, non che superato? ed egli era pure protetto e pasciuto da Augusto." Rispondo: "La fama dei libri di Virgilio è somma; e tale, quasi per tutti i lati, la meritano; e quelle parti di essi, che possono essere combinabili colla timidità dell'autore, e coll'avvilimento della sua dipendenza, vi si scorgono tutte perfette; sceltezza e maestà di parlare, varietà e imitazione d'armonia, vivacità di colori, evidenza, brevità, costume, e mill'altre: ma la principalissima parte d'ogni scritto, che dee essere (per metà almeno) l'utile misto col dilettevole; quella parte divina, che ha per base il vero robusto pensare e sentire, totalmente quasi manca in Virgilio". Alle prove. Discende Enea nell'inferno, e gli vien fatta la rassegna dei grandi uomini che sono per illustrar Roma, e per farla poi un giorno signora del mondo. Quale scrittore di verità, qual pensatore, qual gelido cronologista per anche, si attenterebbe fra questi di mentovarvi primi Cesare ed Augusto? e di mentovarli con ben altre lodi, che gli Scipioni, i Regoli, i Fabrizi, ed i Fabj, i quali seguono col misero corredo di pochissimi versi. Non contento di ciò, Virgilio spende diciannove altri eccellenti e toccantissimi versi per far menzione d'un Marcellotto nipotino d'Augusto, morto nell'adolescenza, il quale sarebbe affatto sconosciuto, se non era la vile sublimità di quei versi. Ma, per Catone, un mezzo verso basta a Virgilio; tre soli per Giunio Bruto; nè una parola pure per Marco Bruto. Molti altri grandi vi sono appena accennati; moltissimi preteriti del tutto, e fra questi (chi 'l crederebbe?) il gran Cicerone; perchè quel sommo oratore recentemente allora caduto era vittima di quella stessa tirannica mano d'Augusto, che, sanguinosa ancora e fumante del sangue dei cittadini romani, pasceva ed avviliva il niente romano poeta. Anzi, Cicerone dalla codardia di Virgilio viene espressamente insultato con quelle infami parole: Orabunt (alii) caussas meliùs;(5) nelle quali uno scrittore latino eccellente, con vile e menzognera sfacciataggine, gratuitamente accorda la palma della eloquenza ai Greci, o a chi la vorrà; e ciò soltanto per toglierla a Cicerone. Il lettore, a tai passi, ripieno di giusta indegnazione, è sforzato a gridar fra se stesso: "Ecco il pane di Augusto; ecco l'utile, che arrecano i principi protettori alle lettere; ecco l'inganno, la viltà, e l'errore, che non mai da essi, nè dai clienti loro, scompagnare si possono".
Parmi innegabile, che Virgilio in questo luogo, e in mille altri simili, abbia voluto piacere ad Au...
[Pagina successiva]