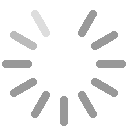[Pagina precedente]...ero da ogni servitù di coloro ch'egli stimare non debbe, nè può? Ed essendo egli ingegnoso, libero, virtuoso, costumato, eloquente, potrà egli mai mancar d'alti sensi, nè di giusto ardire, nè di luminose idee, nè di forti, splendidi, e sublimi colori per esprimerle?
Si osservi, che se a Virgilio (come già dissi) è mancata l'energia d'animo, che richiedeasi in un Romano che a Romani parlava, la cagion principale ne fu, che egli debolmente sentiva, e se stesso non istimava, nè stimare potea. Quindi è, che oltre il timore d'Augusto, anche la vergogna di se stesso lo trattenea dal dare certi tocchi risentiti, feroci, e verissimi, i quali smentito avrebbero pur troppo la sua vita servile. E se alcuno volesse anche trovare da ridere in un autor così grave, l'osservi in quei pochi suoi passi, dove egli pur vuole parer cittadino; e lo vedrà procedere con timidità tanta, e con tante cautele, che la di lui pusillanime cittadinanza lo svela, anche più che le ardite sue adulazioni, per un vile liberto di Augusto. Ma, chi vorrà pur trovarvi onde piangere, e con ragione, da quegli stessi passi ne ricaverà non picciolo dolore, riflettendo che da quei mezzi tocchi, e da quelle massimette di semilibertà snervate in versi eleganti, ne nasce assai più danno che utile alla universalità dei lettori. Dal poco dire, ne risulta il meno sentire; e dal sentir poco, allorchè un tale effetto si trae da un autore di grido com'è Virgilio, se ne cava questa falsa induzione; che in un buon libro (e massime di poesia) molte cose importantissime vi si debbano piuttosto tacere, o appena accennare, che scolpire. Non mancava a Virgilio null'altro, che l'alto e robusto pensar di Lucano; ma questa mancanza ad ogni pagina vi si fa grandemente sentire. Se non isbaglio, gli epiteti sono quelli che meglio svelano l'animo, le circostanze, e il più o men forte sentire dello scrittore. Esaminiamo rapidamente, sotto questo aspetto, l'epitetar di Virgilio.
Nel sesto libro, parlando egli d'Augusto, ne dice in diciotto versi ciò che mai d'uomo nessuno dir non potrebbesi senza sfacciata menzogna, e senza che parimente non arrossissero il lodatore e il lodato: ma in quei diciotto versi non ci osservo altro che il vile. Proseguiamo. Nominando egli i Tarquini, cioè quegli abbominevoli tiranni, la cui sola espulsione di Roma la fece poi grande, Virgilio dice: Tarquinios reges(6); e non vi aggiunge epiteto nessuno: perchè ogni giusto epiteto che avesse loro dato, veniva ad essere per l'appunto l'epiteto, che in vece dei diciotto versi sopraccennati, meritamente e solo spettava ad Augusto. E si noti, che il buon Virgilio dice: Tarquinios reges; neppure osando dire tyrannos; ed ecco il timido e ingannevole poeta, che scrive, non pei Romani, no, ma pel principe che lo pasce. Più oltre, menzionando Giunio Bruto, cioè il liberatore, e quindi il fondatore vero di Roma, dice il leggiadro poeta: animamque superbam ultoris Bruti; ed ecco il non cittadino, il traditor della gloria, della libertà, e dell'utile verace di Roma. Falsissimo, vile, ed iniquo pensiero fu il suo, di non dire, per la patria liberata da un Bruto, altro che animamque superbam(7); e di avvelenare ancora quell'epiteto già improprio, coll'aggiunto di ultoris Bruti; come se Bruto non fosse stato mosso da altro impulso, che dalla privata vendetta; e altra impresa non avesse egli a fine condotta, che il vendicare la contaminata Lucrezia. Ma, per i figli condannati dal padre (tratto, la cui ferocia non può essere scusata, nè abbellita, se non dalla riacquistata libertà) ci impiega egli maliziosamente quattro versi, sparsi di veleno cortigianesco; in cui dovendogli sfuggire per forza l'epiteto di pulcra a libertate, intieramente lo cancella tosto coll'aggiungervi in fine il laudumque immensa cupido;(8) e con ciò Virgilio viene a dipingerci Bruto, non come un cittadino liberatore, ma come un vendicatore crudele e vanaglorioso.
Che ne risulta da un così fatto scrivere? o il lettore, che non conosce Bruto altrimenti che da Virgilio, piglierà più avversione che amore per Bruto; e, stimando più le private virtù che le pubbliche, abborrirà il parricida, senza badare al liberator della patria; tollererà gli Augusti; li crederà per anche necessarj alla pubblica felicità: ovvero il lettore, iniziato già nelle cose romane da Livio, nulla potendo aggiungere alla stima e venerazione ch'egli avea già concepita per Bruto, molto aggiungerà pur troppo al disprezzo ch'egli giustamente anche concepito avea per Virgilio ed Augusto, nel leggerne le sopra mentovate lodi, non meno indiscrete che vili. Ma questo falso e debole pensare, potea egli forse provenire in Virgilio dall'avere egli stimato in suo core maggiormente Augusto che Bruto? niuno è, che ciò creda. Non proviene dunque questa virgiliana viltà da null'altro, se non dall'aver Virgilio anteposto gli agj e gli onori del corpo alla altezza e chiarezza della propria fama; dall'aver egli temuto più la povertà che l'infamia; dall'aver egli riguardato Augusto come il tutto, e Roma come il nulla; dall'avere egli in somma tenuto se stesso minor d'un tiranno.
Il sublime letterato, a parer mio, si dee dunque stimare più che uomo nessuno, se egli non vuol tradire la sacrosanta causa dei più, che sempre dev'essere quella, che in mille diversi modi egli tratta. E gli orgogliosi re, che scambiando la loro illimitata potenza con se stessi, si credono essere il tutto, e sono il perfettissimo nulla, debbono ai sani occhi del letterato il nulla parere: che tanto divario corre per l'appunto fra un illustre scrittore ed un volgar re, quanto ne correa tra un cittadino romano ed un servo asiatico eunuco.
Ma, parole al vento gittate sarebbero le mie, se altro aggiungessi per provar la supremazia del sublime ingegno su la volgare potenza: mi pare bensì di dover dir qualche cosa su la preeminenza tra un principe grande, e un grande scrittore; rarissime e sublimi piante l'una e l'altra, ma assai più rara, e sempre meno sublime, la prima.
CAPITOLO OTTAVO.
QUAL SIA MAGGIOR COSA; O UN GRANDE SCRITTORE, O UN PRINCIPE GRANDE.
Se tutti i pregi che si richiedono per fare il sublime scrittore, si trovassero pure riuniti in un principe, di quanto non dovrebbe egli primeggiar sovra tutti, poichè egli può operar tante cose, che lo scrittore può appena accennare? Questa mi pare una questione da doversi esaminare profondamente, per la semplice soddisfazione e persuasione dei più; che se io dovessi parlare a quei soli pochi, che giudicano per forza d'intimo sentimento, non la tratterei altrimenti. Ricapitolerei soltanto tutti i pregi dello scrittore sublime; cioè, sommo ingegno, integrità somma, conoscenza piena del vero, e non minore ardire nel praticarlo e nel dirlo. Da questo solo novero, verrei bastantemente a dimostrare, che se tali e tante doti potessero per semplice forza di natura trionfare degli ostacoli annessi al nascimento e educazione del principe, un uomo che se ne trovasse fornito, inorridirebbe tosto dell'esser principe, ed immediatamente cesserebbe di esserlo; e, divenendo facitore di così savie leggi che impedissero per sempre ogni futuro principe, egli verrebbe in tal modo (senza avvedersene) ad essere ad un tempo il primo degli scrittori tutti, e il solo vero gran principe che vi fosse mai stato. Dei tali non ne conosco dalle storie, che un solo: Licurgo, che di re si facea legislatore, poi cittadino; e quindi finalmente esule si faceva della riprocreata sua patria, per dare così più valore alle proprie leggi, acquetando con la sua lontananza l'invidia. Agide, e Cleomene, tentarono la stessa cosa più secoli dopo: il primo perì nella impresa; il secondo non la riuscì interamente. Per ciò la gloria loro è minore di quella di Licurgo; ma di gran lunga maggiore di quella d'ogni altro principe.
Ma si lasci a parte questa specie di grandezza, principesca ad un tempo e cittadinesca ed umana, la quale, per essere troppo sublime, se non vi fosse stato un Licurgo, verrebbe riputata più ideale che vera. Parliamo per ora delle tre specie di principi grandi di grandezza principesca soltanto; che appunto di tre sorti ce ne somministra alcuni, ed anche rari esempli, la storia. Scegliendo dunque un principe grande di ciascuna classe, e paragonandolo a un veramente grande scrittore, (e di questi non ve n'è se non d'una sola) mi affido di evidentemente dimostrare la verità.
La esatta misura della fama meritata e acquistata, innegabilmente sta nel maggiore o minore utile che si è arrecato agli uomini con imprese difficili, ardite, laboriose, e grandi, sì per se stesse, che pe' loro effetti. I principi che noi chiamiamo grandi, erano eglino conquistatori? La loro virtù è dunque stata utile soltanto ai pochi dei loro sudditi, dannosa ai più, distruttiva pei moltissimi uomini vicini, incognita o di nessun effetto ai lontani, di debole esempio o di tristo incitamento ai loro successori, e in fine di sterile maraviglia alle susseguenti generazioni. Erano eglino legislatori? ma essi fondavano assoluti principati, e non repubbliche mai. E, fondando governi assoluti, hanno insultati ed oppressi i più; hanno innalzati, insuperbiti, e fatti o lasciati essere oppressori i pochi e malvagj: quindi la loro fama, in proporzione dell'utile arrecato agli uomini, riesce pur sempre picciolissima o nulla agli occhi dei savj; ed agli occhi della moltitudine è durata quanto l'imperio loro, o poco più. In fatti, per quanto sia stato grande Numa, credo che la fama di Giunio Bruto in Roma avanzasse di gran lunga, e giustamente, la sua; poichè Numa con tante savie leggi non avea però potuto o voluto impedire le seguenti tirannidi, che avvilita ed oppressa la tennero; e Bruto all'incontro, con una sola generosissima impresa, avea stabilito quella libertà da cui nacque la vera Roma, che fu poi per tre secoli la maggiore e la più perfetta cosa pubblica di cui si abbia esempio nel mondo. O, finalmente, grandi erano codesti principi per avere, in un regno già stabilito, governati i lor popoli con somma politica, umanità, e dolcezza? ora, qual trista specie di uomini è dunque codesta dei principi, a cui viene ascritto come somma virtù, a cui acquista immensa fama ed eterna, il semplice esercizio del loro più stretto dovere? esercizio, al quale (se essi ben distinguono le cose) va annessa ad un tempo con il maggior loro utile la loro propria intera e sola felicità. Fu egli mai riputato sommo verun giudice, pel non commettere evidenti ingiustizie? verun pastore, per non disperdere il proprio gregge? verun padre, pel non trucidare i suoi figli? un uomo, in somma, è egli tenuto maggiore degli altri, soltanto per non esser egli e scellerato e crudele? Così è, pur troppo! Tanta è la facilità, la possibilità, e l'invito al mal fare per chi sta sul trono, che chi, nol facendo, ha operato, o lasciato operare dalle leggi un certo anche minimo bene, è stato riputato grandissimo. E, vista la nostra debile ed insolente natura, allorchè alcun freno possente non la corregge, un tale principe si dee pur troppo riputare grandissimo.
Fra queste tre specie di principi magnati, piglierò per esempio della prima, Alessandro; della seconda, Ciro; della terza, Tito: e paragonerò l'utile da essi arrecato agli uomini, e quindi la somma della loro fama, alla fama ed utilità arrecata da un solo valente scrittore; e sia questi il più antico; il gran padre Omero.
Alessandro, le cui vittorie e conquiste da nessun principe non furono mai agguagliate, non giovò ai Macedoni; perchè, della infinita gente ch'egli estrasse dal proprio regno, il più gran numero ne periva nell'Asia; e dei pochi che si arricchirono della preda dei Persj, niuno quasi ne ritornava in Macedonia: e questa, allo svanire di quell'aura prima di gloria che al popolo conquistatore si aspetta, rimanea un picciolo regno da se, poco o nulla serbando di quelle sue già tante conquiste. Alessandro ai Greci non giovò, poichè dalla epoca sua si deve ripetere la intera cessazione della lor libertà, per cui sola i Greci si erano creati il primo popolo della terra: ai Pe...
[Pagina successiva]