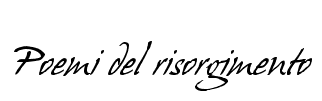[Pagina precedente]...mezzo, nudo l'arco, sta.
IV
Ma dall'ignoto Spirito sferzate
corrono a lui le riluttanti nubi,
strisciano appiè di lui, sorgono a un tratto,
lo velano, lo celano. È sparito
sotto la pioggia fumida, sparito
nel grembo grigio. Né baleno guizza
mai da due nubi frante che divida
l'oscurità . Niuno lo veda! Niuno
veda la fronte cupa, niuno veda
quegli occhi tristi, i tristi occhi veglianti,
come due tristi uccelli della notte,
sul suo terribile sorriso.
Non lampo mai; né mai rimbomba il tuono
seguace; ch'altri non lo creda il tuono
della sua secca chioccia bronzea voce,
usa a guattire sola tra il silenzio
di cupi pallidi uomini e il sommesso
loro anelare; ch'altri mai non pensi
che dalla tacita isola dei morti,
d'oltre l'Oceano e il popolo dei sogni,
sia quella voce che di tra l'eterna
penombra, sopra il sonno delle genti,
sul mondo forse immemore, passando,
scoppi e si franga all'improvviso,
e chiami e scuota, e susciti nel mondo
squilli di trombe, rulli di tamburi,
scroscio di marcie, suon di ferro, strido
di ruote, émpito e ringhio di cavalli,
polvere e fumo, e grandinar di palle,
scintillar d'armi, e rombo di cannoni,
assalti, fughe, mura umane, stagni
di sangue umano: ululi d'odio, strazi
di pianto, un pianto immenso, un campo immenso
che piange, tutto un piangere di madri;
e fuoco, sangue, orrore, morte; e un grido
solo: L'Imperatore è là !
V
Or tra gli smerghi e l'aquile marine
è là , celato; e raro e breve il sole
s'affaccia e getta, per vederlo, un raggio:
ché brama il sole di veder quel pari
a sé terrestre; ché anche il sole è solo.
Guarda, e si cela. E non appena il giorno
egli ha compiuto, subito nel buio
precipita, né roseo s'indugia
nella soave ora crepuscolare
a consolare il cielo d'una blanda
chiarità ampia che si muta in ombra,
così, più dolce che la luce.
No: ch'egli, come il simile terrestre,
precipita. Se non è dì, sia notte.
E rare a notte vengono le stelle
vergini, vengono all'Ignoto ignote,
la Croce insieme e la Corona australi,
per veder l'uomo che nella sua mano
tenne il timone dell'opaca Terra
e volle unico reggerla sul mare
del rezzo eterno. Cercano le stelle
quell'Orïone cacciator di fiere,
armato d'oro, cercano quel nuovo
divino pùgile Polluce.
Avea lottato, il Pùgile, con Dio!
Avea ghermito una sua stella a Dio!
Volea rapire una sua stella errante!
la nera Terra! E l'altre stelle erranti
già ne' lor pii crepuscoli il pianeta
vedean, tremando, prigionier d'un uomo;
vedeano rosso al placido orizzonte
spuntare il globo, vario di grandi ombre,
soffuso forse, ogni dì più, di sangue;
nel cielo ancora ma non più del cielo.
Empia e sicura al non tuo cielo, o Terra,
montavi lentamente su.
VI
L'anima egli era, e tutto il mondo, il bruto.
Soltanto braccia egli chiedeva, e l'ebbe.
Fu come il Brahma, a cui sporgean dai lati
mille migliaia di guizzanti braccia,
mille, di mani, ognuna d'esse un ferro.
Né città v'era né deserto al mondo,
né tempio augusto, né sublime reggia,
né foro né castello né ruina;
o dove nasce o dove cade il sole,
a sud, a nord; sopra la cui parete
non apparisse; alfine un giorno, l'ombra
adunca d'una sua gran mano.
Egli era dio d'un proprio suo diviso
regno di dio. Per tutto egli era, e tutto.
Ne ripeteva, paventando, il nome
l'eco dei monti e la marea dei mari.
Empiano i suoi migranti padiglioni
le nivee steppe e le assolate arene.
Gittava al Tutto egli le braccia armate,
calmo, dal perno, e tra lo scatto enorme,
tra l'infinito riscintillamento
delle sue braccia, si vedea quel mezzo
Sorriso breve cui covava eterna
la sua tristezza di Titano.
Ed egli volle un vicedio ch'eterno,
per il dio triste, sorridesse al mondo.
Volle, e compose un idolo fasciato
di bianca seta, rilucente d'oro,
aspro di gemme, gli occhi pii, le labbra
sottili, aperte sempre al dolce assenso.
E lo vegliava, ché dovea placare
gli uomini a Dio, con la gemmata mano
benedicente, e gli uomini pregare
per l'immortale. Ond'egli cupo in vista
mostrava il placido idolo alle torve
inginocchiate sue tribù.
VII
Altri al timone siedono del mondo.
Son mozze alfine le sue mille e mille
e mille braccia, e guizzano per tutto,
cadute a terra, le convulse mani
cercando il ferro. Egli nell'aria fosca
leva, stillanti sangue, i moncherini.
È chiuso là nell'isola deserta
tra le grandi acque, che l'attendamento
de' re terrestri il suo dolor non turbi
con l'alte grida. Sullo scoglio assiso
forse nel mar tuffa le braccia, e lava
le innumerabili ferite.
Credono i re di udire la selvaggia
querela atroce, l'aspro grido acuto
ch'egli dal lido getti alle fuggiasche
vele atterrite. No; ch'ei tace, o parla
soltanto a smerghi ed aquile marine.
Ei siede e tace, mentre sull'Oceano
purpureggiante le sue braccia affonda.
Tace ed assiduo, tra la nebbia, lava
il sangue inesauribile che sgorga
dai milïoni delle braccia, il sangue
che sgorga dalla pallida sua vita,
di milïoni d'altre vite.
Non è fragore ondoso di risacca
alla scogliera, non è vento urlante
nei boschi morti, non tempesta in mare
che l'isola urti, e sciacqui nell'abisso.
È lui che sparge sopra sé l'immenso
Oceano rosso, per lavare il sangue.
A grandi ondate abbraccia il mare, e tutto
l'attira a sé. Cupo silenzio è intorno.
Là , nell'oscurità caliginosa,
vedono l'ombra del ferito immane
i brevi re, tremando ancor dell'uomo
ch'è tutto ancora, e non è più.
VIII
Anch'egli vede nella lontananza
perduta, un altro, indissolubilmente,
tra l'acqua e l'aria, a' suoi travagli avvinto.
Lo vede: egli solleva alte le braccia.
Egli sostiene il polo sulle spalle,
del cielo, ed allontana con le braccia
dal capo suo le costellazioni,
e la marea mugge a' suoi piedi infranta.
Passano lente sopra lui le ruote
del Carro, e geme sotto lui l'Abisso,
e lungo lui scrosciano andando i fiumi
alle voragini profonde.
Ed anche un altro ei vede: una vedetta,
stante, ed insonne, e immobile, sospesa
al duro scoglio, attraversato il petto
dal cuneo lungo di mordace acciaio,
serrato da infrangibili catene
l'un piede e l'altro a due lontane rupi.
E tra i due piedi passano le navi,
ch'egli insegnò; ché diede all'uomo il fuoco
delle cento arti e delle cento morti.
Ora egli sta, né più goder del bene
può né vietare il male, avanti il riso
innumerevole dell'onde.
E solo, come i due Titani, è il nuovo
venuto, solo tra sé stesso e il mondo.
L'onde che s'accavallano spumando
sulle ginocchia al reggitor del cielo,
intorno ai ceppi al rapitor del fuoco,
son quelle dove tuffa le sue braccia
inutile l'uomo. E il suo pensier soggiace
all'universo, ch'egli può, l'invitto.
Ma il triste cuore e il fegato, rombando
nella penombra con le sue grandi ali,
a lacerarli senza fine scende
l'imperïale aquila giù.
IL RE DEI CARBONARI
I
Nella foresta murmuri notturni:
breve nel buio balenìo di luci.
Forse non son che lucciole e che gufi:
gufi con gli occhi tondi ne' lor buchi.
O non son essi. Vanno attorno i lupi
con passi sordi sulle felci e i muschi.
O forse vanno per la solitudine
anacoreti con lor pii sussurri.
Bussano andando i cavi tronchi duri,
che ognun si scosti e qua o là s'occulti.
No: sono boscaioli con le scuri,
così lontani che gli ansiti lunghi
e i grandi colpi sembrano minuti
picchi di picchi e singultìo di chiù.
II
Il fuoco dorme in mezzo alla foresta
nella sua piazza. Dai cagnoli il fuoco
occhieggia e guizza. Ma di foglie mista
la terra chiude la fumante bocca.
Il fuoco è dentro: inconsumabile arde.
Nelle baracche, cui di frondi è il tetto,
i carbonari dalle lunghe barbe
su tronchi assisi, vegliano, tenendo
la scure in mano. Una lucerna brilla
sul maggior tronco con le sue tre fiamme.
Il gran maestro alza le mani al Santo
e intuona il canto nel silenzio sacro:
III
- Oh! questa è gioia, questo al mondo è bene,
in un sol luogo dimorar fratelli.
È come unguento sparso sui capelli,
che piove giù dal capo sulla barba.
È come unguento scorso sulla barba,
che scorre, e bagna l'orlo della veste.
Come sereno piovere celeste,
come rugiada che vien giù dal cielo;
rugiada che discende dal Carmelo,
discende ai colli, e poi da' colli al piano.
Ché Dio segnò quei luoghi di sua mano,
e vita avranno fin che secol duri.
E voi le mani alzate con le scuri
stando nell'atrio, in cuor pensosi e pronti.
La notte cade. Luce è già sui monti.
Le scuri alzate contro il dì che viene. -
IV
Il gran maestro con la scure il tronco
batte tre volte. Grave parla, e dice:
«Udite, o nati da fratelli. All'uscio
d'una baracca uno picchiò notturno.
Era smarrito tra la notte e il nembo,
nella foresta. Vide il fuoco in una
radura, acceso. Vide le tre luci
nella capanna. Entrò. Giovane e bello
era, coi segni del dolore in fronte.
Era un'errante zingara sua madre.
Per lunghe strade lo traea fanciullo
meditabondo. Sempre gli occhi al cielo
teneva, fissi, per vedere un astro,
che non sorgeva. E nel suo cuore il sangue
del Conte Verde era e del Conte Rosso.
Re, per destino, egli sarà dei monti;
ma noi l'ungemmo re della foresta.
Contro lui geme ed ulula il lupatto
dell'Apennino, e l'aquila a due rostri
lo spia dall'alto senza muover l'ale,
tacita, intenta. Ma il re nostro un giorno
trarrà la spada, leverà lo scudo,
ché Dio lo vuole, con la bianca croce,
mettendo in fuga tutti i lupi e i gufi,
allor che la grande aquila ferita.
trasvolerà , rauca strillando, l'Alpi.»
V
- O Carbonari, uscite dalle porte
dell'acque, con le accette sulle spalle.
Uscite al monte, andate nella valle,
tagliate rami verdi d'oleastro.
Recate ognuno frondi d'oleastro,
rami di mirto, calami di canna.
Fatevi, come è scritto, una capanna,
un vostro asilo tacito e selvaggio.
Una capanna, usciti di servaggio,
fate di rami d'acero e di pino;
ove beviate in pace il dolce vino
e vi cibiate della pingue carne.
Ma la sua parte niuno oblii mandarne,
a chi non n'ha, ché questo è il giorno santo.
E lieti siate, ed obliate il pianto.
Gioia è di Dio che il cuore ci fa forte. -
VI
Così celati aspetteranno il giorno
d'andare incontro al gentil re crociato.
Libereranno dalle piote arsite
allor la bocca, e il carbon nero al vento
prenderà fuoco e brillerà sul filo
di mille scuri, e da quel fuoco il fumo
a grandi spire salirà nel cielo.
Nero il vessillo come carbon nero,
e rosso e azzurro come fuoco e fumo,
sia nelle vostre mani, o boscaiuoli,
o taglialegne nati da fratelli,
o carbonari, avanti al re che viene!
VII
Passano intanto i carbonati occulti
la notte, alzando le due mani ai puri
astri del cielo, tra gli scabri fusti
d'annose quercie, nei romani luchi.
Gittano sangue al lor passaggio i pruni,
scrosciano foglie, fischiano virgulti.
Sotterra il fuoco hanno sepolto muti,
siccome seme gli aratori ignudi.
Germinerà . Nei taciti interlunii,
chiusi nei tabernacoli fronzuti,
pensano al re fanciullo, che tra i lupi
ignaro passa, che di tra le nubi
l'aquila veglia, e piomba già su lui
stringendo sempre il nero volo più.
GARIBALDI FANCIULLO A ROMA
PEPIN
I
L'isola sacra, l'isola dei morti
aveano a poggia, piena d'asfodeli.
LÃ bianchi i morti, volti alla marina,
sui tumoleti, tendono le mani
al sole occiduo. Ora al chiaror dell'alba
v'erano voci di piombini e chiurli.
E la tartana lontanò. Ma il vento
batté la vela e sibilò nei fiocchi;
e sorse allora un mozzo biondo, il figlio
del padron vecchio, col grondante remo;
e stette a prua guardando muto il fiume,
l'Albula chiara, del color d'argilla;
a cui d'estate non mescean le pioggie,
non i ghiacciai, ma grandi opachi laghi,
sotterra, ignoti. E contro lui correva,
fremendo al sommo, il Tevere immortale.
Ma il vento salso avea seguito a volo
dal mar tirreno il marinar fanciullo,
e fischiò tra gli stragli e arruffò fresco
la lunga sua capellatura fulva.
II
La prua solcava l'ombre ora di glauchi
canneti in fiore, ora di rade quercie.
Dove accosciata era la scrofa bianca
coi trenta bianchi suoi porcelli intorno?
Dove la reggia alta tra i boschi sacri,
nell'atrio i sacri vecchi re di cedro?
LÃ , da pantani pieni d'erbe e giunchi,
sporgean la testa i bufali selvaggi.
Dov'era il bosco della Dea Larenzia
co' grandi suoi dodici figli arvali,
danzanti al sole ed invocanti il sole
con bionde spig...
[Pagina successiva]