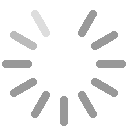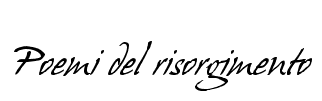[Pagina precedente]...nsante
non ravvisava, nel Mamurio irsuto,
Marte sé stesso. E scese alfin dal sommo
dell'arce, dietro gli altri dei consenti,
Giove pieno di nubi il sopracciglio.
«O già potenti in cielo, sulla terra,
nel mondo oscuro: fummo. Noi cacciammo
altri dal soglio, ed altri noi discaccia.
Ma non è vano l'aspettar vicenda.
Quel dio rifatto, a cui cedemmo contro
cuore, fuggiasco, povero, deforme,
il cui soglio è la croce, ed il cui serto
sono le spine dei roveti...» Ed altro
egli diceva, ma seguì con voce
piena d'orrore la Carmenta antica
vaticinante, a nessun dio più nota,
svanì lasciando gli edifici soli,
già balenanti, già meditabondi
tra sé e sé, del crollo ultimo, e Roma,
Roma, sotto il suo sole almo, deserta.
IL GRANDE SEPOLCRO
E fu silenzio dentro le muraglie
sacre, e il pomerio grande ora cingeva
grande un sepolcro. E il sole che la vide
tacita, a poco a poco calò, lento
sfiorando con un alito di luce
le cupole e i lunghissimi obelischi;
e poi nel trarre fuori il dì, tentando
invano di svegliarla dal gran sonno,
stupiva di vederla altra e la stessa.
Suono non v'era se non d'improvviso
crollo di muro o il tonfo di finestre,
cui si provava di serrare il vento.
Talvolta andando e riandando i corvi,
gracchianti, a stormo, quel letargo strano
scotean, nell'ira, d'uomini e di cose.
E molti discendean dall'Aventino
foschi avvoltoi, che ripetean l'augurio
natale, in alto, sulla città morta.
E poi notturna i cuccioli la volpe
guidava, e le basiliche del Foro
cauta girava e le colonne antiche.
E dopo i lunghi secoli le lupe
del tempo primo vennero, cercando
gli antri per l'alte sedi imperïali.
Parean, destati dal lor sonno i templi,
aperti stare, stare ed aspettare
i sacerdoti immemori. Giaceva,
abbandonata per i sette monti,
Roma. E le acquate assidue la battono
e le raffiche rapide del vento,
e la fiammante folgore del cielo
ormai fa divampare il rogo.
IL NOME CELESTE
Aprile
era vicino, era, con lui, vicino
il dì natale della città morta.
E di narcissi dalla chioma d'oro,
di crochi dagli stami d'oro rise
la solitudine, e dalle rovine
dei templi il rosso smìlace comparve;
e le vïole al fonte di Iuturna,
caste, s'abbeveravano, e gli sparsi
ruderi si gremìano di giacinti;
e tutti i bronchi e pruni aspri, nel Foro
Romano, in cima avevano una rosa,
e sopra i marmi antichi era l'antica
porpora. Per nessuno, dal sepolcro,
dal suo sepolcro, ch'era anch'esso infranto,
spargea, versava senza fine al cielo,
nel tempo dolce ch'è il suo tempo, i fiori
che sono suoi, quella che in cielo è Flora.
A FLORA
Flora! madre dei fiori, o tu cui sempre
è primavera, o tu che per le genti
immense hai sparso il nuvolo dei semi,
la Terra aiuta! Questa pia saturnia
terra produca in maggior copia i frutti
che già versava dal fecondo grembo.
Nutra di sé quelli che già nutriva,
armenti e greggi, e tornino gli uccelli,
ormai spariti, a liberare i campi,
e per i campi floridi echeggiare
facciano la dolcezza del lor canto.
Alle mammelle opime della Terra
sugga una prole più gagliarda il latte
e insiem col latte la virtù romana;
ed ogni mare solchi ed ogni terra
calchi, anche il cielo navighi, sembrando
candidi stormi di canori cigni.
La tua città non lasciar più che cinta
sia di deserti e verdi acque muggenti
del torvo bue selvaggio che vi guazza.
Riguarda quei villaggi di capanne,
quelle capanne squallide di stoppia,
o Flora! Dunque non distrusse il fuoco
de' primi dì tutti i tuguri? Dunque
non toccò tutti gli uomini il Diritto
con la sua verga? Guarda: sono schiavi,
sotto le bestie! Rendi a quei meschini,
o Flora, il suo; liberatrice abbraccia
quelli spogliati; e per sé solo, o Flora,
raccolga chi le seminò, le messi,
come allorquando si lasciava a mezzo
solco l'aratro e s'assumeano i fasci.
Rinnova l'arte antica, cingi al capo
l'antico serto e fa che mai non cada
l'inno di gloria che beò l'Italia.
Sian, per i colli, glauchi olivi e verdi
viti, e di spighe rigogliose ondeggi
la valle immensa. E fiacchino la forza
del vento e il nembo struggitor le selve
veglianti a guardia sul cigliar dei monti.
Il Rubicone, ecco, già bianchi ammira
enormi tori. Egli che vede andare
per la campagna tante paia e vede
da dieci bovi tratto un solo aratro,
egli che già non obliò nel sonno
le bronzee file della forte Alauda,
pensa all'imperio, a Cesare, ai trionfi.
Noi non l'imperio, non i cortei lunghi
di quei trionfi a te chiediamo. Un'Ara
abbiamo, e noi, di Pace, eretta, o Flora.
I fiori dà color di sangue ogni anno
(solo nei fiori tu il color di sangue
lodi e nel casto viso di fanciulle:
miele, olio, vino, o Flora, ami; non sangue),
dà le memori foglie dell'acanto
per adornar quest'ara. Alto nel mezzo
noi collocammo in una vampa d'oro
chi la portò; questa concordia augusta.
E quanti ancora col lor sangue, eccelsi
spiriti, questa pace e questa patria
fecero a noi, là stanno. E sono, o Flora,
la messe tua che cade sì, ma sempre
nuova nei lunghi secoli germoglia.
IL PRIMO COLLE E I PRIMI PASTORI
Certo è che vive in questa terra occulto
qualche portento, e sì, nel monte, dove
Roma quadrata germinò dal solco.
Pastori un tempo (luce ed ombra incerte
vi si spargean sotto la falce d'oro)
erano là coi rastri. Era la gloria
vanita già di Roma, era d'Apollo
sparito il tempio. Tutto il sacro colle
tenean le infrante vecchie pietre ingombro.
Cespi d'acanto, nuove polle uscenti
da qualche ceppa d'albero che appena
sapea sé stesso, s'opponeano al piede.
Giacean rottami candidi di marmo
tra i rovi e i pruni, e sorrideano al suolo
i capitelli ai cardi ispidi e duri.
Muri con archi, cui copriva il musco,
pendean crollanti, si scoteano al vento
ad ogni crepa le parïetarie
come ciarpame pendulo a finestre
d'un abituro. Qua le acquate al tutto
finìan gli dei dipinti nella calce,
qua le ventate stridule uno straccio
sempre rapìan da tende non più fisse.
Scabbia di pietre, lue di sassi verdi
per tutto, ed archi che teneano ancora
sol per l'abbraccio d'edere contorte.
Credean gl'ignari di veder spelonche
di giganti che dopo un'ardua rissa
con massi enormi, ora, cocendo l'ira,
lontani e soli errassero sui monti.
IL SEPOLCRO DEL PRIMO EROE
Ed i pastori, come un tempo, in cerca
di preda, una spelonca aprono, un sasso
movendo, immenso, e vedono nel fondo
della spelonca balenare un lume.
E quindi - era un sepolcro - gigantesche
membra d'un uomo vedono, che il petto
aveva aperto da una lunga piaga.
Stupor li prese di quel corpo cinto
d'armi cangianti, di quel capo ignoto
dentro l'irsuta gàlea. Ché tutte
l'arme egli avea, fuor della spada, e il petto
non gli cingeva il balteo d'oro, vario
di spesse borchie. Sull'ignoto capo,
alto, vegliava un fuoco e gli sfiorava
l'antica piaga con l'assidua fiamma.
Un dei pastori, simile ad un Fauno,
vide fra tanto impallidire il cielo,
languire insiem le tenebre e le stelle.
LA LAMPADA INESTINGUIBILE
Ogni maceria gorgheggiava. I nidi
s'erano desti, delle rondinelle,
in fila sotto i capitelli neri.
E si vedean le macchie, e tremolando
splendean le cime delle selve, e i pini
alti sopra la vetta Pallantea.
Ed il pastore trasse fuori all'alba
la lampada e l'oppose al mattutino
vento. E il suo lume si sbatté, ma visse.
E vi soffiò con le selvaggie labbra,
e la tuffò nell'acqua d'una pozza;
ma il lume visse. Ed e' la rese ardente
al suo sepolcro e l'appendé dov'era,
e col suo masso chiuse la spelonca.
Dove ancor pende e raggia ancor la luce
su te, giovine eroe primo, che fosti
di tanta gloria e tanta lotta e tanto
dolore e amore la primizia santa.
Son tre millenni ch'ella dal sepolcro
veglia su Roma con l'eterna luce.
A ROMA ETERNA
Spirito eterno, eterna forza, o Roma!
Dopo il gran sangue, dopo l'oblìo lungo,
e il fragor fiero e il pallido silenzio,
e tanti crolli e tante fiamme accese
da tutti i venti, tu col piè calcando
le tue ceneri, tu le me macerie,
sempre più alta, celebri il più grande
dei tuoi trionfi; ché la morte hai vinta.
Tu in faccia a tutti i popoli che a parte
chiamasti del tuo dritto, ora apparisci
nel primo fior di giovinezza ancora,
meravigliosa, simile a Pallante,
difesa intorno dal fulgor dell'armi,
e con la spada; e pende sopra il mondo
quella al cui lume accesero le genti
tutte il lor lume, quella che noi rompe
l'ombra: o Roma possente, la possente
tua più che il tempo lampada di vita.
INNO A TORINO
I
Toro divino ch'oltra due fiumane
giaci e, fiso nel gran murmure, guardi
l'Eridano, che passa e che rimane:
macro pascesti sotto i baluardi
donde i Titani si sporgean, le spine
dei rovi, un tempo, ed il salistio e i cardi!
Ti distendevi immenso sul confine
delle montagne, nella notte, attento
tra il fioccar bianco e le tormente alpine;
facesti il nerbo di cento anni in cento,
solo e rubesto, caute le pupille,
sbalzando al piano, corneggiando al vento,
Amavi l'ombra; amavi le tranquille
acque e verzure; eppure avesti in sorte
la guerra eterna, dai mille anni ai mille.
Passavi i fiumi baldo allora e forte,
cedevi passo passo, e insanguinato
col dosso all'Alpi combattevi a morte.
Da due nemici preso a volte in guato,
di qua di là, volgevi tu d'un salto
a questo e quello il fiero capo armato.
Alfine come statua di basalto
tu ti piantasti quadro sulle sponde
Ticine, or pronto a rintuzzar l'assalto,
or volto verso il piano, oltre quell'onde,
verde, ove il tuo nemico, il tuo rivale,
erbe non sue pasceva e non sue fronde:
il collo in arco, a fronte bassa, male
pensando, e il sì nel fiero cuore e il no...
finché mugliasti, rauco, trionfale,
lungo; e l'Italia tutta ne sonò.
II
Quale eri tu? Non l'ITALO tu forse
che per la grande terra della sera
trasse un fatale popolo, e la corse
tutta col nome che tuttor non era?
Fuggìano, andando, le paludi oscure
tinte d'un lividore di tramonti;
fuggìan le macchie vergini di scure
e il fuoco acceso notte e dì sui monti.
Sospesi, se temere, se sperare,
tendean l'orecchio ad altri gridi umani;
ma non s'udiva che scrosciare il mare
e rintronare lava di vulcani.
Emergeano cavalli-d'-acqua a torme,
spruzzando pioggia dalle froge grosse.
Volgeano i piccoli occhi e il muso enorme,
chiedendo a sé, quella tribù, che fosse.
Fendeva i boschi un calpestìo selvaggio
ed un fragor di grandi alberi infranti.
Pareva un cieco nembo; era il passaggio,
là, di rinoceronti e d'elefanti.
E quando a notte era sparita, avvolta
d'aride foglie la raminga gente,
a prender sonno, tutta notte in volta
andava l'ombra del leon ruggente.
Ma sempre tu, senza guardarti attorno,
guidavi, o Toro, i tuoi Taurini erranti,
allor che i piè, sempre più lenti, un giorno
fermasti. T'era una palude avanti:
una palude gialla che tra l'ulva
lasciava sette cime già scoperte
di colli. La rapace aquila fulva
gridava all'acqua che stagnava inerte.
Ma nubi nere e sfavillìo di lava
uscian di notte dalle verte nude
dei monti, intorno, e sempre sussultava
la terra e balenava la palude.
Era lontana l'augurale aurora,
che s'aspettava. E tu, col tuo profondo
muglio, colei ch'era nascosta ancora
dall'acqua ed alga, la chiamavi al mondo.
Dopo gran tempo era per balzar fuori
Roma, nei dì che da te spunta il sole,
Toro che spargi sulla terra i fiori
e in ciel t'impenni tra le stelle sole.
Roma era allora cinta dalla dia
vigile Terra. Tardo, a poco a poco,
continuasti, o Toro, la tua via,
volgendo al tuono il capo, spesso, e al fuoco.
Tutta così la terra senza nome
varcasti lungo il risonante mare
passando fiumi e valli oscure; e come
fosti alla fine del fatale andare;
la Primavera Sacra che dai solchi
natii fu data ai venti e alle venture,
il tuo ramingo popolo, i bifolchi,
ITALO, tuoi, levando l'aste pure,
dissero: Italia! Vollero che il breve
lido del mare fosse Italia, fosse
di te. L'Etna alitava, tra la neve,
nuvole, ver' la verde Italia, rosse.
Poi dove il Sole ha i pascoli, tu insieme
ai tuoi Taurisci a nuoto un dì passavi.
Ma sopravenne dalle prode estreme
l'Eroe più dio che gl'Immortali ignavi.
«Indietro!» disse, e tese l'arco. Indietro
volgesti allor, parando le tue torme,
girando spesso attorno gli occhi tetro,
ponendo i piedi sulle tue grandi orme.
Passando, quella ch'era un dì palude,
ve...
[Pagina successiva]