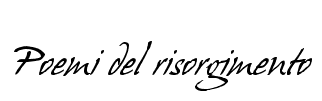[Pagina precedente]...desti arare e seminar già doma.
Era un pastore dalle membra nude
che seminava l'avvenir di Roma.
Aveva atteso te, la primavera
tua, la ma stella. Anche di lì cacciato,
spingevi innanzi la tribù tua fiera,
volgendo il capo, ed obbedendo al fato.
T'era alle spalle, simigliante a notte
oscura, te seguendo sempre al varco,
una grande ombra in mezzo a nubi rotte,
l'ombra di lui, con nudo e teso l'arco.
Ma tu posasti, dove due fiumane
angolo fanno, certo del destino.
Si sparse intorno per capanne e tane
il tuo tenace popolo Taurino.
Appiè dell'Alpi t'accostasti come
sopra una soglia. Il tuo viaggio vano
pensavi e il lido cui tu desti il nome,
e l'avvenire, grande, alto, lontano.
III
Itale vergini, Alpi dal bel velo
bianco, tendenti all'alto, che la veste
lasciate lungi dagli sguardi impuri,
la veste, sì, di prati e di foreste
cader lasciate, ma soltanto in cielo:
di quali voci allora e qual concento
empian le Madri i neri boschi cupi!
quali lontani portentosi auguri
gemean negli antri, o dritte sulle rupi
gridavan alto tra la neve e il vento!
- Un re verrà (fermo è nel fato e fisso)
dalla sventura. Caccerà camosci
per l'Alpi sue. Sempre nel cuore il fischio
avrà dei venti, sempre avrà gli scrosci
delle valanghe e l'anelante abisso.
Il re vedrà , tra nubi grigie e meste,
un segno bianco e snuderà la spada.
Il re porrà tutto sé stesso al rischio
per liberare tutta la contrada,
alzando al cielo il suo segno celeste.
Il re trarrà dalle grandi Alpi al piano
di nuovo il Toro; dal suo doppio fiume,
lungo la terra della stella, al mare;
a riveder la prima Italia al lume
del pino acceso dal suo gran vulcano.
Questi, quel Donno, il Regolo fatale.
Gl'Itali udrà gridare di dolore.
Gl'Itali lo vedranno cavalcare
con l'asta lunga. O Roma, egli, vittore,
dell'elmo ferreo t'armerà , che ha l'ale. -
Così le madri predicean nel santo
orror dei boschi, ed ora al sacro fonte
sotterra dell'Eridano. E, pur bassa
fosse la voce, trascorrea dal monte
Vesulo sino al mare Adriaco il canto.
Via via le ripe faceano eco; e in doppi
lunghi filari le sorelle fise
a rimirar l'acqua ch'eterna passa,
tutte, in udir, crollavano improvvise
le loro chiome tremule di pioppi.
Abbrividiano come per un blando
soffio di venti. Un dolce suono usciva
dalle lor foglie ov'era un usignolo.
Così lunghesso la lunata riva
parcano andare in compagnia, cantando.
Faceano un solo inno d'amore i puri
virginei canti. E tu, come una nave
bianca dall'acqua fluttuando a volo,
cantavi ancor più forte e più soave
le morti, o cigno, degli eroi futuri.
Gli eroi nel bosco del perenne alloro
erano insieme assisi al sacro fonte
dell'Eridano, e tutti, redimita
già delle vitte candide la fronte,
diceano l'inno della gloria in coro.
Anime pure, anime senza sangue
erano ancora, ancor sul limitare;
che alfin trovato il lume della vita,
alla lor Patria dar la vita, dare
tutto voleano alla lor Patria il sangue.
IV
Taurina gente, sacra sin dagli anni
primi all'Italia, o fuochi accesi in vetta
delle bianche Alpi, o saldi cuori e forti,
o guardie eterne poste a vigilare
l'estrema, immensa, ardua trincèa di Roma!
L'avea, la forza del maggior nemico,
varcata già la cerchia di granito,
le avea forzate l'ultime muraglie
sacre d'Italia e della sacra Roma.
Veniva già col vento e la tempesta,
invisibile in mezzo alla tormenta.
Sul capo suo cadeva franto il cielo
che nascondea nel polverìo le turbe.
Per cime e valli andava, e il suo cammino
dalle macerie era, del cielo, ingombro.
Ma egli andava, come in un gran sogno,
sempre, non mai volgendo gli occhi, avanti.
Intorno a lui sonava il faticoso
nitrito de' cavalli, a cui le sabbie,
auree nel caldo anelito del sole,
rideano al cuore; avvezze a pascolare
sotto le palme, le turrite mandre
barcollanti incedean degli elefanti.
Alle sue spalle, un fragor grande, crolli,
fuga, tumulto, e scrosci di foreste
schiantate e grosso crepitar di fiamme.
Era un serpente enorme che con torve
spire seguiva, e i culti campi larga-
mente prostrava e sradicava i boschi
e con la coda distruggea le intere
città ; che tutto con la bocca ardente
dava alle fiamme, insieme, ed alla morte.
Era la vïolenta idra straniera,
la sventura d'Italia, che d'allora
avrebbe osato rompere i confini
sacri, in eterno, e sulla devastata
terra l'immane corpo arrotolare
e covar sopra ceneri di messi
e sopra roghi di città distrutte.
Allora in prima il mal serpente infranse,
per farsi via, le rupi ond'è costrutto,
insino al cielo, il Termine d'Italia;
Termine immenso che da mare a mare,
col fondamento nel lor fondo, incurva
sé stesso e sembra, a Dio caduto, un arco.
Allora in prima con le spade in mano
guizzanti, voi sbalzaste su, Taurini,
e sulla soglia della patria terra
gettaste il sangue, sin d'allor col sangue
segnando il patto con il vostro fato.
Ma voi vedeste chi, le italiche Alpi,
da questa Italia le ascendea Romano;
ma voi vedeste poi le italiche armi
oltre i confini propagar la pace
del giusto Lazio. In mezzo a voi, Taurini,
come nel marmo in cui la vita scorra,
Cesare apparve. Nel paludamento
imperïale ei conducea l'Alauda
fulva le chiome: intorno a lui le scuri
nei fasci, e i pili della sua coorte.
Oppur liete parole egli intrecciava
coi fidi amici, o nella molle cera
solchi imprimea col vomere, gittando
in quella il seme del suo gran pensiero.
Ora i fasti romani, ora le guerre
per terra e mare, e il mondo vinto, e, in mezzo
ai suoi trionfi e alla sua pace, Roma;
or meditava arguti versi e dolci
esili carmi, e si beava il cuore.
Qui mentre un dì cadea la neve a fiocchi,
dicono, entrò nella capanna trista
d'un re selvaggio. Largo il re, di latte
giovò gl'ignoti, e loro appose i frusti
d'uno stambecco. E la coorte in tanto
motti avventava contro il re dei monti,
gran cacciatore, e l'un mostrava all'altro
quel re seduto sulla panca al fuoco,
rugoso in fronte ed accigliato. Ed uno
disse: «E' mi pare il dio Cernunno, il dio
della ricchezza, con le corna in capo.»
Cesare, grave, disse allora: «Io primo
sia qui piuttosto che secondo in Roma!»
Regolo alpino, tu balzasti allora,
a un tratto, su, dalla massiccia panca.
Di nera luce ardevano al Romano
gli occhi mortali; dalle tue pupille,
splendeano ignude due cerulee spade.
Nel focolare arse più chiaro il fuoco,
vampeggiò, crepitò, fece faville.
E per le forre, con un'eco arcana
dell'infinito, a lungo mugliò una
raffica, come se parlasse il Tempo.
Allora avanti Cesare quel Gallo,
irto di peli il labbro, stette, e parve
grande del pari, ed esclamò: «L'augurio
accetto. Viva io qui tranquillo e pago
di questo regno povero, cacciando
i cervi, errando pei selvaggi monti,
fin ch'io non possa essere il primo in Roma!»
Risero tutti, sì, ma la lontana
posterità ventò sulla coorte,
quasi alitando i secoli futuri.
Cesare quindi una città di guerra
fece ai Taurini, e la munì di vallo,
e di due torri ornò le porte, e, cauto
dell'avvenire, i veterani astati
pose in questo romano accampamento,
forti coi forti. E la quadrangolare
città nel suolo si piantò, sicura
per le sue pietre e più per i suoi cuori.
A destra poi, per una grande porta,
badava ad ogni voce, ad ogni suono,
se udisse mai venire le coorti,
se un clangor, lungi, si levasse al vento,
frangesse il vento uno squillar di trombe,
la via strepesse al duro cuoio e ai chiodi
della legione, e Roma ritornasse:
o se, di tra gli stipiti rimasti
l'eterna fuga a contemplar degli anni,
s'avesse alfine a ritornare a Roma.
Fuggiva il tempo, e l'acqua dei due fiumi
fuggiva anch'ella, in grande oblìo di tutto.
Dalle sue porte la città spiava
i quattro venti, rivolgendo a un tratto
l'attento orecchio ognor dall'Alpi a Roma.
Ecco luccicar d'armi ampio e di schiere.
Ferro era tutto, che copria cavalli
e cavalieri, e tutto il piano era aspro
come di fulva ruggine di ferro.
- Romani voi? Partiti sì da Roma,
ma non Romani. Dove i pili e i valli?
Che v'appiattate sotto il fosco ferro? -
Ed altre schiere ecco venir dall'Alpi
traboccando dall'alto arco dell'ampia
porta d'Italia. Per il ciel sereno
in faccia ad essi era una bianca croce.
Stupore ebbe le genti, e il condottiere
- Prendi l'insegna della tua vittoria! -
udì. Vinsero in vero, e le lor brevi
spade la via trovarono del sangue
sotto le squamme, in mezzo al vostro cielo
restò, Taurini, quella bianca croce,
ora lucente nell'azzurro, ed ora
scialba, e da un triste nimbo incoronata;
finché quel segno fu dalla vittoria
ripreso in mano, quando, o Italia, forte
martire, Italia, delle genti, orlavi,
recando in alto la tua verde palma,
la veste bianca di purpureo sangue.
E Roma intanto dalle sette cime
era crollata, e dell'Esperia guasta
da ferro e fuoco, nulla più che l'ombra
era, del nome. E tempo corse, e il nome
anche svanì, come in un rogo immenso
ultima brilla e muore una favilla.
Duca era allora dei Taurini un uomo
di quei barbari, che nemici a Roma
avea la biondeggiante Elba mandati.
Il duca era partito per le liete
nozze del re, per le fiorenti mense.
Appena giunto era nell'aula: un tuono
rimbombò, subito, ed un lampo insieme
illuminò per l'aula le criniere
fulve e le barbe e le dense aste e l'azze
razzanti, e il re. Li scosse e impietrò tutti,
ed il palagio con un lungo rombo
scrollò. - Del re breve la vita e il regno!
Duca Agilulf, diremo noi tra breve
te re. - Queste parole e' le nascose
nel cuore, il duca, e ne ronzava il cuore
profondo. Ma non volsero molti anni:
furono vere. Né, concordi, a grida
sonore i duchi porsero a lui l'asta,
a lui dicendo di regnar su loro;
ma la regina fu che il regno e un colmo
calice, prima a fior di labbro attinto,
offerse a lui di rosso italo puro
vino, e gli disse: «Generose genti
come codesto vino vendemmiato,
Re Agilulf, su colli che il sole ama,
tu reggerai; ma l'arte dell'impero
è presso loro, e tu da lor l'apprendi.»
Fecero quindi un tempio. Era, sull'alba
dei secoli, uno errante nel deserto.
«Fate le vie» gridava, «e le spargete
di palme: l'Aspettato è per venire!»
Fecero a lui di marmo un tempio, e dono
posero, in esso una corona d'oro
fulgida, cui cingesse l'aspettato,
il re d'Italia ch'era omai per via.
Ma l'oro puro intorno inanellato
era di ferro, che già ferreo chiodo
fu della croce. - Oh! come tutto è vero!
Ma lo vedranno i secoli lontani.
Vero! Alla croce sarà reso il chiodo!
Vero! Al sovrano de' Taurini resa
sarà l'aurea corona. Egli su tutta
l'Italia re dominerà . L'Italia
renderà questi agli Itali e al destino.
Ma dopo lunghi secoli con molto
purpureo sangue, ma con fuoco e ferro! -
Allor col ferro impresero i Taurini
a perigliar la cara vita, e sempre
alla futura patria addimostrarsi,
in disventura ed in povertà , forti.
E sì pareano immemori del fato
e pur del nome e dei costumi antichi
e del linguaggio che fu già di Roma.
Né più le genti capo avean: l'augusta
città fatta straniera: e valli e monti
dell'armi ostili eran per tutto ingombri.
E tramontata era la sacra insegna,
né v'era alcuno che levarla al cielo
potesse ancora: Donno era lontano;
esilïato Donno era dalle Alpi.
Presso i due fiumi, come corpo morto,
come travolto da una gran valanga,
Toro progenitore, eri prostrato:
quando, Testa di ferro, tutto ferro,
alto levando, come alfier, la spada,
puntando ai fianchi del destrier gli sproni,
egli tornò. Tornava dall'esilio:
dalla vittoria. E il popolo Taurino
gridò: «Già viene! Ecco il signor con noi!
Vero il tuo nome dice Emanuele!»
Egli ristette e il suo cavallo immane
fermò, trasse le redini, e nascose
nella guaina la sua grande spada.
Non fosti tu, tu stesso, che, tre volte
volti cent'anni, la levasti al sole?
Grida di morte, grida di dolore,
in ogni tempo, d'ogni parte, al cuore
giungeano ardenti. Quel rapace drago
strisciava per la terra della sera,
tutto abbattendo, e il popolo le ingiuste
verghe provava e le superbe scuri
dei re tiranni. Sì, ma tu le udisti
quelle infinite grida di dolore,
la grande spada tu, d'un dì, snudasti,
la croce bianca tu, d'un dì, levasti.
Oltra Ticino, sommovesti all'armi
tutte le genti e le guidasti a guerra
ch'è santa e pia, se libera e redime.
Poi col tuo nome mille eroi due navi
salgono, e vanno all'isola che ...
[Pagina successiva]