LE CANZONI DI RE ENZIO, di Giovanni Pascoli - pagina 2
...
.
Quello che fummo e quello che saremo,
tranano i lenti e forti bovi al passo.
Carro, tu sei l'arca del nostro patto,
tu sei l'altare della nostra legge.
La messa e il vespro sovra te si canta,
squillano a morte di su te le trombe.
No, non con noi restano nelle chiese
i Santi d'oro: escono teco in campo!
Nemmeno i morti nei muffiti chiostri
sono con noi: vengono teco al sole!
Vengono ai tocchi della Martinella,
che suona all'alba, a sera, a morto, a gloria,
o bel Carroccio, o forza arte ricchezza
e libertà comune! -
V.
LE COMPAGNIE DELL'ARMI
Il popolo - ecco dalle quattro porte,
dai quattro venti, il popolo che viene.
Viene seguendo i quattro gonfaloni
coi quattro santi e con la rossa croce.
Hanno l'osbergo tutti e le gambiere,
hanno il roncone e la mannaia lombarda.
Hanno lasciato i ferri del lavoro
sull'oziosa incudine e sul banco,
e preso il ferro.
Vengono a cavallo,
guardando in su, cattani e valvassori,
domini e conti, in cui poder castella
son, del contado, ed, in città, tubate.
Son gli Andalò, signori di più terre,
con cinquecento servi della gleba,
Alberto de' Cazanimici grandi,
la mala volpe, ed Albari e Galluzzi
e il conte reo da Panico e il cattano
di Baragazza, i re della montagna,
ch'hanno il lor covo in venti castellacci,
e rubano alle strade.
Pensano i Grandi: «O buoni callegari
e bisilieri, non vi pesa in groppa
il nostro ferro? Il ferro a voi fa d'uopo
per ganci e graffi e raspe e seghe e morse.
L'azza...
vi resti, pei beccai per l'arti!
Ma quel ronciglio abbinlo i boattieri».
Il popol va, pensano ognuno e tutti:
«Conti, v'abbiam graffiato dagli scudi
l'orso e il leon rampante con la rosa,
e pinti su l'aquile nostre e i pardi.
Voi cavalcate dietro i gonfaloni
nostri, Colonna, Grifo, Angelo e Branca.
Ma voi covate sotto la gaiferia
astio tra voi, spregio per noi cattivi.
Tempo verrà che, ricchi noi, daremo
castella ai gufi e torri alle cornacchie.
Vi abbiamo preso l'azze e le corazze,
l'aste e gli scudi.
Verrà tempo, e forse
per l'armi vostre vi darem le nostre:
pettini, cardi ed aspi».
Vedono all'ombra dell'Arengo il carro
come galea ch'è per uscir dal porto.
S'alza il nitrito d'un cavallo al cielo.
Più ferreo tuona il passo de' pedoni.
I cavalieri, ognuno oblia sua parte:
Comazzo parla amico ad Uspinello.
«Chi pari a lui? Che Berte o Bertazzole!»
Un marangone, vecchio, delle Schize,
ricorda i tempi di vent'anni addietro,
che lo raddusse un angelo a Piumazzo.
«Egli parava i bovi con un fiore.
Fu l'anno che i cavalli ghibellini
bevvero al Reno: e che le manganelle
furono prese...» Un valvassore aggiunge:
«Ne restò una, che gittò l'altr'anno
l'asino...» Un riso corre grandi e plebe.
«Chi pari a te, Carroccio bianco e rosso?
Forse il Blancardo? Forse la Buira?
Quando ella va, con le sue vacche, intorno
gridando: Chi to' latte? «
Le lunghe spade ignude sulle spalle
sono i Lombardi ai lati del Carroccio.
Sembrano usciti allora da un convento,
d'aver giurato sopra l'evangelia;
aver negli occhi fiamme di covoni
e fumigare lento di macerie.
In lor città vedono andar l'aratro:
passa l'aratro e rompe ossa di morti.
Serpeggia il rovo dove fu la Chiesa,
l'edera monta dove fu l'Arengo.
Non hanno più la lor città di pietra:
questa di legno hanno, e ramenghi vanno.
Poservi su quanto è più dolce al mondo,
quanto è più sacro, quanto è suo per sempre.
Poservi il dritto, che vivente e sano
da fiamme e da rovine esce e da mucchi
di morti: il dritto della nuova Italia.
E però stanno ai mozzi delle ruote,
guardia e scorta, con le lunghe spade i
ignude sulle spalle.
VI.
IL PRIMO CARROCCIO
Che fu da prima? Il carro del convento,
che usciva ai campi, al tempo delle messi.
Squillava il suono della campanella,
per l'erme vie, con le cicale a gara.
Vennero al trebbio ove sostava il carro,
gli schiavi agresti col formento e l'orzo.
Vi si accoglieano i grami e nudi intorno,
come a sperare; e non sapean che cosa.
Sedeano a lungo, il viso tra le pugna,
quel suono udendo lontanar nel sole.
E poi tornò tra il canto degli uccelli,
un dì di maggio.
Era la terra in fiore.
La Martinella risonò nel nome di Dio,
che fece il servo e il valvassore.
Sonava a stormo, e i servi della gleba
corsero con le falci e con le ronche.
V'era un altare, dove ardea l'incenso;
salìa l'incenso e si mutava in nubi.
V'erano angeli con le lunghe trombe,
e dalle trombe vento uscì di guerra.
E poi fiammeggiò rosso nei carrobbi
della città, chiamando l'Arti all'armi.
«Le lancie in pugno, o voi che le foggiate!
Le spade in pugno, o voi che le temprate!
Voi che le torri a pietra a pietra alzate,
chi fa, disfà: gettate giù le torri!»
Venne la plebe antica.
Allato al carro
stava un uscito dall'oblìo dei tempi;
grande; come ombra al vespro ed all'aurora.
Parea che avesse i fasci con le scuri.
E poi tornò sotto il gran cielo il carro
fulgente d'armi.
Avea con sé gli artieri
e i ferrei conti e i sacerdoti assòrti:
il Popolo era, intorno al suo Carroccio.
La città era, che possente, augusta,
usciva con la Chiesa e con l'Arengo
e col suo Santo e col suo Dio; con tutto.
Giunta al nemico, ella dicea col bronzo
della sua squilla: - È presso te Milano,
che mutò luogo: al modo delle stelle.
-
E venne tempo, e patria sola il plaustro
restò.
Giaceva la città di pietra.
E il plaustro parve il Gran Carro di stelle
che intorno a un punto sempre va nel cielo.
Ma vennero altri plaustri, altre vaganti
città tranate dai muggenti bovi,
altri raminghi popoli.
Fu il mese
d'aprile, il mese che aprono le gemme.
Di fiori in boccia sorridea l'altare.
Le Martinelle sonavano a gloria.
E il doppio a festa si faceva immenso
e percotea nell'avvenir profondo.
Misto era a scrosci, a voci, a urla, a rombi.
Forse tonava sopra la Redorta.
Era d'aprile.
Il figlio della lupa
quel mese arò con la giovenca e il toro.
Era d'aprile.
Dalle tue macerie
nascean, Milano, l'erbe ancora e i fiori.
Vi aveva arato l'arator selvaggio:
dal solco fondo germinò l'Italia.
E fu l'Italia giovinetta, eterna,
su te, con te, Carroccio di Milano,
quel fin di maggio! Già sfiorian le rose.
Andava lento in val d'Olona il plaustro.
Il distruttore di città lo scorse:
gli si avventò coi cavalier di ferro,
ruppe le schiere, i sacri bovi attinse,
l'azza scagliò contro la sacra antenna.
Allor su lui con novecento spade,
splendide al sole, si gettò la Morte.
E quella sera il carro del convento,
il santo carro di Pontida, attese.
Reddiano stanchi i falciatori a vespro,
rossi di sangue, e rosso era di sangue
il carro, e i bovi, che muggian sommesso.
Ma il canto andava, delle trombe, al cielo.
Rosso era il cielo, che s'empìa di stelle.
Lucean le stelle ai morti.
In mezzo, eretto,
si riposava su l'enorme spada
Alberto da Giussano.
VII.
LA VIA EMILIA
Il Podestà coi giudici e' notari
scendono, in ricchi sciamiti velluti.
Vanno lor contra gli Anziani artieri:
lento è lor passo e lor parola è breve.
È scura omai la piazza di Bologna,
scura di ferro.
Al chiaro sol d'ottobre
lucono punte d'aste e di roncigli.
I gonfaloni tremano come ale
d'uccelli incerti di spiccare il volo.
Percuote l'ugna dei destrier le selci.
La gente ammira il suo Carroccio adorno:
i trombettieri con le lunghe trombe
in cui la guerra mugge come il mare
nella conchiglia; e i più valenti in guerra,
che ad uno ad uno son mostrati a dito,
gli ultimi, eletti a non morir che a sera;
e il sacerdote con pianeta e stola,
che deve a notte benedire i morti.
Le madri in capo alzano i bimbi, come anfore
andando al fonte.
Va! Che tu vada dove cade il sole
o il timon duro volga al sol che nasce,
va per la piana e larga via romana,
con sull'antenna il ramo dell'ulivo.
Non sei de' carri che seguiano a tergo
legioni mosse a propagar l'imperio,
non sei de' carri, ove dormian le donne
dei Goti scesi a metter fuoco a Roma.
Placido e forte per l'antica strada
va, che attraversa le città munite,
le città belle; ed erano già fòri e
còmpiti e quadrati accampamenti,
e vi sonò, misto alle gaie voci
rustiche, il grave accento dei triari.
Sorgon per tutto agili tremoli alti
pioppi del Po, scolte del re dei fiumi.
Nelle vigilie parlano tra loro,
sommessamente per la bianca strada,
che va sui ponti eterni dall'Eridano
a un Arco trionfale.
Strada non è, ma grande fiume anch'essa.
È la sua fonte appiedi d'una rupe
di Roma, presso il tempio di Saturno,
il vecchio Dio.
Nasce a una pietra d'oro.
E prima specchia urne d'antichi morti,
di cui non sanno che i cipressi il nome!
Poi sbocca ai campi, sale ai monti, fende
le roccie, inoltra per le sacre selve;
finché dall'Arco del trionfo sgorga,
Po, nel tuo regno, ch'ha per guaite i pioppi.
Né più ravvisa le città d'un tempo.
Ora riflette aspri serragli, torri
merlate, cerchi di massicce mura
e chiese ed inquieti battifredi.
Tutto è mutato.
Pure il sacro fiume
che nasce appiè del Campidoglio, ancora
porta notturno le memorie a flutti
con cupa romba...
Va pel fiume eterno,
o nave nostra, con la vela nuova
all'albero maestro!
Non per un fiume; per un mar tu varchi,
nave fornita d'ogni fornimento
per il passaggio.
Un mare ti circonda,
uguale, immenso, e sempre a gli occhi ondeggia:
un mare biondo e tremulo di spighe
d'onde s'esala già l'odor del pane,
un rosso mare di trifoglio, un mare
verde di folta canapa, un celeste
mare di lino, cielo sotto cielo,
e bianche in mezzo nuotano le culle.
E varca, o nave, pel fecondo mare
che muta vista ogni filar di viti,
tra cui si spande il pero e il pesco, e il melo
colora i pomi del color dei fiori.
E ti saluti, non la procellaria,
bensì la quaglia che tra il grano ha il nido.
E i bimbi ver' te strillino, e dai solchi
parlino a te col lieto muglio i bovi.
E gioia all'alba dica, e dica a sera
pace, la Martinella.
VIII.
IL RE
Ma uno squillo suona al ciel, di guerra,
come uno strillo d'aquila sul monte.
I cavalieri levano la spada
ed i gonfalonieri il gonfalone.
Levano il duro pungolo i biolchi,
e i trombettieri imboccano le trombe.
Tutti si son branditi dentro l'arme.
Per tutto è corso un brivido di ferro.
Spiccia dagli occhi a donne e vecchi il pianto.
Sboccia tra i labbri de' fanciulli un grido.
O patria! O grande, forte, unica! I cuori
sbalzano al primo cigolìo di ruote,
già; quando gli occhi dei fanciulli, quando
le donne e i vecchi, quando tutti, a piedi
ed a cavallo, con le trombe in bocca,
coi gonfaloni, con le spade in mano
o sulle spalle, e i pungoli e le lancie,
tutti, ma uno, in suo pensiero, ognuno,
come ad un cenno, nel silenzio grande,
si volgono all'Arengo.
Pare che passi un soffio di grandi ale.
Forse è il lor tacito ànsito che s'alza.
Premono in cuore l'ululo i biolchi,
i trombettieri tengono lo squillo.
I cavalieri appoggiano alle groppe
de' lor cavalli la ferrata mano.
Son tutti gli occhi volti in su, son volti
tutti ad una finestra dell'Arengo.
Non più diritte sono lancie e spade:
mandano un vario scintillìo confuso.
Alla finestra è il vinto di Fossalta,
il Re.
Gli luce d'oro il capo, i biondi
capelli istesi insino alla cintura.
Guarda il Carroccio coi grandi occhi azzurri,
là in mezzo al duro mareggiar del ferro.
Guarda la rossa croce sull'antenna.
Re Enzio sta, come sulle rembate
d'una galea.
Sotto, gli fiotta il mare;
e il vento salso gli enfia le narici
e tra i capelli fischia...
È l'ànsito del Popolo, che passa
come un gran vento tra la sua criniera
fulva.
Il leone vivo del Comune.
il bello e forte suo leone in gabbia,
esso è.
Ma esso ha ben fratelli al mondo,
ch'escono armati d'oro come stelle,
dalla serenità di Federigo
Cesare Augusto! O nati dall'Aguglia!
O re Currado! O principe Manfredi!
O dritti stanti a guardia dell'impero
giovani figli dell'imperatore!
E conti e duchi e principi e landgravi
tutti d'un sangue! Dritto sta re Enzio,
re di Sardegna e di Gallura e Torri,
conte degli aspri monti del Mollese,
e delle cupe selve in Val di Serchio,
e delle terre apriche al Mar di Luni,
signor della Versilia e di Varresso.
Gli occhi del Re s'incontrano con gli occhi
del Popolo, in silenzio.
E scoppia acuto il suono delle trombe,
e grave romba il suon delle campane,
e vi si mesce il grido de' fanciulli
e le femminee voci di preghiera;
e i cavalieri spronano, e i cavalli
partono sfavillando sulle selci,
e i duri artieri partono col croscio
della gragnola; e tutti i gonfaloni
tremano al vento, e tutte l'armi al passo
dànno bagliori, e ferro è che si muove,
ferro che va con un clangor di magli
su forti ancudi da cui raggia il fuoco:
e i bovi il capo curvano alle grida
del lor biolco, e tirano, e il Carroccio
va: crolla, crolla, la sublime antenna,
e la bandiera si disnoda in cielo.
Suonano in cielo tutte le campane
sopra il Carroccio.
È la città che parte:
parte levando un lento aereo canto
con tutte le sue torri.
IX.
I PRIGIONI
Volge all'occaso, volge a Porta Stiera,
volge il Carroccio per la via del sangue.
Non trenta volte trenta dì son corsi
da che re Enzio combatté, fu preso,
per quella via, come un astor maniero
preso alla pania.
Or ei ricorda il giorno
che passo passo in groppa d'un muletto
seguì quel carro e i bovi dell'aratro.
O sacro impero! O aquile di Roma!
Ma Enzio a un tratto si riscuote, e parla.
Parla a Marino d'Ebulo, a Currado
di Solimburgo ora loquace or muto.
Siede cruccioso Buoso da Dovara.
«Credete voi che dorma la possanza
del sacro impero?» Il conte apre la bocca.
Buoso tentenna il capo e non risponde.
S'odono i duri passi de' custodi
fuor delle porte, e il busso de' ronconi
sul pavimento.
La città par vuota.
Esclama il Re: «No: veglia!»
Dalla città par la città lontana.
Non s'ode più di tante squille e trombe
che una campana, e il busso de' ronconi
sul pavimento e il passo de' custodi.
Aggiunge il Re: «Per una nube credi,
o Buoso, tu, non sia più cielo il cielo?»
Tentenna il capo Buoso da Dovara.
«Conte Currado, ben mio padre ha detto,
come tu sai, bene il sereno Augusto
scrisse: - Faceste corna, o voi, di ferro,
con cui credete ventilare il mondo!
Alcuno ascese per cader più d'alto.
Voi fate feste e vanti coi fratelli
vostri Lombardi: ripensate al nostro
grande avo; addimandatene i fratelli...
-
Conte, e' le corna frangerà di ferro!»
Il conte un poco apre le labbra, e tace.
Stanno i custodi, è ferma la campana.
Non s'ode più che il paternostro, in piazza,
d'un cieco senza guida.
Enzio a sé ode i battiti del cuore.
Pensa a suo padre.
Federigo Augusto
è come Dio, tacito sì ma insonne.
Forse e' s'aggira col possente stuolo
presso la cerchia di città ribelli.
Cesare in armi scorre per l'impero.
Vengono al suon de' timpani gli arcieri
arabi snelli, e grandi cavalieri
monaci assòrti ne' lor tetri voti;
Normanni biondi della Conca d'oro
con gli occhi incerti tra verzieri e fiordi;
conti e cattani scesi d'Apennino,
e col suo stormo cavalcando chiuso,
solo Ecellino; e leopardi e tigri,
e con l'andar di nave i dromedari,
e il leofante con la torre quadra
da cui s'alza il vessillo imperiale
con la grande aquila; e l'imperatore.
Egli cavalca, né tristo né lieto,
con un gerfalco al pugno.
Enzio a sé ode i battiti del cuore
giovane.
- E s'Egli fosse alla Scultenna?
Se campeggiasse intorno alla Fossalta?
volesse su quella oste di manenti
trar sua vendetta dove fu lor vanto?
Sono, in lor cieca oltracotanza, in campo
forse ora usciti per sentor che ne hanno...
- Ed Enzio parla: «Or di', conte Currado
di Solimburgo! Se d'un tratto, andando
coi tardi bovi e i tardi artieri il carro,
l'oste sentisse sibilar le freccie
dei Saracini, rimbombar l'assalto
dei cavalieri, calar mazze e spade
ed azze e lancie, ed apparir, ruggendo,
il nero capo d'Ecellin d'Onara,
e stormi e stormi correre in tempesta
sopra il Carroccio, e d'ogni parte il grido
alzarsi: Roma! Roma! Imperatore!...»
«Ma egli è morto,» grida il conte: «morto
morto, l'Imperatore!»
X.
L'IMPERATORE
Sì.
Egli dorme in una Cattedrale,
entro l'eterno porfido dell'arca.
E' non sa più di stormi e cavalcate,
e' non sa più di timpani e di trombe,
nel dolce tempo quando foglia e fiora,
ch'egli tendea nei prati i padiglioni.
Non più dai geti libera l'astore,
delle canzoni perse il motto e il suono.
Non suono più di corni o di leuti,
ma pii bisbigli e il canto della messa.
Anche ha dimenticato gli anatemi,
e il bando a lui nel giorno dell'ulivo,
e i giorni d'ira, i giorni di sventura
coi ceri accesi e le campane a festa.
Dorme nell'arca rossa l'Anticristo
nato alla vecchia monaca, e nudrito
da sette preti.
Presso, il mare aspira
col lento succhio tutto il cielo azzurro:
al cielo dà Gennet-ol-ardh l'olezzo
dei cedri e delle rose.
Al morto grande imperador di Roma
dissero pace i vescovi di Cristo.
Di lui parlò 'l rabbino al Dio d'Abramo,
a braccia spante volto all'Oriente.
Per lui, girando attorno al minareto,
le cinque volte il muezzin cantò.
Or egli giace nell'oscura cripta,
coi mali e i buoni.
Oh! avessero favella!
Direbbe forse alcuno dal sepolcro:
- Qual sei disceso presso noi Ruggero?
Noi padre il vento e madre avemmo l'onda.
-
Risponderebbe: - O figli di Vikinghi!
Anch'io fui vento, figlio anch'io di vento!
Né Skaldo mai cantò sull'arpa un canto
più grande e bello, né più bello e grande
mondo mai vide Re del mare in corsa,
del sogno mio...
- Ma più non ha favella
ora, e il coperchio è sceso omai per sempre
sull'arca fiammeggiante.
Dorme, ma i sogni non saprà narrare,
s'egli pur sogna, e si ritrova a Roma
sulla quadriga di cavalli bianchi
per la Via Sacra andando al Campidoglio.
Placato è il Mondo.
Seguono, al guinzaglio,
Cesare Augusto leopardi e tigri,
vengono sopra il dosso d'elefanti
l'armi e i trofei delle città ribelli...
O lascia il Mondo veleggiando al Regno
santo di Dio.
Distendono le vesti
e ramuscelli per le vie, ch'e' viene.
Cantano Osanna! Osanna negli eccelsi!
Tutti hanno in mano i rami delle palme.
Cristo ritorna al suo sepolcro vuoto.
Cristo ritorna a dare la sua pace.
Sta sulle porte di Gerusalemme.
Sta tra le nubi.
Ha virtù molta e gloria.
Gli angeli a lui congregano le genti
dai quattro venti; ch'Egli a tutti franga
il pane, e mesca il vino.
Ma col dormente è il sogno suo sepolto,
tra il Mondo e Dio, nell'isola del Sole.
Ed una voce è corsa per la terra,
che quella è stata l'ultima possanza,
l'ultima vasta raffica di vento
che dileguò lasciando ansante il mare.
Forse la voce viene dal profeta
che ha barba grigia come vecchio musco,
dal vecchio bardo errante nella selva
di quercie brulle in cui verdeggia il vischio.
E poi verrà chi povero e ramingo,
errante anch'esso in un'antica selva,
nei luoghi dove spento fu, la prima
volta, l'imperio, sognerà quel sogno
che tace là sepolto dentro l'arca.
La selva sta, sublime cattedrale,
su mille e mille aeree colonne.
E il peregrino v'ode il soffio eterno
dell'Infinito, che lo tocca in fronte
come soave vento..
XI.
IL PAPA
E il vento soffia, dell'autunno, e stacca
le foglie ai pioppi della strada e a gli olmi,
di quando in quando.
Cadono le foglie
stridule sopra le armi e sul Carroccio.
Ecco e il Carroccio e il Popolo s'arresta;
e lancie e spade sono volte a terra.
Sonate, o trombe! Squilla, o Martinella!
Inchina a lui la pertica il Carroccio.
Son là di contro i sacerdoti rossi,
vescovi, preti, diaconi di Roma.
Guatano appena, parlano tra loro
sommesso e grave, o coi marchesi e conti
lor lancie e spade.
Vinsero.
Per loro
Dio combatté.
La fronte atterra e gli occhi
muto solleva il Popolo di ferro,
lassando i suoi ronconi e talavazzi.
Tra il rosso delle porpore, tra il lampo
d'armi dorate, alto tra terra e cielo,
in faccia a lui ravvolto nel suo pallio,
è, tacito, il Gran Prete.
È il successore di Simon Bar Iona
che a Gesù disse primo: «Tu se' Cristo!»
di Pietro a cui lasciò le chiavi in terra,
del cielo, il Dio che ritornava al cielo.
È il Cristo che rimuore e che risorge
perennemente, è il Cristo del Signore,
l'Unto nel capo, il Verbo che rimase
in terra Carne, e che tra noi dimora.
Di qua da Dio, di là dall'Uomo, è l'Uno
degli invisibili angeli più grande,
poi ch'egli in terra è giudice del cielo,
dei Troni e delle Dominazioni.
É il Dio che Dio creò su Faraone
dal duro cuore, e lo mandò coi segni
del suo giudicio, e gli affidò la verga
che si fa serpe e si disnoda e fischia
appiè dei re; che dove si distende,
i laghi in sangue, muta i fiumi in sangue,
ogni acqua in sangue, e nella terra intiera
fa che non sia che sangue.
Ora il Gran Prete alza la mano, e parla:
«La terra esulta e si rallegra il cielo:
dov'è colui ch'era nemico al Cristo?
dov'è il gigante di Babel, possente
in faccia a Dio, saettator dei giusti?
dove il Nerone, dove il nuovo Erode?
dove il Soldano me' che imperadore?
Scendeva un maglio ad or ad or sul mondo.
Non s'ode più.
Cadde di mano al Fabbro.
Spada di Pietro, lancia di Maurizio,
e' si voltò contro la Croce e Pietro.
E Dio lo franse.
Egli dovea le notti
schiarar, del sonno e degli errori, Luna,
che da noi Sole ha, quant'ella ha, di luce;
né volle; e invase, ombra deforme, il giorno.
La notte eterna or lo riprese e cinse.
Noi pose in Roma trionfal suo carro
Dio! Pose a noi Dio stesso nelle mani
destra e sinistra, le due briglie lunghe
del cielo e della terra!»
Torna il Carroccio e il Popolo nel chiaro
lume d'ottobre.
Splendono le rosse
pampane intorno, splendono le vesti
rosse e l'argento delle curve mazze.
Dice Innocenzio: «E voi sterpate il seme
del reo Nembròd ch'e' non rimetta ancora».
Dice Innocenzio: «Buoso da Dovara
vuo' che da voi, per amor mio, sia sciolto».
E un Anziano: «Noi teniam due terre
di Santa Chiesa.
Averle amiamo in dono».
«No» dice il Papa.
Alcun de' Lambertazzi
stringe più forte il pomo della spada.
Presso è Bologna; e già si son rideste,
tra grida e canti, tutte le campane.
Splende lassù, per un momento, a oro,
nel sol morente il capo del re Enzio.
Poi cala il grido e il murmure: poi cessa.
Parla ai biolchi, tetri, sulla porta,
ilare Zuam.
Mugliano stanchi i bovi
appiedi dell'Arengo.
LE CANZONI DI RE ENZIO
II°
LIBERTÀ!
SALE SUL DESCO SANGUE NEL CUORE ARIA DELL'ANIMA
SOLA PACIFICATRICE DEGLI UMANI
PERCHÈ SOLA NE SCOPRI NE RIVELI NE CONSACRI
LA SOMIGLIANZA FRATERNA
O SIMILE A COLEI CHE ALCUNO IN SOGNO PIANGE LONTANA
E TU GLI DORMI FLORIDA MOGLIE ACCANTO
O TU PER CUI SI MUORE CON GIOIA
PERCHÉ MORIRE È RIACQUISTARTI PERDUTA
LIBERTÀ
LA CANZONE DEL PARADISO
I.
IL BIROCCIO
I bovi per l'erbita cavedagna
portano all'aia sul biroccio il grano.
Passa il biroccio tra le viti e li olmi,
con l'ampie brasche, pieno di covoni.
Sotto i covoni va nascoso il carro,
muovono i bovi all'ombra delle spighe.
La messe torna donde partì seme,
da sé ritorna all'aia ed alle cerchie.
I mietitori ai lati del biroccio
vanno accaldati, le falciole a cinta.
Sul mucchio, in cima, un bel fantino ignudo.
Tre vecchi gravi seguono il biroccio,
i tre fratelli, un bianco, un grigio, un bruno.
Ma di lontano, dalle gialle stoppie,
un canto viene di spigolatrici.
Sola comincia Flor d'uliva il canto,
poi le altre schiave alzano un grido in coro:
Sette anni planse, oimè sett'anni sani,
e scalza andava, un vinco in ne le mani.
Pecore e capre aveva entorno, e' cani.
Sette anni, oimè taupina sclava,
sett'anni planse: un dì, cantava...
Passava un cavaleri de la crose,
sentì lassù la dolze clara vose,
ligò 'l cavallo cum la brillia a un nose:
«Vosina clara como argento,
sett'anni è sì, che no te sento...
«
Son tra i pioli i ben legati fasci,
le spighe in dentro, e sovra il mucchio d'oro
che va da sé, siede il fantino e ride.
Ride gettando i fiordalisi in aria
e le rosette: al piccolo di casa
mandano a gara, uomini e donne, un motto,
mandano a prova, verle e quaglie, un suono.
Parlano i vecchi, i tre fratelli, insieme.
E l'uno parla, e dice: «Arregidore,
ben Vidaliagla si può dir granaro».
E l'altro parla, e dice: «Campagnolo,
la terra è buona, ma voi meglio siete;
voi, meglio, e i bovi del fratel Biolco».
Tace il Biolco, ma s'allegra in cuore.
E più lontano viene dalle stoppie
il canto tristo.
Flor d'uliva intuona:
seguono l'altre, ch'oggi sono ad opra:
Ligò 'l cavallo, e se li fece avanti.
«Deh! pasturella, Deo te guardi e' Santi.
Mangiasti bene, così gaia tu canti!»
«Vui dite, la Deo gratia, vero:
mangiammo, e' cani et eo, pan nero».
El cavaleri la mirò cum dollia.
«Ne' to' cavelli sempre 'l vento brollia,
lassa tra' rizzi l'erba 'l fior la follia».
«El vento no, non è, meo Sire:
è che nel feno aio a dormire...
«
Fermo è il biroccio.
Al bel fantino stende
le mani, e d'alto lo raccoglie in collo,
la prima nuora; e gli uomini e le donne
prendono i fasci e fanno il cavaglione.
L'Arregidore dice al Campagnolo:
«Spighe segate e manipelli a bica
di rado o mai Santo Zuanne ha visti».
Dice il Biolco: «E seghisi la stoppia
prima che piova, non la terra v'entri!»
E il Campagnolo: «E tosto ariamo.
Arare
tre volte è bene, quattro volte è meglio».
...
[Pagina successiva]

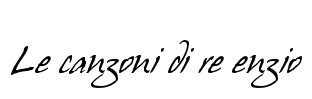 Libri online
Libri online