LE CANZONI DI RE ENZIO, di Giovanni Pascoli - pagina 5
...
.
Li può bollare nella faccia il donno,
legar li può sul cavalletto al sole,
onti di miele, e tôrre lor la vita,
oh! senza libertà non cara...»
Più forte vento urta le foglie, squassa
li alberi, tutto agita il bosco, e passa.
Fatto silenzio, alto e soave parla
il Podestà: «Dunque in onor del Cristo,
e della Madre, ed in onore e prode
della Città del Popolo e Comune,
piacciavi: quei che vivono e vivranno,
dentro le mura e fuori delle mura,
e ora e sempre, liberi sien tutti,
e sia la loro libertà difesa
dalla Città dal Popolo e Comune.
E niuno, laico o clerico, più osi
muover quistione ad affermar che alcuno
sia servo o serva della sua masnada.
E niuno più porti sul collo il giogo,
o lieve o grave, o legno o ferro».
VI.
IL PARADISO
E sorge il savio Rolandino, e parla:
«Dio, l'uomo all'uomo toglie a forza il dono
che come padre che partisce il pane
tra i figli, giusto hai tu tra noi diviso:
la libertà.
Ché, come volse i passi
altrove il padre, ecco il fratello grande
strappa il suo pane al piccolo fratello.
Ma tu, Dio, vedi, e vieni, e togli, e rendi.
Nel suo giardino, nel suo monte santo,
Dio pose l'Uomo.
Con l'eterne mani
vi avea dal cielo trapiantato i rami
de li odoriferi alberi, e gettato
i semi colti nelle stelle d'oro.
E v'era in mezzo una fontana viva
che l'irrigava, donde escono i fiumi
Gehon Phison Euphrate e Tigris.
Dio pose l'Uomo, libero, nel santo
suo Paradiso.
- Opera - disse - e godi -;
non disse: - Opera e piangi, opera e impreca.
-
Aveva allora, il placido ortolano
di Dio, soavi pomi per suo cibo,
per sua bevanda acqua più dolce a bere,
d'ogni dolcezza; e facile il lavoro
come il trastullo; e lo seguian li uccelli
con l'alie rosse, all'ombra delle foglie
tremule, lungo il mormorìo d'un rivo.
Tutto era luce, tutto odore e canto.
Ferìa la fronte ove sudor non era,
un'aura uguale; e pur movendo, l'Uomo,
su questa terra, era sì presso al cielo,
che udiva il caro suono delle sfere,
che si volgeano eternamente.
Ei fu cacciato, e fuori errò meschino
e doloroso.
E Seth il buono, un giorno,
venne al Cherub che a guardia era dell'orto
di Dio, dov'ora non vivean che uccelli.
Moriva l'Uomo; e l'Angiolo al buon figlio
un grano diede, ch'e' ponesse al morto
sotto la lingua; ed era della pianta
di cui suo padre avea mangiato il pomo;
e Seth sì fece, e seppellì suo padre,
col grano in bocca: e di quel seme un grande
albero sorse; e dopo mille e mille
anni seccò.
Gli diedero la scure
alle radici, e il tronco giacque.
Un giorno vennero i fabri, e recidean due legni
dal tronco, e insieme li giungean nel mezzo,
tra loro opposti.
E fu la Croce.
L'albero, ch'era in mezzo al Paradiso,
sorse d'allora in mezzo della terra.
Fu tutto il mondo l'orto di Dio chiuso.
I quattro fiumi lo partian; ma ora
moveano rossi sotto il cielo azzurro.
Uomo, lavora e canta! Or ti sovvenga
dei canti uditi nella grande aurora
dell'universo.
È tuo fratello il sole.
La terra, tu la solchi, ella t'abbraccia,
ché voi vi amate.
Abbi il sudor sul volto,
ma come la rugiada sopra il fiore.
Sia l'arte buona presso te.
Lavora
libero.
Tutto ora vedrai ch'è buono
ciò che tu fai, come vedea, creando,
Dio.
Cogli i fiori e fattene ghirlanda,
o uomo, all'ombra della Croce!
O Croce rossa, rossa come il sangue
sparso da Dio, Croce per cui vincemmo,
cauta nel monastero di Pontida,
alto schioccante sul Carroccio ai venti,
o Croce tratta da' placidi bovi
tra spade e lancie, tra le grida e il sangue;
o Croce nostra, noi di te siam degni.
Questo Comune, ch'ha interrotto il vento
imperiale, ch'ha spezzato l'arco
di Federigo, ch'ha gittato il rugghio
solo tra i tanti, ch'ha recinto al fianco,
non targa e scudo, ma cultello e spada,
il suo diritto, ora, di tutti il primo,
adempia il verbo, e dica a tutti il vero:
che il Redentore ancor non è là, dove
ancor non è la libertà!»
VII.
LA LIBERTÀ
Libertà! Su, sbalzano l'Arti e l'Armi,
stanno i Seicento, stanno i Cinquecento,
tendono, stanti, i Consoli le braccia
verso il Consiglio.
Alzano tutti il grido,
Libertà!, grido delle lor battaglie.
Vedono in cuore le assolate strade,
biechi torrazzi, torvi battifolli.
Ecco il lontano canto delle trombe,
ecco il tuon delle torme de' cavalli,
scroscio di lancie, sibili di freccie,
ferro su ferro, spade contro spade,
il martellar d'una fucina immensa,
e il rugginoso anelito, e il singhiozzo
del sangue, e il chiaro alto latino squillo,
Libertà! sempre, Libertà! tra il rauco
latrar di teutoni e schiavoni.
Libertà! L'hanno essi difesa in campo
più che la vita, come la lor fede;
meglio che il dritto, come il lor dovere;
nel suo quel d'altri; libertà per tutti.
Ché né è d'uno, se non è di tutti.
Stante il Consiglio del Comune augusto
tende le braccia, come al giuramento,
tende le mani, come con le spade.
Oh! bel Comune, condurrai tu primo
quei che già venne e non si vede ancora.
Da tanto aspetta fuori delle porte,
e vuole entrare e vuol mangiar la Pasqua.
Egli è vicino, e mansueto aspetta,
seduto presso l'asina legata,
in ermo luogo, e il suo polledro a volte
lo guarda, e torna a brucar l'erba.
Andrem per Lui coi bovi bianchi e rossi
e col Carroccio, e cingeremo in armi
popolo santo l'ara nostra e l'arca.
Sarà la croce in alto sull'antenna,
saranno ai mozzi le lucenti spade.
Ci fermeremo tra il pulverulento
scalpitamento de' cavalli ansanti,
mentre i placidi bovi muggiranno.
Egli, il Dio vero, l'Uomo Dio, soave,
ci dirà pace, ci dirà: Son io.
- Vieni con noi, vieni a mangiar la Pasqua,
siediti a mensa, ché l'agnello è pronto.
Non ha tra noi maggiore né minore.
Tu non volevi né mangiar l'agnello
né bere il vino, prima che il tuo regno
venisse in terra: ecco, è venuto.
-
Libertà! Noi lo condurremo, il Cristo,
al suono vago della Martinella.
Lo condurremo nelle aperte piazze,
dove è pur lunga l'ombra delle torri,
al monte, al piano, sotto le castella
covi di falchi, presso i monasteri
ricchi di grasce; nelle chiese il Cristo
noi condurremo.
Cedano i serragli!
Le porte aprite! Alzate i ponti! Ei viene.
Niuno ritenga ciò che fu ricompro:
è qui Colui che n'ha disborso il prezzo:
Dio! Viene al suono della Martinella,
al nostro grido, sul Carroccio nostro.
Fatevi incontro, a lui gettate i rami
d'uliva, a lui stendete le schiavine
per terra, a lui gridate, Hosanna!
Libertà! Posa il grido qual del rombo
d'un branco in cielo un cinguettìo rimane
minuto in terra.
Sono tutti gli occhi
pieni d'una lontana visione.
È il Paradiso.
Non vi son manenti
od arimanni.
Ogni uomo è uomo.
Ogni uomo ha la sua donna, i figli suoi, la casa
sua.
Sbalza lieto dai tuguri il fumo.
S'ode una voce ch'è nel cuore, e sembra
quella di Dio, quale s'udiva allora:
- Fa ciò che vuoi: non puoi voler che il bene! -
Fuori è il serpente e sibila notturno.
Fuori è il nemico, e vien alto come onda
che muore al lido.
Avanti il Paradiso
resta il Cherub che v'era già: vi resta
a guardia della Libertà.
VIII.
LA BUONA NOVELLA
Va tra le torri, suona nelle piazze,
passa tra i pioppi, sale tra i castagni,
vola tra i faggi la novella buona.
La notte cade, s'avvicina il giorno.
A lui che viene, andate, o genti, incontro.
Vien col Comune e Popolo.
Egli spese
il sangue già per ricomprare i servi;
tutto il suo sangue: ora, dimesso, aggiunge
i trenta sicli, suo valsente.
I trenta sicli, suo valsente in terra,
aggiunge al sangue.
Si riscatti il capo
d'anni oltre sette e sette, dieci libbre
di bolognini; otto il minore: è giusto.
Prendete il prezzo delle mandre umane,
dei greggi, ahimè! che parlano.
S'avanza
coi sicli in mano e col costato aperto
il Redentore...
Il popolo gli è intorno
con gli spontoni e coi ronconi.
Soffia nel corno, o guaita della torre;
desta il palagio irto di merli, aduna
nella tubata i servi con le ancelle.
In vano il prete vi spruzzò sul capo
l'acqua lustrale e vi soffiò negli occhi
e v'unse d'olio.
Voi non rinasceste.
Ora il Comune e Popolo vi scioglie,
v'alita il nuovo spirito, vi tuffa
nel fiume purificatore.
Tu che nel battifredo del convento
suoni compieta, onde s'attrista il cuore
del peregrino, ché quel suon lontano
ciò gli ricorda ch'è vie più lontano:
a festa suona, per Gesù risorto.
Monaci salmeggianti, Egli è risorto,
e viene a tôrre i figli suoi, che i campi
v'arano e l'orto zappano e la legna
gemendo tagliano nel bosco.
Voi che nei torracchioni del castello
vegliate in armi tra il guattir dei falchi,
biondi arimanni, servi di masnada:
in libertà, mastini alla catena
del valvassore! Siate falchi: è meglio.
Via, biondi falchi, dal castello al bosco!
E della vostra fiera gioia empite
la solitudine dell'aria.
Fuochi di gioia, ardete sulle cime!
Dov'ora sola la Limentra scroscia
e muglia il Reno, e il vento urta nei faggi
simile a un folle, fumeranno grigi,
in mezzo all'albeggiare della neve,
nuovi tuguri.
E v'arderà perenne
sul focolare il figlio di due selci
battute sopra un'ara dalle grandi
silenti vergini di Roma.
Fuochi di gioia, ardete in mezzo all'aie
delle pianure! Ché non più, seguendo,
la stiva in mano, i due gementi bovi,
l'uomo dirà: - L'aratro, i bovi e l'uomo,
son tutti cosa che si compra e vende.
-
La sfogliatrice non dirà sfogliando:
- Di qui né io né l'olmo può partire:
olmo, bell'olmo, noi ci somigliamo.
Io canto, anche tu canti, al vento.
-
O sfogliatrice che canti sull'olmo,
come un uccello, quando cade il sole,
scendi; tu puoi partire, anche restare:
all'osilino alcuno avrì l'usolo.
Il drago è morto, o Santa Filumena;
più non ti mangia al fine della tela.
Non planzer più: torna 'l to Sire: canta!
Specchiati nelle lacrime ch'hai sparse,
e va', ti lava alla fontana.
Va Flor d'uliva in Savena la verde:
in un boschetto si mette ad andare.
Scioglie i capelli, lascia giù le vesti,
scende nel rio, tutta si spruzza d'acqua.
E l'oseletto udì cantare un poco,
piano e segreto, che nessun l'udisse.
Ma ella intese ch'era 'l lusignolo
di caiba uscito e ritornato al broilo,
all'acqua, al verde, all'ombra,
al sole, al sole et all'amore.
IX.
LUSIGNOLO E FALCONELLO
Or ella va con la canestra in capo,
lungo la verde Savena, ai serragli,
alle aspre porte, alla città turrita,
recando l'uva paradisa, d'oro.
Ora non canta: canta sì la verla;
fischiano sì le pispole di passo;
anco le rondini: elle vanno in branco
dolce garrendo a ripulirsi al fiume.
Vede ella i meli rosseggiar di pomi,
vede curvare i peri a terra i rami;
l'api bombire, ode ronzar le vespe
e i calabroni in mezzo al dolce fico.
Ella non canta, ma le canta il cuore,
che c'era un re ch'era di giorno un uomo,
ma diventava capougello a sera;
volava allora ai boschi ai campi ai fiumi.
E Flor d'uliva lo sapea, ché sempre,
sull'imbrunire, qua e là, sentiva
parlar più forte, tutti insieme, a gara,
perché piatìano innanzi al re, gli uccelli.
In cuore ha il re, ch'ora ha rimesso l'alie,
per certo, e vola al regno suo lontano,
al suo castello in mezzo al mare azzurro,
il falconello, e il cielo empie di gioia.
O forse è là, tra i suoi cavelli d'oro,
in mezzo ai conti, ch'hanno il pugno al mento,
che dorme per incantamento...
E Flor d'uliva giunge al limitare,
all'alte scale del Palagio nuovo;
e qui Zuam Toso la sogguarda e dice:
«Già t'ho, ricordo, a Santo Zuam, veduta».
«Eo son Lucia, ma detta Flor d'uliva,
da Vidaliagla» ella risponde: «sclava
non più, misèr, sì libera...» «Va, dunque.
Scritto è 'l to nome già nel Paradiso».
Ella non sa: monta le scale, ed entra,
da niuno vista, dove alle pareti
stanno addossati i muti cavalieri.
Stante, in un raggio è fiso il Re, di sole.
E Flor d'uliva presso a lui depone
la sua canestra, e scopre dalle arsite
pampane i cerei grappoli dell'uva,
tacitamente.
Ed ha il corollo in capo.
Il Re si volge a lei che aspetta e tace,
con sui morati riccioli le rosse
pampane; l'uva al piè si vede; e guarda
lei.
Gli occhi neri scontrano gli azzurri.
«Deh! forosella, eo già te vidi 'n sogno,
ch'ero addormito, e tu portasti fiori
et erbe e frutta.
Et eo sognavo un campo
grande, di grano.
E da le folte spighe
spuntavi, come un flore, tu; vestita
non più che un fiore.
E c'era il sole e il vento,
e l'ire o stare a suo talento».
Re Enzio prende un grappolo dorato,
e dolcemente gli acini ne spicca,
zuppi di sole.
E poi riguarda e dice:
«Apersi gli ocli ma tu plu non c'eri.
Seppi, qual eri.
Io prigionier, tu sclava».
E Flor d'uliva: «Ora non plu! Riebbi
la libertà...
Non anco vui, meo Sire?»
Ed Enzio dice: «Eo m'era il Falconello
d'un tempo: aveva il vento tra i cavelli
e il sole entorno.
Apersi li ocli un tratto:
non c'eri plu...» «Ma sono a vui tornata».
Ed Enzio dice: «Or viemmi dietro e taci».
E s'incammina ver' la sua cellata:
dietro ai suoi passi muove Flor d'uliva:
segue il Re morto, uscito dal lavello,
pallido, sì, che v'era da sette anni,
et or la schiava va con lui che l'ama.
L'ha tanto amato, e notte e giorno ha pianto;
tre notti e giorni sotto l'arcipresso,
mescendo a gara, più della fontana.
Or è con lui nel grande suo palagio.
Nullo divieto i giovani custodi
fanno, per la dolcezza del lor sangue.
Dicono: «E noi sediamo a tavoliere».
«Ben ha ghermito» dice Bonfiliolo
«il falconello il lusignolo».
X.
LA NOTTE
E dalla torre suona la campana.
Il Podestà comanda di serrare.
Rimbomba ogni uscio del Palagio nuovo:
sull'imbrunire chiavi e chiavistelli
vanno con agro cigolìo di ferro.
Sèrrisi bene il falco randione,
il pro' bastardo della grande Aguglia.
Fece il Comune sacramento e legge
ch'egli non esca quinci mai, che morto.
Oh! non vedrà né Puglia né Toscana!
Addio Lamagna e Capitana!
Ogni uscio è chiuso del Palagio nuovo;
chiusa è la porta ed è levato il ponte.
Vegliano ad occhi aperti nella notte,
come civette, guaite per le scale.
Vegliate, o guaite, intorno al re prigione.
Egli era al lato dell'imperadore,
era lo specchio della sua persona.
Egli correva mare e terra in armi.
Del sacro impero era la fiamma al vento.
Ora è prigione, e non farà più stuolo
e non menerà più gualdana!
Dorme il Palagio tutto chiuso e muto.
Soltanto, sparse qua e là, le guaite
anche la bocca aprono d'ora in ora,
d'alto e di basso, e gridano: Eya! Eya!
Disse il Comune: «Lo tenemo, come
da piccol can spesso si ten zinglare,
e lo terremo, poi ch'è dritto nostro».
E non lo rese a padre od a fratelli,
per preghi e gabbi, né per oro od armi.
Vegliate, o guaite, Eya gridate in fino
che in cielo sia la stella diana.
Eya! c'è tempo a che ci sia la stella
che sveglia i cuori.
Ora si spegne il foco
e la lucerna; ora si dorme il sonno
primo, più forte, il sonno senza sogno.
Eya! c'è tempo a starnazzare i galli,
a cantar chiusi ed a chiamare i sogni:
ché dopo i galli è gran silenzio: ogni uomo
parla sommesso ad un suo morto caro.
Eya! c'è tempo allo schiarir dell'alba...
Ma voi gridate, o guaite, a vuoto! Oh guaite,
codesta vostra veglia è vana!
E' non v'è più! Fuggito è il re! Si trova
oltre le mura, oltre i serragli e il Reno.
È già più lungi anche del suo reame,
è già più lungi anche del sacro impero.
Non più prigione e non più re, si trova
nel luogo all'oriente della terra,
dove uscì prima l'erba che fa il seme,
dove uscì prima l'arbore ch'ha il frutto.
Non è più re, né manto egli ha, che falbo;
non ha che il musco d'oro, onde si veste
da sé la calda creta umana.
Non è più re, ma d'una schiava, in dono,
la libertà che a lei fu resa, egli ebbe.
La dolce schiava gli ha portato il sole
di ch'ella è piena, che ne' campi imbevve.
Egli alla nuda libertà s'è stretto,
bee l'aria pura di tra le sue labbra,
tra le sue braccia prieme l'erba folta,
da tutta aspira il grande odor del sole.
All'ombra egli è del legno della vita,
e presso il cuore sente mormorare
l'inestinguibile fontana.
E dorme alfine, dorme l'Uomo avvinto
alla dolce Eva.
Quella che fu schiava,
quei che fu re tengono il capo accanto,
e l'onde brune solcano le bionde.
No, non e' dorme: s'è addormito il mondo
intorno a loro.
Ei solo è desto, e vede
l'acque dormire, lieve ansare i venti,
chiudere il cielo gravi le sue stelle,
sparir la terra.
Liberi e sereni
sentono il tutto che s'annulla preso
dalla dolcezza antelucana.
Eya! gridate, Eya! gridate a vuoto
l'ultima volta, o guaite del palagio.
Ed ecco suona la campana.
XI.
L'ALBA
«Dormendo or ora ho udito la campana
che da sette anni io so tra l'altre squille.
Ella m'ha detto tristamente e plana:
- Comincia un dì come già mille e mille -
Amore, a Deo! Ven l'alba».
«Non anco in cielo s'è sentito il canto
dell'allodetta che destando il broilo
pleno d'oselli, al lusignolo accanto
passa e gli dice: - Dormi, o lusignolo:
non cantar più, ch'è l'alba».
-
«Qui non è broilo e foglia d'albaspina.
Qui non se sente risbaldire oselli.
Ben sì la gaita canta la maitina,
svernano entorno clavi e clavistelli.
Pàrtite, amore, a Deo!»
«Partir, se resti, come porò mai?
Eo plu non amo quel che tanto amava.
Eo plu non vollio quel che tu non hai,
ch'eri tu re et eo taupina sclava.
Or me basa, oclo meo».
«Va' ne, mea bella, e non far più lamento,
ch'eo vegno teco, teco vegno fuori.
Questo si fa per dolze incantamento.
Ti fie palese, quando arai du cuori...
e doglie altanto e pene!»
«Non duole al flore aver un dì donate
le follioline de la sua corona.
Non duole: el flore allega per la state.
Non duole: ad altri è caro ciò ch'e' dona,
et a lui ciò ch'e' tiene».
«Pàrtite, amore, poi che vezo 'l sole
rimpetto là sui merli della torre.
E l'ombra là vezo di corvi e grole,
e 'l passo qua sento de l'hom che tôrre
mi ti devrà per sempre!»
«Amore, a Deo! Quanto mi fu già caro
lo sole, tanto or mi sarà molesto.
Eo plu non vollio 'l dì lusente e claro;
con te, meo Sire, in questa notte eo resto,
dove tu sei, per sempre».
«Flore, o d'uliva o mandorlo che sia,
flore ch'hai già l'anima bianca e molle,
me plu non tene quei che m'ha 'n bailia,
eo sarò teco tra le fresche zolle,
al sole et all'amore!»
«Eo vado al sole, all'acqua, al gelo, al vento.
Prima eo cantava tutte le mie sere.
Ora, tra i solchi, in vetta gli olmi, eo sento
che forse te farò così dolere,
e ben n'arò dolore!»
«Me' là con te, che 'n Roma imperadore!
El Paradiso......
LE CANZONI DI RE ENZIO
III°
A BOLOGNA
ALMA MADRE DEGLI STUDI
UN DA LEI AGLI STUDI VERACEMENTE NUDRITO
DEDICA QUESTO PRIMO SAGGIO DI POESIA
ISPIRATO DALLA STORIA DEL LIBERO COMUNE
MA OH! QUANTO INFERIORE ALLA GLORIA DI LEI
ALLA GRATITUDINE SUA
LA CANZONE DELL'OLIFANTE.
I.
LA VEDETTA
Fu il venerdì, ch'era dolore e sangue
e la battaglia al Prato delle rose.
Bello era il tempo e tralucente il giorno.
Enzio era volto a dove nasce il sole.
Di là! l'altr'anno, sorgere una stella
soleva, lunga, che parea selvaggia
del cupo cielo, e lo fendeva in fuga,
lasciando il segno come una ferita.
Tutte le notti dall'agosto al verno
sorgea, come una fiaccola di guerra
sur una torre, e sotto quella luce
nere apparian le torri di Bologna,
immobili, erte, le dugento scolte
veglianti intorno al re prigione.
Fu il venerdì della battaglia al Ponte
di Benevento.
Enzio guardava al sole,
il re vedeva l'Asinella acuta,
la rossa torre sulla via di Roma.
Per là nel verno il conte di Monforte,
coi maliscalchi e cavalier di Francia,
avea stradato.
Allor già verno,
è ora fin di ferraio; ora in Campagna e Puglia
che avvien di voi, leoni di Soave?
Ora in Palagio i sedici custodi
sparsi per l'aula seguono con gli occhi
il re pensoso.
Egli ode nella strada
la cantilena lunga di un giullare
e un aspro suono di vivuola:
Sale Ulivieri e guarda a giù dal monte,
guarda la valle piena di grandi ombre.
Rumor di contro viene dalle forre,
rumor di zampe sopra secche fronde.
Muli e cavalli fiutano altre torme
lì dirimpetto, e rignano all'odore.
Schiarisce il giorno, son le nubi rosse.
Suonano i corni, squillano le trombe.
AOI
Guarda Ulivieri, guarda nella valle.
Quanti elmi al sole, quante spade e lancie!
Gli osberghi d'oricalco hanno le frangie:
bandiere al vento, rosse azzurre e bianche.
I gonfaloni pendono dalle aste;
punte su razzano come fiamme.
Son tante schiere, ch'e' non può dir quante.
Giammai non vide sforzo così grande.
AOI
Scende Ulivieri, e conta ai Franchi tutto.
«Più grande sforzo mai non fu veduto.
Son mille e mille, e hanno osbergo e scudo;
hanno allacciato al capo l'elmo bruno;
dritte le lancie, i verrettoni in pugno.
In campo state e Dio vi dia virtù!»
Dicono i Franchi: «Abbia chi fugge, lutto.
A morir qui non mancherà nessuno».
AOI
II.
IL CONSIGLIO
Ode re Enzio; ascolta come in sogno,
perché il suo cuore è in Capitana e Puglia.
Un de' custodi, Min de' Prendiparti,
dice: «Mal prenda a questi giuculari
ch'hanno per sue le piazze del Comune,
per ricantar le vecchie fole al volgo!
Già da gran tempo Carlomagno è morto».
E Scannabecco: «È morto sì, ma siede,
l'imperatore dalla barba bianca,
nella sua tomba, e con la destra impugna
la spada posta sopra le ginocchia».
Enzio re pensa: «O bel sire fratello!
Biondo e gentil Rollando di Soave!
Forse vedete ora apparir sui monti
non Valdabrun, ma i cavalier di Francia,
Proenza Fiandra Piccardia Brabante
coi santi gigli e con la croce!»
Manfredi in vero scorge allor sui monti
oltre il Calore l'oste del re Carlo.
Il nato dallo imperator di Roma
ha suo consiglio.
Parlano i suoi pari.
Qual è canuto, qual è tutto fulvo,
armato ognuno, ed il lor nome è Lancia.
Dice Calvagno: «Un giorno o due s'attenda:
saranno morti e presi per diffalta
di pane e biade per i lor cavalli.
A Benevento e' mal sarà venuto!»
Ma in parte è un vecchio astrologo accosciato
avanti un libro dove prende il punto,
come se avesse sopra il capo l'ombra
piena di stelle.
Intorno a re Manfredi,
vestito a verde come il lor vessillo,
vegliando a guardia i bruni Saracini
poggiati ad arcora e balestre.
Dice Ulivieri: «Bene è grande stuolo.
Di lor masnade è tutto pieno il bosco.
Son tante schiere, quante dir non posso.
Compagna abbiam noi picciola a tal uopo.
Rollando amico, date fiato al corno!
Lungi n'udrà l'imperatore il suono,
là nelle gole, e tosto sarà volto».
Rollando dice: «Sarò prima io morto!
Onore e loda perdere non voglio.
Non corno qui, ma Durendal ha luogo.
Sì, la vedrete rossa fino all'oro».
AOI
«Rollando amico, e' sono, per un, cento.
È pieno il bosco, tutto il monte è pieno.
Sonate il corno, il corno dell'impero!
l'imperatore lungi n'udrà l'eco,
là nelle valli, e sarà volto a tempo.
Tutti hanno scudo, tutti bianco osbergo,
bene a cavalli, ad arme, e d'ogni arredo...»
Dice Rollando: «Morte sarà meglio!
Il mio legnaggio non sarà dispetto.
Qui Durendal, non corno fa mestiero.
Dar colpi voglio, non soffiare al vento».
AOI
«Rollando amico, in bocca l'olifante!
È pieno il monte, è piena ormai la valle.
Tanti elmi al sole! Tante spade e lancie,
bandiere al vento rosse azzurre e bianche!
Giammai non vidi sforzo così grande.
N'udrà lo squillo in mezzo alle montagne
l'imperatore, e lo vedrem tornare...»
Dice Rollando: «Più morir mi piace!
Bel sire, e' ci ama per le nostre spade,
l'imperatore, e il ben ferire e il sangue.
Baroni e gente, ora ai cavalli e all'arme!»
AOI
III.
LO STORMO
Ascolta il re: sobbalza come in sogno.
Sta l'arcivescovo alto sur un poggio.
Nero il cavallo, con la bava al morso.
Alza la mano, e chiama i Franchi a pruovo,
e dice a tutti un suo sermon divoto:
«Avete a fronte l'oste d'un re moro:
battaglia avrete in cui morire è buono:
chi sparge il sangue, in cielo è suo ricolto!»
Di sella i Franchi sono scesi al suolo;
a Dio mercede pregano in ginocchio.
«Per questa croce ch'Egli portò in collo,
io d'ogni colpa in nome suo vi assolvo».
AOI
«Oh! questo» Enzio re pensa, «non avviene
nel campo tuo, biondo e gentil fratello!»
Nell'altro, in vero, il vescovo d'Alzurro
passa sopra le schiere inginocchiate,
eretto passa sul destrier suo falbo,
benedicendo con la man di ferro,
a tutti colpa perdonando e pena...
«Quei tra le fiamme e voi tra i santi fiori!»
E frati bianchi con la croce rossa
vanno tra i cavalieri e tra i ribaldi,
dando a lor caute voci il cavo orecchio,
porgendo sulle lingue agli sfregiati
o filo d'erba o foglia d'oleastro...
«Ti do per penitenza: Uccidi!»
I Lancia sono intorno a re Manfredi.
«La gente aspetta di messer Currado!»
dicono: ma l'astrologo dal libro
pieno di stelle, dove egli ode assorto
lieve stridire i neri vipistrelli,
alza la testa, e grave dice: «È il punto».
E il re soggiunge: «Usciamo fuori a campo!
Due re son troppi per un regno solo».
E il figlio dello imperator di Roma
fa tre battaglie delle sue masnade,
e il nome dà: Soavia cavalieri.
Vanno con la nera aquila ondeggiante.
Cupo rimbomba sotto le lor péste
il ponte presso Benevento.
Enzio non ode rimbombare il ponte
di Benevento, non le tre battaglie
vede schierate e ferme alla Grandella.
Egli la lunga cantilena ascolta,
il re prigione, e vede Roncisvalle,
e vede anco Rollando il prode:
Biondo e gentile, lieto viso e chiaro,
la lancia in pugno, va sul buon cavallo.
La punta al cielo, il gonfalone è bianco,
la frangia d'or gli batte sulla mano.
Dice: «Baroni, andiam soave, al passo!»
AOI
Enzio non vede l'altro re che aringa
le tre battaglie al Prato delle rose,
e il nome dà: Mongioia cavalieri.
Egli la lunga cantilena ascolta,
il re prigione, e vede Roncisvalle,
e vede anco Ulivieri il savio:
Dice Ulivieri: «Io non vuo' dir parola.
Lasciate il corno pendere alla soga:
non verrà Carlo il magno a questa volta.
Dunque, baroni, fate vostra possa,
e cavalcate avanti voi di forza...»
Un grido s'alza intorno a lui: Mongioia!
AOI
IV.
LA MISCHIA
«Tempo vene chi sale e chi discende»:
dice il re delle Torri e di Gallura:
«non più Mongioia è il grido dell'impero».
E dice a lui Rollando de Marano:
«Mongioia è il monte, donde Carlomagno
udì sonare le campane a festa
di Roma santa, udille sonar sole,
sull'alba, a gloria dell'antico impero».
Enzio re siede, e reggesi la fronte
piena di rughe sulla bianca mano.
È quella mano usa alla mazza d'arme,
usa alla spada ch'elmi e bacinelli
fendeva: ora non più, da sedici anni.
Non più tutta oro la capellatura
lunga fluisce.
Oh! come al fresco vento
si svincolava al modo d'una fiamma,
sulla galea, nel mar della Meloria!
Come, in cospetto dell'imperatore,
guidava i cavalieri a Cortenuova
contro il Carroccio di Milano!
Siede re Enzio con la fronte in mano.
O Enzio amico bella gioventù!
Egli non parla, e i sedici custodi
pensano anch'essi a sedici anni addietro.
Salgono in vano fabbri e zavattieri.
Tocca non è la torta del Comune.
Suonano qua e là da' battifredi
or fioche or chiare tutte le campane.
Passa la trecca, passa il pesciaiuolo,
la merce sua cantando ognuno a prova.
Vengono, a frotte, ai portici le donne,
quando si sforna, a comperare il pane.
A quando a quando ora su questa torre
ora su quella tubano i colombi.
E s'ode ancora il canto del giullare
già rauco, e un aspro suono di vivuola.
Ma Enzio sente in cuore una battaglia
lontana.
È come quando ingrossa il fiume,
quasi sognando, per una tempesta
nelle invisibili montagne.
Maravigliosa è la battaglia, e grave.
Rotti gli osberghi, sono l'aste infrante.
Non più le trombe suonano, che rauche;
non, se non rosse, scendono le spade.
Bocconi, in faccia, l'un sull'altro giace,
quali sui sassi, quali tra l'erbe alte.
Quanti belli anni vanno via col sangue!
Quanti non rivedranno la sua madre,
né Carlomagno che non torna, e va...
AOI
Mararavigliosa è la battaglia, e forte.
Per tutto il mondo tanto non si muore!
Scorre tra l'erbe, sgronda dalle foglie,
bulica il sangue, come quando piove.
Vanno cavalli, con le selle vuote,
nel campo, in fuga, e scalciano alla morte.
Quanto bel tempo si fermò col cuore!
Quanti non rivedranno le sue spose!
né Carlomagno che tornar non può...
AOI
Lontan lontano, tutto il ciel si muta.
Tempesta in terra, in alto mar fortuna.
A mezzodì, come di notte, abbuia.
Cielo non v'è, se un lampo non l'alluma.
Tuona con una cupa romba lunga.
La terra trema, crollano le mura.
Dice la gente: Secol si consuma!
la gente dice, eppure non sa nulla.
Eh! buon Rollando bella gioventù!
AOI
V.
IL CONTRASTO
Il re prigione balza in piè d'un lancio.
La chioma grigia sopra il capo ondeggia
come ondeggiava al Ponte Sant'Ambrogio
in mezzo al roseo polverìo di maggio.
Sorgono insieme i sedici custodi
quasi tendendo contro lui le branche.
Un de' più vecchi, il pro' Michel degli Orsi,
dice: «Così gli ardeano gli occhi azzurri
quand'io lo presi».
Al re si volge e dice:
«Messer lo re, pensate al detto vostro:
che voi tenete saggio e canosciente,
quale si sa col tempo comportare».
Ma Enzio sente rinfrescar la pena
che in cor gli abonda, e non sa come.
Enzio non sa; ma forse vede l'ombre
di cavalieri biondi che le spade
alzano lunghe e calano a due mani,
alla Grandella, al Prato delle rose.
Ma i lor nemici gridano: «Agli stocchi!
Date gli stocchi al ventre dei cavalli!»
Cadono i biondi e grandi cavalieri
co' destrier suoi fediti di coltella.
Caduti appena, hanno alla gola anch'essi,
i cavalieri, il ferro dei ribaldi.
Enzio non sa, ma forse l'ombra e' vede
di re Manfredi dritto sur un colle,
che mira in fuga ripassar le schiere
sul ponte presso Benevento.
Rollando mira: vede il grande scempio.
Chiama Ulivieri, e dice questo detto:
«Bel sire amico, al nome del Dio vero,
vedete a terra tutto il fior del regno.
Ben possiam fare il duolo ed il lamento
di tai baroni, che non più vedremo.
O imperatore, qui voi foste almeno!
Come, o fratello, fargli posso un cenno?»
Dice Ulivieri: «Come far, non vedo;
ma soffro io meglio morte che disdegno».
AOI
Dice Rollando: «Che non suono il corno?
Lungi n'udrebbe Carlomagno il suono;
verrebbe qui, prima che ognun sia morto».
«Io meglio soffro morte che disdoro.
Voi nol farete per il mio conforto:
onta sarebbe nel legnaggio vostro.
Di voi non sono né signor né uomo:
se voi sonate, io guardo e non approvo.
Poi, rosso il braccio avete fino al collo...»
«Ben sì» risponde il Conte «picchiai sodo».
AOI
Dice Rollando: «Io suono l'olifante!
Al suon verrà l'imperator e al sangue».
«È d'ogni morte onta per me più grave!
Compagno, noi morremo in questa valle».
Rollando dice: «La vostra ira è grande...»
«Perché non quando vi pregai sonaste?
La virtù vostra a tutti noi fu male.
Morrete e voi: ben questo è peggior male!
Avanti sera ci dovrem lasciare...»
E l'un per l'altro ecco sospira e piange.
AOI
VI.
L'ACCORDO
Anche Enzio re non sa perché, ma piange,
volto alla terra che riluce al sole.
Sul colle ei, forse, vede il suo fratello
il gentil re, tra i raggi dell'occaso.
Dice Anibaldo: «Fuggi in Puglia, e passa
il mare, e trova il Despoto d'Epiro».
Il suo cavallo chiede il re, da guerra.
Dice Anibaldo: «Trova la tua donna;
porta i tuoi figli (Enzo ha due anni) in salvo».
Monta a cavallo e cinge, il re, la spada.
Dice Anibaldo: «Miglior tempo aspetta!
Vano è pugnar contro la rossa croce».
Il re Manfredi prende dalla mano
d'uno scudiero l'elmo, su cui posa
la sua grande aquila d'argento.
Rimira a valle.
Presi o morti i Lancia,
sgozzati a terra i biondi cavalieri,
fuggono in Puglia, fuggono in Abruzzi
gli altri baroni.
Al cielo va Mongioia!
Risuona il ponte presso Benevento
sotto scianguati cavalieri in fuga.
«Mal sia di te, soldano di Lucera!»
Ma egli, il figlio dell'imperatore,
la reda dell'imperator di Roma,
è in cima al colle, sul destrier che raspa.
Egli è lassù che mira la sua rotta,
con l'elmo in mano, e l'aquila d'argento
arde e sfavilla al sole che tramonta.
E il re prigione del Comune ascolta
la voce quale d'un profeta:
Quel che Dio mise in nome suo, vien presso;
dà degli sproni d'oro nel destriero.
«Non ira mala sia tra voi, vi prego.
Per Dio vi prego: è il nostro giorno estremo.
Sire e compagno, qui morire è certo.
Dell'olifante il suono andrà disperso.
N'udrà, sì, forse il suono, n'udrà l'eco,
ma non verrà l'imperatore a tempo».
AOI
«Dategli fiato tuttavia, Rollando,
poi che l'udrà l'imperator lontano.
L'udrà sul capo gemere d'un tratto,
ed, a vendetta far di noi, verranno.
Discenderanno tristi da cavallo,
ci troveranno morti per il campo;
raccatteranno il nostro corpo e il capo,
sopra i somieri li porranno, in pianto».
AOI
«Faranno il pianto con affanno e doglia,
sopra il somier ponendo una tal soma!
Ci deporranno in qualche ombrosa chiostra,
col lume acceso all'arco della soglia.
O qui su noi porranno una gran mora,
non cane o lupo mangi le nostre ossa;
non le nostre ossa bagni qui la pioggia,
non nella fossa il vento qui le muova».
AOI
VII.
L'OLIFANTE
Ormai nessuno è più con te, Manfredi
nepote di Costanza imperatrice!
Sul biondo capo ei pone l'elmo, ei leva,
andando a morte, l'aquila di Roma.
L'aquila cade sull'arcion dinanzi.
Romano e' parla, ed Hoc est signum Dei ,
dice ai suoi cento.
Ma però non lascia:
muove il cavallo verso la battaglia.
Cavalca, quale cavalier valente,
contro i guerrieri della rossa croce,
galoppa al Prato delle rose, sprona
ver la sua rossa Roncisvalle.
Rollando ha messo l'olifante a bocca,
forte lo prieme, a gran virtù vi soffia.
Il sangue sprizza e dalle labbra cola.
Son alti i monti, alta la voce vola.
A trenta leghe l'eco ne rimbomba.
L'imperatore ode la voce lunga.
«Suon di battaglia!» mormora, ed ascolta:
«se non è tuono che tra i monti corra».
Raccoglie a sé le briglie, né più sprona.
Tien alto il capo, e lento, al passo, inoltra...
AOI
«O triste voce!» pensa il re prigione.
«Che non cavalco per le bianche strade
di Lombardia con Ecellino e Buoso?»
Pensa, e il suo cuore è come onda nel mare,
nel mare intorno a Montecristo e il Giglio,
quel tre di maggio...
«Or sono sì distretto!»
Rollando mette ancora le due labbra
all'olifante, e suona con ambascia.
Dal collo gonfio il chiaro sangue salta.
Son alti i monti, passa la voce alta.
A trenta leghe il suono ne rimbalza.
L'imperatore ode la voce chiara.
«Se non è tuono, se non è valanga,
è la mia gente, questa, che ha battaglia».
Ferma il cavallo, sosta in una landa.
Sul capo suo palpita l'orifiamma...
AOI
«Che avviene là?» domanda Enzio.
Nessuno
sa, là nel regno, dei due re, che avvenga.
Il giorno cade, e il sole tinge in rosa
la torre al sommo, che prigione ei prima
vide lanciarsi su nel cielo azzurro,
venendo dal Castel d'Unzola.
Rollando prende tutta la sua lena:
nell'olifante con furor l'avventa.
La fronte crepa, scoppiano le tempia.
Sono alti i monti; ma la voce immensa.
La voce va, nell'alto ciel dilegua,
passa all'imperatore sulla testa.
Non è valanga, è altro che tempesta!
Ei fa sonare tutti i corni a guerra.
Volge il cavallo, volge a lei la schiera.
«Rollando chiama! Uomini, all'arme e in sella!»
AOI
VIII.
IL SACRO IMPERO
E suona la campana del Comune
a tocchi tardi.
Ella è sonata a soga.
Buon artigiano, cessa l'opra: è notte.
Uomo dabbene, torna a casa: è buio.
Il bevitore esca dalla taverna.
Chi giuoca a zara, lasci il tavoliere.
Uscite, o guaite, per veder se alcuno
va per la terra senza lume o fuoco.
Affretta il passo, o peregrino, e trova
qualche uscio aperto, ove tu chieda albergo.
Ora in palagio tuonano le porte,
i catenacci stridono e le chiavi,
serrando il re.
Poi tace ultima anch'essa
la lunga lugubre campana.
Ma Enzio ancora ode sonare il corno
della gran caccia, dalla Valle rossa.
Di sangue tinti sono l'erba e i fiori.
Giacciono i morti, i morti dell'impero,
giacciono, chi sul dorso, chi sul petto,
tra i neri massi, a piè dei neri pini.
Tre volte suona l'olifante, e chiama.
È la vigilia della tua vendetta:
chi ha mal fatto, non lasciar che dorma:
ritorna, imperatore magno!
Oh! egli udì; l'imperator ritorna.
S'ode la vasta e lunga cavalcata.
Viene tra gli alti tenebrosi monti,
per grandi valli e grandi acque correnti.
Avanti e dietro suonano le trombe
a riscontrare in alto l'olifante.
Non ha tra lor chi non si dolga e pianga.
Sul calpestìo risuona e sulle trombe
il pianto, come in mezzo all'acquazzone
le raffiche dell'uragano.
Sono alti i monti, gli alberi molto alti.
La Valle è piena di rosai selvaggi.
La notte è chiara: è chiarità di luna;
tremano i gigli nella rossa Valle.
Presso ogni morto è fitta la sua spada,
la spada sua con l'elsa fatta a croce.
Stanno riversi con le braccia in croce:
è nato un giglio in bocca d'ogni morto.
Ognuno ha il giglio, a ciò tu li conosca:
ritorna, imperatore santo!
Viene.
Non è ancor giorno né più notte.
Splendono già le punte delle lancie,
lucono gli elmi, brillano gli osberghi,
elmi ed osberghi e scudi pinti a fiori.
Si vedono ondeggiare i gonfaloni
appesi all'aste, rossi azzurri e bianchi;
su tutti i gonfaloni è l'orifiamma,
quella che un giorno si chiamò Romana.
Tutti a cavallo i popoli del mondo:
in mezzo a loro è Carlomagno.
L'imperatore! Ha conti e duchi intorno,
vescovi armati, con le mitrie d'oro.
L'imperatore ha gli occhi al sol levante,
l'arcangelo gli dice: Ave! all'orecchio.
È bianco, è vecchio di cinquecento anni;
la barba in fiore ha stesa sull'osbergo.
I centomila, in segno di gran duolo,
fuori dell'elmo hanno la barba bianca.
Va, giungi al campo ove morì Rollando,
imperatore! imperatore!
Va, ma non giunge.
È brusìo d'ombre vane
ch'ode re Enzio, quale in foglie secche
notturna fa la pioggia e il vento.
LIBERTAS
...
[Pagina successiva]

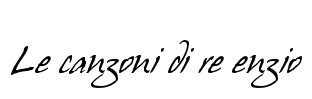 Libri online
Libri online