LE CANZONI DI RE ENZIO, di Giovanni Pascoli - pagina 3
...
.
Suonano in cielo tutte le campane
sopra il Carroccio.
È la città che parte:
parte levando un lento aereo canto
con tutte le sue torri.
IX.
I PRIGIONI
Volge all'occaso, volge a Porta Stiera,
volge il Carroccio per la via del sangue.
Non trenta volte trenta dì son corsi
da che re Enzio combatté, fu preso,
per quella via, come un astor maniero
preso alla pania.
Or ei ricorda il giorno
che passo passo in groppa d'un muletto
seguì quel carro e i bovi dell'aratro.
O sacro impero! O aquile di Roma!
Ma Enzio a un tratto si riscuote, e parla.
Parla a Marino d'Ebulo, a Currado
di Solimburgo ora loquace or muto.
Siede cruccioso Buoso da Dovara.
«Credete voi che dorma la possanza
del sacro impero?» Il conte apre la bocca.
Buoso tentenna il capo e non risponde.
S'odono i duri passi de' custodi
fuor delle porte, e il busso de' ronconi
sul pavimento.
La città par vuota.
Esclama il Re: «No: veglia!»
Dalla città par la città lontana.
Non s'ode più di tante squille e trombe
che una campana, e il busso de' ronconi
sul pavimento e il passo de' custodi.
Aggiunge il Re: «Per una nube credi,
o Buoso, tu, non sia più cielo il cielo?»
Tentenna il capo Buoso da Dovara.
«Conte Currado, ben mio padre ha detto,
come tu sai, bene il sereno Augusto
scrisse: - Faceste corna, o voi, di ferro,
con cui credete ventilare il mondo!
Alcuno ascese per cader più d'alto.
Voi fate feste e vanti coi fratelli
vostri Lombardi: ripensate al nostro
grande avo; addimandatene i fratelli...
-
Conte, e' le corna frangerà di ferro!»
Il conte un poco apre le labbra, e tace.
Stanno i custodi, è ferma la campana.
Non s'ode più che il paternostro, in piazza,
d'un cieco senza guida.
Enzio a sé ode i battiti del cuore.
Pensa a suo padre.
Federigo Augusto
è come Dio, tacito sì ma insonne.
Forse e' s'aggira col possente stuolo
presso la cerchia di città ribelli.
Cesare in armi scorre per l'impero.
Vengono al suon de' timpani gli arcieri
arabi snelli, e grandi cavalieri
monaci assòrti ne' lor tetri voti;
Normanni biondi della Conca d'oro
con gli occhi incerti tra verzieri e fiordi;
conti e cattani scesi d'Apennino,
e col suo stormo cavalcando chiuso,
solo Ecellino; e leopardi e tigri,
e con l'andar di nave i dromedari,
e il leofante con la torre quadra
da cui s'alza il vessillo imperiale
con la grande aquila; e l'imperatore.
Egli cavalca, né tristo né lieto,
con un gerfalco al pugno.
Enzio a sé ode i battiti del cuore
giovane.
- E s'Egli fosse alla Scultenna?
Se campeggiasse intorno alla Fossalta?
volesse su quella oste di manenti
trar sua vendetta dove fu lor vanto?
Sono, in lor cieca oltracotanza, in campo
forse ora usciti per sentor che ne hanno...
- Ed Enzio parla: «Or di', conte Currado
di Solimburgo! Se d'un tratto, andando
coi tardi bovi e i tardi artieri il carro,
l'oste sentisse sibilar le freccie
dei Saracini, rimbombar l'assalto
dei cavalieri, calar mazze e spade
ed azze e lancie, ed apparir, ruggendo,
il nero capo d'Ecellin d'Onara,
e stormi e stormi correre in tempesta
sopra il Carroccio, e d'ogni parte il grido
alzarsi: Roma! Roma! Imperatore!...»
«Ma egli è morto,» grida il conte: «morto
morto, l'Imperatore!»
X.
L'IMPERATORE
Sì.
Egli dorme in una Cattedrale,
entro l'eterno porfido dell'arca.
E' non sa più di stormi e cavalcate,
e' non sa più di timpani e di trombe,
nel dolce tempo quando foglia e fiora,
ch'egli tendea nei prati i padiglioni.
Non più dai geti libera l'astore,
delle canzoni perse il motto e il suono.
Non suono più di corni o di leuti,
ma pii bisbigli e il canto della messa.
Anche ha dimenticato gli anatemi,
e il bando a lui nel giorno dell'ulivo,
e i giorni d'ira, i giorni di sventura
coi ceri accesi e le campane a festa.
Dorme nell'arca rossa l'Anticristo
nato alla vecchia monaca, e nudrito
da sette preti.
Presso, il mare aspira
col lento succhio tutto il cielo azzurro:
al cielo dà Gennet-ol-ardh l'olezzo
dei cedri e delle rose.
Al morto grande imperador di Roma
dissero pace i vescovi di Cristo.
Di lui parlò 'l rabbino al Dio d'Abramo,
a braccia spante volto all'Oriente.
Per lui, girando attorno al minareto,
le cinque volte il muezzin cantò.
Or egli giace nell'oscura cripta,
coi mali e i buoni.
Oh! avessero favella!
Direbbe forse alcuno dal sepolcro:
- Qual sei disceso presso noi Ruggero?
Noi padre il vento e madre avemmo l'onda.
-
Risponderebbe: - O figli di Vikinghi!
Anch'io fui vento, figlio anch'io di vento!
Né Skaldo mai cantò sull'arpa un canto
più grande e bello, né più bello e grande
mondo mai vide Re del mare in corsa,
del sogno mio...
- Ma più non ha favella
ora, e il coperchio è sceso omai per sempre
sull'arca fiammeggiante.
Dorme, ma i sogni non saprà narrare,
s'egli pur sogna, e si ritrova a Roma
sulla quadriga di cavalli bianchi
per la Via Sacra andando al Campidoglio.
Placato è il Mondo.
Seguono, al guinzaglio,
Cesare Augusto leopardi e tigri,
vengono sopra il dosso d'elefanti
l'armi e i trofei delle città ribelli...
O lascia il Mondo veleggiando al Regno
santo di Dio.
Distendono le vesti
e ramuscelli per le vie, ch'e' viene.
Cantano Osanna! Osanna negli eccelsi!
Tutti hanno in mano i rami delle palme.
Cristo ritorna al suo sepolcro vuoto.
Cristo ritorna a dare la sua pace.
Sta sulle porte di Gerusalemme.
Sta tra le nubi.
Ha virtù molta e gloria.
Gli angeli a lui congregano le genti
dai quattro venti; ch'Egli a tutti franga
il pane, e mesca il vino.
Ma col dormente è il sogno suo sepolto,
tra il Mondo e Dio, nell'isola del Sole.
Ed una voce è corsa per la terra,
che quella è stata l'ultima possanza,
l'ultima vasta raffica di vento
che dileguò lasciando ansante il mare.
Forse la voce viene dal profeta
che ha barba grigia come vecchio musco,
dal vecchio bardo errante nella selva
di quercie brulle in cui verdeggia il vischio.
E poi verrà chi povero e ramingo,
errante anch'esso in un'antica selva,
nei luoghi dove spento fu, la prima
volta, l'imperio, sognerà quel sogno
che tace là sepolto dentro l'arca.
La selva sta, sublime cattedrale,
su mille e mille aeree colonne.
E il peregrino v'ode il soffio eterno
dell'Infinito, che lo tocca in fronte
come soave vento..
XI.
IL PAPA
E il vento soffia, dell'autunno, e stacca
le foglie ai pioppi della strada e a gli olmi,
di quando in quando.
Cadono le foglie
stridule sopra le armi e sul Carroccio.
Ecco e il Carroccio e il Popolo s'arresta;
e lancie e spade sono volte a terra.
Sonate, o trombe! Squilla, o Martinella!
Inchina a lui la pertica il Carroccio.
Son là di contro i sacerdoti rossi,
vescovi, preti, diaconi di Roma.
Guatano appena, parlano tra loro
sommesso e grave, o coi marchesi e conti
lor lancie e spade.
Vinsero.
Per loro
Dio combatté.
La fronte atterra e gli occhi
muto solleva il Popolo di ferro,
lassando i suoi ronconi e talavazzi.
Tra il rosso delle porpore, tra il lampo
d'armi dorate, alto tra terra e cielo,
in faccia a lui ravvolto nel suo pallio,
è, tacito, il Gran Prete.
È il successore di Simon Bar Iona
che a Gesù disse primo: «Tu se' Cristo!»
di Pietro a cui lasciò le chiavi in terra,
del cielo, il Dio che ritornava al cielo.
È il Cristo che rimuore e che risorge
perennemente, è il Cristo del Signore,
l'Unto nel capo, il Verbo che rimase
in terra Carne, e che tra noi dimora.
Di qua da Dio, di là dall'Uomo, è l'Uno
degli invisibili angeli più grande,
poi ch'egli in terra è giudice del cielo,
dei Troni e delle Dominazioni.
É il Dio che Dio creò su Faraone
dal duro cuore, e lo mandò coi segni
del suo giudicio, e gli affidò la verga
che si fa serpe e si disnoda e fischia
appiè dei re; che dove si distende,
i laghi in sangue, muta i fiumi in sangue,
ogni acqua in sangue, e nella terra intiera
fa che non sia che sangue.
Ora il Gran Prete alza la mano, e parla:
«La terra esulta e si rallegra il cielo:
dov'è colui ch'era nemico al Cristo?
dov'è il gigante di Babel, possente
in faccia a Dio, saettator dei giusti?
dove il Nerone, dove il nuovo Erode?
dove il Soldano me' che imperadore?
Scendeva un maglio ad or ad or sul mondo.
Non s'ode più.
Cadde di mano al Fabbro.
Spada di Pietro, lancia di Maurizio,
e' si voltò contro la Croce e Pietro.
E Dio lo franse.
Egli dovea le notti
schiarar, del sonno e degli errori, Luna,
che da noi Sole ha, quant'ella ha, di luce;
né volle; e invase, ombra deforme, il giorno.
La notte eterna or lo riprese e cinse.
Noi pose in Roma trionfal suo carro
Dio! Pose a noi Dio stesso nelle mani
destra e sinistra, le due briglie lunghe
del cielo e della terra!»
Torna il Carroccio e il Popolo nel chiaro
lume d'ottobre.
Splendono le rosse
pampane intorno, splendono le vesti
rosse e l'argento delle curve mazze.
Dice Innocenzio: «E voi sterpate il seme
del reo Nembròd ch'e' non rimetta ancora».
Dice Innocenzio: «Buoso da Dovara
vuo' che da voi, per amor mio, sia sciolto».
E un Anziano: «Noi teniam due terre
di Santa Chiesa.
Averle amiamo in dono».
«No» dice il Papa.
Alcun de' Lambertazzi
stringe più forte il pomo della spada.
Presso è Bologna; e già si son rideste,
tra grida e canti, tutte le campane.
Splende lassù, per un momento, a oro,
nel sol morente il capo del re Enzio.
Poi cala il grido e il murmure: poi cessa.
Parla ai biolchi, tetri, sulla porta,
ilare Zuam.
Mugliano stanchi i bovi
appiedi dell'Arengo.
LE CANZONI DI RE ENZIO
II°
LIBERTÀ!
SALE SUL DESCO SANGUE NEL CUORE ARIA DELL'ANIMA
SOLA PACIFICATRICE DEGLI UMANI
PERCHÈ SOLA NE SCOPRI NE RIVELI NE CONSACRI
LA SOMIGLIANZA FRATERNA
O SIMILE A COLEI CHE ALCUNO IN SOGNO PIANGE LONTANA
E TU GLI DORMI FLORIDA MOGLIE ACCANTO
O TU PER CUI SI MUORE CON GIOIA
PERCHÉ MORIRE È RIACQUISTARTI PERDUTA
LIBERTÀ
LA CANZONE DEL PARADISO
I.
IL BIROCCIO
I bovi per l'erbita cavedagna
portano all'aia sul biroccio il grano.
Passa il biroccio tra le viti e li olmi,
con l'ampie brasche, pieno di covoni.
Sotto i covoni va nascoso il carro,
muovono i bovi all'ombra delle spighe.
La messe torna donde partì seme,
da sé ritorna all'aia ed alle cerchie.
I mietitori ai lati del biroccio
vanno accaldati, le falciole a cinta.
Sul mucchio, in cima, un bel fantino ignudo.
Tre vecchi gravi seguono il biroccio,
i tre fratelli, un bianco, un grigio, un bruno.
Ma di lontano, dalle gialle stoppie,
un canto viene di spigolatrici.
Sola comincia Flor d'uliva il canto,
poi le altre schiave alzano un grido in coro:
Sette anni planse, oimè sett'anni sani,
e scalza andava, un vinco in ne le mani.
Pecore e capre aveva entorno, e' cani.
Sette anni, oimè taupina sclava,
sett'anni planse: un dì, cantava...
Passava un cavaleri de la crose,
sentì lassù la dolze clara vose,
ligò 'l cavallo cum la brillia a un nose:
«Vosina clara como argento,
sett'anni è sì, che no te sento...
«
Son tra i pioli i ben legati fasci,
le spighe in dentro, e sovra il mucchio d'oro
che va da sé, siede il fantino e ride.
Ride gettando i fiordalisi in aria
e le rosette: al piccolo di casa
mandano a gara, uomini e donne, un motto,
mandano a prova, verle e quaglie, un suono.
Parlano i vecchi, i tre fratelli, insieme.
E l'uno parla, e dice: «Arregidore,
ben Vidaliagla si può dir granaro».
E l'altro parla, e dice: «Campagnolo,
la terra è buona, ma voi meglio siete;
voi, meglio, e i bovi del fratel Biolco».
Tace il Biolco, ma s'allegra in cuore.
E più lontano viene dalle stoppie
il canto tristo.
Flor d'uliva intuona:
seguono l'altre, ch'oggi sono ad opra:
Ligò 'l cavallo, e se li fece avanti.
«Deh! pasturella, Deo te guardi e' Santi.
Mangiasti bene, così gaia tu canti!»
«Vui dite, la Deo gratia, vero:
mangiammo, e' cani et eo, pan nero».
El cavaleri la mirò cum dollia.
«Ne' to' cavelli sempre 'l vento brollia,
lassa tra' rizzi l'erba 'l fior la follia».
«El vento no, non è, meo Sire:
è che nel feno aio a dormire...
«
Fermo è il biroccio.
Al bel fantino stende
le mani, e d'alto lo raccoglie in collo,
la prima nuora; e gli uomini e le donne
prendono i fasci e fanno il cavaglione.
L'Arregidore dice al Campagnolo:
«Spighe segate e manipelli a bica
di rado o mai Santo Zuanne ha visti».
Dice il Biolco: «E seghisi la stoppia
prima che piova, non la terra v'entri!»
E il Campagnolo: «E tosto ariamo.
Arare
tre volte è bene, quattro volte è meglio».
E dice qui l'Arregidora, e passa:
«Ben ci faranno ceci fava ervilia!»
E passa, ch'ella ha da far cena, e il giorno
è già sul calo.
Ma vie più lontano
vien dalle stoppie il canto delle schiave:
Al cavaleri ansava forte 'l pecto.
«In quil castello u albergare aspecto,
dimme s'eo posso ritrovare un lecto».
«Di plume, eo l'ebbi, in quil castello,
col Sire meo sì blondo e bello!»
«Tristo a cui te fidai nel meo passare!
Dolze mea sposa, eo torno a te dal mare».
E se levava l'elmo e lo collare;
e per le spalle a mo' de l'onde
scorrèn le longhe ciocche blonde...
II.
SAN GIOVANNI
Col manipello delle spighe in capo
torna la schiava.
Tra i capelli neri
ha paglie e reste e foglie di rosette
che paion ali rosse di farfalle.
«Va', Flor d'uliva, va' con le mie figlie,
monta sul pero, monta sul ciriegio.
Domani viene San Zuanne e vuole
le prime pere e l'ultime ciriegie.
Le porterete in piazza di Bologna
coperte con le pampane di vite».
«Va', Flor d'uliva, va' con le mie nuore,
cava nell'orto l'aglio e le cipolle.
Per San Zuanne chi non compra l'aglio,
per tutto l'anno non arà guadagno.
Prendi la maggiorana e petroselli,
la camomilla e spighe di lavanda».
«Va', Flor d'uliva, va' con la cognata
per medesine e benedizioni:
foglie di nose e flori di pilatro,
vesiche d'olmo e fiori di sambuco.
Nell'acquastrino prendi le ramelle
del salcio d'acqua detto l'agnocasto».
Va Flor d'uliva, torna va ritorna,
ma lieta in cuore, che vedrà domani,
vedrà Bologna e le sue grandi torri;
e canta...
E per le spalle a mo' de l'onde
scorrèn le longhe ciocche blonde...
Domani è il Santo delle innamorate.
Siedono su le panche le pulzelle.
Son li amadori a' loro piè col mento
sopra le mani, e i gomiti sull'aia.
Gli occhi guardano, palpitano i cuori:
palpitano le lucciole nel buio.
Parlano e dànno in lievi risa acute;
fanno le rane prova di cantare.
Ma Flor d'uliva siede in terra e intreccia
le lunghe reste; ch'ella non ha drudo.
Le code intreccia, e mette, ad ogni volta
data alle code, un capo d'aglio nuovo;
ma gode in cuore, ché vedrà le torri,
che in una torre c'è una caiba, e, dentro,
re Falconello, le catene d'oro,
i ceppi d'oro, anche i cavelli d'oro.
I lunghi pioppi scotono le vette:
son li aierini che vi fan la danza.
I barbagianni soffiano dai buchi:
son le versiere che ansimano andando.
La guazza cade: è ora di partire.
Partono i drudi, per non far incontri.
Cade la guazza, che fa bene e male.
Rincasan ora le pulzelle; ancora
la schiava è là, sola con li aierini
che si dondolano...
Oi bel lusignolo!
canticchia: torna nel meo broilo!...
Non vanno a giro omai che le versiere;
vanno alle case dove è un lor fantino;
il lor fantino nato da sette anni
in questa notte, ch'era San Giovanni.
Chiamano all'uscio.
Stesi sulle siepi
son fascie e teli, a prendere la guazza;
e li aierini passano soffiando
sui bianchi teli, sulle bianche fascie,
tremanti al soffio.
Qua e là nell'aie
muoiono i fuochi crepitando appena.
È mezzanotte, l'ora che al sereno
prende virtù l'erba, la foglia, il fiore,
e l'olio chiuso nelle borse d'olmo,
e il ramo puro, il ramo d'agnocasto.
Ora il tesoro ch'è sotterra, sboccia,
fiorisce un tratto, e subito si spegne.
Ora si trova l'erba che riluce,
che fa vedere ciò che fu sepolto.
Ora si vede al lume di tre lumi
chi è lo sposo a cui dormire accanto.
Ora nei trebbi, incerte del cammino,
sostano un poco insieme le versiere.
A li aierini chiedono la strada,
e li aierini ridono.
Ma ecco,
di qua di là, lente tra il sonno e piane,
ton, ton , suonano le campane.
III.
IL SOLE
Avanti il dì si leva dal giaciglio:
non ha battuto ancora l'ali il gallo,
ancora canta l'assiuolo intorno,
la rondinella è nel suo nido ancora.
Esce la schiava e tira l'acqua al pozzo,
nel lebe colmo ella s'inonda il viso,
scioglie i capelli sotto la rugiada,
v'intreccia i fiori nati tra le spighe.
E poi raccatta i fasci di lavanda,
le reste d'aglio, l'erbe, i fior, le foglie,
le medesine e benedizioni
zuppe di guazza e di virtù notturna.
Larga la guazza piove dalle stelle,
le stelle impallidiscono.
Non canta
più l'assiuolo.
Va la schiava e cerca
nei greppi un fiore ch'ha ramoso il gambo,
larghe le foglie e morbide di pelo,
grande.
Una spiga porta che s'appunta
come la fiamma, e tanti fiori ha forse
la lunga spiga, quanti giorni ha l'anno;
aperti i primi, chiusi i più lontani.
Strappa da terra Flor d'uliva il grande
tasso barbasso, e va con quello, e prende
via per un infinito colonnato
d'aerei pioppi, volto ad oriente.
Odora la viorna e la vitalba.
E s'incammina incontro all'alba.
Batte tre volte l'ali un gallo, e canta:
cantano tutti, nelle case, i galli.
E li aierini, del color dell'aria,
frullano via, dando una scossa ai pioppi.
Lasciano un po' di rugumare, a lungo
mugliano i bovi, poi che il cielo imbianca.
La schiava inalza il verde cero, ch'arde,
inalza e scuote il gran tasso barbasso;
e le fogline de' suoi fiori aperti
piovono giù come faville gialle.
- O Sole! O Sole! Ricomincia il giro!
Temevi forse qualche tuo nimico?
Libere omai sono le vie del cielo.
Sta' su nel cielo un poco meno, e posa
un poco più; ma non sostar: cammina!
Seccaci, a tempo, nelle spighe il grano,
mettici, a tempo, dentro l'uve il vino.
O indugïasti per un sandaletto
d'oro, che in prima pàrveti una stella?
Il poco indugio sia con nostra pace;
ma ora muovi! Anche noi s'ama, o Sole! -
Ed ecco il cielo si converte in rose,
in rose e oro; i pioppi ardono in vetta;
a Flor d'uliva, come gemme, in capo
brillano mille gocciole di guazza.
Si leva il sole.
E li uccellini in cova
tre volte girano sull'ova.
Allegra poi con la canestra in capo
va Flor d'uliva, e due panieri al braccio.
Vanno con lei le serve del contado.
Cantano lungo Savena la verde,
cantano 'l lai de Santa Filumena.
In t'una grotta in ripa de la Zena
c'è un vieni e va, ma che si sente appena...
gra pa ri gra pa ri tra...
là c'è una donna che tesse, che tesse...
una spola che va, che va...
Lunga è la strada ed è già alto il sole;
sì, ma le schiave l'amano, la strada,
l'amano, il sole, e vanno via cantando:
Un drago aspetta, guata che si spicci,
lo giorno sta cun li ocli fissi ai licci...
gra pa ri gra pa ri tra...
Finito ch'abbia quello ch'ella tesse,
dopo, il drago la mangerà.
Bella è Bologna, ma così lontana!
Cantano già su li olmi le cicale.
Guata che guata, li ocli a sera ei vela.
E' dorme, et ella stesse la so tela...
gra pa ri gra pa ri tra...
Lo giorno fa, la notte sfa, ché tesse
la tela dell'eternità
Ed apparisce la città.
IV.
IL RE MORTO
Nella città con la canestra in capo
va sotto i neri portici e le torri
dal sole accese, appiedi dei palagi
cinti di merli, ingombri di baltresche,
in mezzo al rombo di campane a festa.
In una piazza ella riposa un poco,
depone un poco la canestra, e guarda.
In alto guarda, e si ravvia sul capo
i ricci pésti dal corollo.
Dalla finestra uno la chiama: «Ehi! tosa!»
S'avvia la tosa con le dolci frutta
e con li odori, e sulla porta un vecchio
vestito a festa: «Va pur su» le dice:
«è misèr Piero, Pier de li Asinelli».
Dice Zuam Toso; ed ella ascende, ed entra
in una sala piena di signori,
seduti, in piedi; e ode basse voci
gridare, Azar! a tavoliere.
Sur una panca giace un cavaliere,
con gli occhi chiusi, bianco il viso, bionde
ciocche scorrenti tutto intorno a onde.
«Re Falconello?» ella domanda; e Piero,
scegliendo fiori e frutta: «Falconello,
coi geti al piede!» Dorme il re: d'un tratto
sente un odore di verziere e d'orto,
e vede fiori frutta alberi strade,
e vede campi e fiumi, e il sole!
Sorride un poco, apre le nari, e dorme.
E Flor d'uliva scende più leggiera
e più pensosa.
Pensa al Falconello
coi geti al piede, così bello e blondo.
Ritorna, e canta nel ritorno, e in cielo
soffiano i lampi e qualche tuon bombisce.
E dice alcuno che il maltempo esplora:
«Par di sentire l'allodetta santa,
che in cielo, tra due tuoni, canta».
Lunga è la via, non è la via dell'orto!
Deh! la gran pieta del Re Morto!
Elli era bello, or è più bello.
Zase scoperto in t'un lavello;
una fontana i geme appresso.
E sul lavello un arcipresso
tene una secchia appesa ai rami,
che dice: Vuoi ch'e' viva e t'ami?
empi me di lagrime amare.
Cascano già gocciole rare e grosse.
Chi ha tante lagrime amare?
Ed ecco un dì vene una sclava,
e vede il Re morto che amava,
né il Re lo seppe a la so vita.
Prende la secchia intarmolita,
e se la pone tra i ginocli:
tre dì vi mesce giò da li ocli,
l'ha quasi empita del so planto.
Rimbalza su la polvere che odora.
Si specchia allora nel so planto:
si vede sozza, scarna, trista.
«Deh! como sosterrà mia vista?
Eo vuo' lavarmi alla fontana».
Vi va, chè la non è lontana;
si lava: anche i cavelli scioglie;
si mira; anche due flori coglie;
fiori di menta e di ginestra.
La pioggia scroscia sulle larghe foglie.
Flori di timo e di ginestra,
flori per una ghirlandetta;
poi torna al so gran planto, in fretta,
che forse non ne manca un dito...
La secchia è colma, il Re sparito!
Un'altra sul suo pianto ha pianto;
ha tratto il morto Re d'incanto,
con quattro lagrimette stente.
Con quattro lagrimette stente
s'è tolta 'l blondo Re ch'ell'ama,
ed ella, oisé dolente e grama!
le ha plante, per l'amor suo, tutte.
Non plange più, le ha plante tutte
dal core per l'amor so bello:
rimane lì presso 'l lavello,
con le so lagrime rimane; ...
le so lagrime vane.
V.
IL CONSIGLIO DEL POPOLO
Lente il domani sulla città rossa
suonano le campane del Comune.
Suona la grande, suona la minore:
chiamano ognuna il suo Consiglio a' brievi.
Dice la gente: «Forse re Manfredi,
fatto suo stuolo, è per guastar la terra?»
Chiama i Consigli con le due campane
il Podestà Manfredi da Marengo.
Vanno i Seicento, vanno i Cinquecento
a quelle voci, e vanno l'Arti e l'Armi,
coi lor massari, e salgono le scale
de' Primiceri con brusìo velato.
Entrar li vede il Popolo, mentr'esce
di casa o chiesa; che non sa, ma fida.
Li vede entrare, e vede Bonacursio
che ferreo sta sul limitare.
E nella sala grande del palagio
sono i potenti Consoli ne' loro
panni rosati, con la lor famiglia
di zendal bianco divisata e rosso.
Gli adiutatori siedono e i notari
e il cancelliere, e dritti, con le mani
nelle capaci maniche, due frati,
un bianco, un bigio, un con la croce rossa
cucita al petto, un con la corda ai lombi.
Il Podestà siede nel mezzo: aspetta.
Ecco i Seicento ed ecco i Cinquecento
e' ministrali.
Con brusìo sommesso
siedono attorno.
I due trombetti un segno
dànno di tromba, e il naccarino picchia
le gracidanti nacchere, e i due frati
intonano il grand'inno sacro.
Si queta l'inno, come a larghe ruote
scesa dal cielo un'aquila rombando.
Fatto silenzio, alto e soave parla
il Podestà: «Magnifici e potenti
Consoli, a cui serrare e disserrare
si dà: per vostra volontà qui feci,
giusta il costume, al suon delle campane
e con la voce dei bandizzatori,
questi assemblar del Popolo e Comune
minor Consiglio di Credenza e il Grande.
E qui, di vostra volontà, dimando,
a li uni e a li altri, che mi dian consiglio.
Buona è la massa cui ripose alcuno,
di puro grano, per il pan del giorno,
ma in essa è un tristo lévito.
Bologna
ha bona omnia ...
fuor ch'una».
Odono attenti le parole austere.
Ma ora avvien, come d'un lieve soffio
ch'urta la foglia, scuote il ramo, fruga
l'albero, tutto agita il bosco, e passa.
Fatto silenzio, alto e soave parla
il Podestà: «Vi sono uomini astretti
al suolo altrui, come le quercie e li olmi;
sì che né a essi né a' lor figli è dato
lasciar quel suolo, se il signor non voglia.
Uomini schiavi ha questa dolce terra
di libertà, manenti ed ascriptizi
et arimanni, gente di masnada.
Li può bollare nella faccia il donno,
legar li può sul cavalletto al sole,
onti di miele, e tôrre lor la vita,
oh! senza libertà non cara...»
Più forte vento urta le foglie, squassa
li alberi, tutto agita il bosco, e passa.
Fatto silenzio, alto e soave parla
il Podestà: «Dunque in onor del Cristo,
e della Madre, ed in onore e prode
della Città del Popolo e Comune,
piacciavi: quei che vivono e vivranno,
dentro le mura e fuori delle mura,
e ora e sempre, liberi sien tutti,
e sia la loro libertà difesa
dalla Città dal Popolo e Comune.
E niuno, laico o clerico, più osi
muover quistione ad affermar che alcuno
sia servo o serva della sua masnada.
E niuno più porti sul collo il giogo,
o lieve o grave, o legno o ferro».
VI.
IL PARADISO
E sorge il savio Rolandino, e parla:
«Dio, l'uomo all'uomo toglie a forza il dono
che come padre che partisce il pane
tra i figli, giusto hai tu tra noi diviso:
la libertà.
Ché, come volse i passi
altrove il padre, ecco il fratello grande
strappa il suo pane al piccolo fratello.
Ma tu, Dio, vedi, e vieni, e togli, e rendi.
Nel suo giardino, nel suo monte santo,
Dio pose l'Uomo.
Con l'eterne mani
vi avea dal cielo trapiantato i rami
de li odoriferi alberi, e gettato
i semi colti nelle stelle d'oro.
E v'era in mezzo una fontana viva
che l'irrigava, donde escono i fiumi
Gehon Phison Euphrate e Tigris.
Dio pose l'Uomo, libero, nel santo
suo Paradiso.
- Opera - disse - e godi -;
non disse: - Opera e piangi, opera e impreca.
-
Aveva allora, il placido ortolano
di Dio, soavi pomi per suo cibo,
per sua bevanda acqua più dolce a bere,
d'ogni dolcezza; e facile il lavoro
come il trastullo; e lo seguian li uccelli
con l'alie rosse, all'ombra delle foglie
tremule, lungo il mormorìo d'un rivo.
Tutto era luce, tutto odore e canto.
Ferìa la fronte ove sudor non era,
un'aura uguale; e pur movendo, l'Uomo,
su questa terra, era sì presso al cielo,
che udiva il caro suono delle sfere,
che si volgeano eternamente.
Ei fu cacciato, e fuori errò meschino
e doloroso.
E Seth il buono, un giorno,
venne al Cherub che a guardia era dell'orto
di Dio, dov'ora non vivean che uccelli.
Moriva l'Uomo; e l'Angiolo al buon figlio
un grano diede, ch'e' ponesse al morto
sotto la lingua; ed era della pianta
di cui suo padre avea mangiato il pomo;
e Seth sì fece, e seppellì suo padre,
col grano in bocca: e di quel seme un grande
albero sorse; e dopo mille e mille
anni seccò.
Gli diedero la scure
alle radici, e il tronco giacque.
Un giorno vennero i fabri, e recidean due legni
dal tronco, e insieme li giungean nel mezzo,
tra loro opposti.
E fu la Croce.
L'albero, ch'era in mezzo al Paradiso,
sorse d'allora in mezzo della terra.
Fu tutto il mondo l'orto di Dio chiuso.
I quattro fiumi lo partian; ma ora
moveano rossi sotto il cielo azzurro.
Uomo, lavora e canta! Or ti sovvenga
dei canti uditi nella grande aurora
dell'universo.
È tuo fratello il sole.
La terra, tu la solchi, ella t'abbraccia,
ché voi vi amate.
Abbi il sudor sul volto,
ma come la rugiada sopra il fiore.
Sia l'arte buona presso te.
Lavora
libero.
Tutto ora vedrai ch'è buono
ciò che tu fai, come vedea, creando,
Dio.
Cogli i fiori e fattene ghirlanda,
o uomo, all'ombra della Croce!
O Croce rossa, rossa come il sangue
sparso da Dio, Croce per cui vincemmo,
cauta nel monastero di Pontida,
alto schioccante sul Carroccio ai venti,
o Croce tratta da' placidi bovi
tra spade e lancie, tra le grida e il sangue;
o Croce nostra, noi di te siam degni.
Questo Comune, ch'ha interrotto il vento
imperiale, ch'ha spezzato l'arco
di Federigo, ch'ha gittato il rugghio
solo tra i tanti, ch'ha recinto al fianco,
non targa e scudo, ma cultello e spada,
il suo diritto, ora, di tutti il primo,
adempia il verbo, e dica a tutti il vero:
che il Redentore ancor non è là, dove
ancor non è la libertà!»
VII.
LA LIBERTÀ
Libertà! Su, sbalzano l'Arti e l'Armi,
stanno i Seicento, stanno i Cinquecento,
tendono, stanti, i Consoli le braccia
verso il Consiglio.
Alzano tutti il grido,
Libertà!, grido delle lor battaglie.
Vedono in cuore le assolate strade,
biechi torrazzi, torvi battifolli.
Ecco il lontano canto delle trombe,
ecco il tuon delle torme de' cavalli,
scroscio di lancie, sibili di freccie,
ferro su ferro, spade contro spade,
il martellar d'una fucina immensa,
e il rugginoso anelito, e il singhiozzo
del sangue, e il chiaro alto latino squillo,
Libertà! sempre, Libertà! tra il rauco
latrar di teutoni e schiavoni.
Libertà! L'hanno essi difesa in campo
più che la vita, come la lor fede;
meglio che il dritto, come il lor dovere;
nel suo quel d'altri; libertà per tutti.
Ché né è d'uno, se non è di tutti.
Stante il Consiglio del Comune augusto
tende le braccia, come al giuramento,
tende le mani, come con le spade.
Oh! bel Comune, condurrai tu primo
quei che già venne e non si vede ancora.
Da tanto aspetta fuori delle porte,
e vuole entrare e vuol mangiar la Pasqua.
Egli è vicino, e mansueto aspetta,
seduto presso l'asina legata,
in ermo luogo, e il suo polledro a volte
lo guarda, e torna a brucar l'erba.
Andrem per Lui coi bovi bianchi e rossi
e col Carroccio, e cingeremo in armi
popolo santo l'ara nostra e l'arca.
Sarà la croce in alto sull'antenna,
saranno ai mozzi le lucenti spade.
Ci fermeremo tra il pulverulento
scalpitamento de' cavalli ansanti,
mentre i placidi bovi muggiranno.
Egli, il Dio vero, l'Uomo Dio, soave,
ci dirà pace, ci dirà: Son io.
- Vieni con noi, vieni a mangiar la Pasqua,
siediti a mensa, ché l'agnello è pronto.
Non ha tra noi maggiore né minore.
Tu non volevi né mangiar l'agnello
né bere il vino, prima che il tuo regno
venisse in terra: ecco, è venuto.
-
Libertà! Noi lo condurremo, il Cristo,
al suono vago della Martinella.
Lo condurremo nelle aperte piazze,
dove è pur lunga l'ombra delle torri,
al monte, al piano, sotto le castella
covi di falchi, presso i monasteri
ricchi di grasce; nelle chiese il Cristo
noi condurremo.
Cedano i serragli!
Le porte aprite! Alzate i ponti! Ei viene.
Niuno ritenga ciò che fu ricompro:
è qui Colui che n'ha disborso il prezzo:
Dio! Viene al suono della Martinella,
al nostro grido, sul Carroccio nostro.
Fatevi incontro, a lui gettate i rami
d'uliva, a lui stendete le schiavine
per terra, a lui gridate, Hosanna!
Libertà! Posa il grido qual del rombo
d'un branco in cielo un cinguettìo rimane
minuto in terra.
Sono tutti gli occhi
pieni d'una lontana visione.
È il Paradiso.
Non vi son manenti
od arimanni.
Ogni uomo è uomo.
Ogni uomo ha la sua donna, i figli suoi, la casa
sua.
Sbalza lieto dai tuguri il fumo.
S'ode una voce ch'è nel cuore, e sembra
quella di Dio, quale s'udiva allora:
- Fa ciò che vuoi: non puoi voler che il bene! -
Fuori è il serpente e sibila notturno.
Fuori è il nemico, e vien alto come onda
che muore al lido.
Avanti il Paradiso
resta il Cherub che v'era già: vi resta
a guardia della Libertà.
VIII.
LA BUONA NOVELLA
Va tra le torri, suona nelle piazze,
passa tra i pioppi, sale tra i castagni,
vola tra i faggi la novella buona.
La notte cade, s'avvicina il giorno.
A lui che viene, andate, o genti, incontro.
Vien col Comune e Popolo.
Egli spese
il sangue già per ricomprare i servi;
tutto il suo sangue: ora, dimesso, aggiunge
i trenta sicli, suo valsente.
I trenta sicli, suo valsente in terra,
aggiunge al sangue.
Si riscatti il capo
d'anni oltre sette e sette, dieci libbre
di bolognini; otto il minore: è giusto.
Prendete il prezzo delle mandre umane,
dei greggi, ahimè! che parlano.
S'avanza
coi sicli in mano e col costato aperto
il Redentore...
Il popolo gli è intorno
con gli spontoni e coi ronconi.
Soffia nel corno, o guaita della torre;
desta il palagio irto di merli, aduna
nella tubata i servi con le ancelle.
In vano il prete vi spruzzò sul capo
l'acqua lustrale e vi soffiò negli occhi
e v'unse d'olio.
Voi non rinasceste.
Ora il Comune e Popolo vi scioglie,
v'alita il nuovo spirito, vi tuffa
nel fiume purificatore.
Tu che nel battifredo del convento
suoni compieta, onde s'attrista il cuore
del peregrino, ché quel suon lontano
ciò gli ricorda ch'è vie più lontano:
a festa suona, per Gesù risorto.
Monaci salmeggianti, Egli è risorto,
e viene a tôrre i figli suoi, che i campi
v'arano e l'orto zappano e la legna
gemendo tagliano nel bosco.
Voi che nei torracchioni del castello
vegliate in armi tra il guattir dei falchi,
biondi arimanni, servi di masnada:
in libertà, mastini alla catena
del valvassore! Siate falchi: è meglio.
Via, biondi falchi, dal castello al bosco!
E della vostra fiera gioia empite
la solitudine dell'aria.
Fuochi di gioia, ardete sulle cime!
Dov'ora sola la Limentra scroscia
e muglia il Reno, e il vento urta nei faggi
simile a un folle, fumeranno grigi,
in mezzo all'albeggiare della neve,
nuovi tuguri.
E v'arderà perenne
sul focolare il figlio di due selci
battute sopra un'ara dalle grandi
silenti vergini di Roma.
Fuochi di gioia, ardete in mezzo all'aie
delle pianure! Ché non più, seguendo,
la stiva in mano, i due gementi bovi,
l'uomo dirà: - L'aratro, i bovi e l'uomo,
son tutti cosa che si compra e vende.
-
La sfogliatrice non dirà sfogliando:
- Di qui né io né l'olmo può partire:
olmo, bell'olmo, noi ci somigliamo.
Io canto, anche tu canti, al vento.
-
O sfogliatrice che canti sull'olmo,
come un uccello, quando cade il sole,
scendi; tu puoi partire, anche restare:
all'osilino alcuno avrì l'usolo.
Il drago è morto, o Santa Filumena;
più non ti mangia al fine della tela.
Non planzer più: torna 'l to Sire: canta!
Specchiati nelle lacrime ch'hai sparse,
e va', ti lava alla fontana.
Va Flor d'uliva in Savena la verde:
in un boschetto si mette ad andare.
Scioglie i capelli, lascia giù le vesti,
scende nel rio, tutta si spruzza d'acqua.
E l'oseletto udì cantare un poco,
piano e segreto, che nessun l'udisse.
Ma ella intese ch'era 'l lusignolo
di caiba uscito e ritornato al broilo,
all'acqua, al verde, all'ombra,
al sole, al sole et all'amore.
IX.
LUSIGNOLO E FALCONELLO
Or ella va con la canestra in capo,
lungo la verde Savena, ai serragli,
alle aspre porte, alla città turrita,
recando l'uva paradisa, d'oro.
Ora non canta: canta sì la verla;
fischiano sì le pispole di passo;
anco le rondini: elle vanno in branco
dolce garrendo a ripulirsi al fiume.
Vede ella i meli rosseggiar di pomi,
vede curvare i peri a terra i rami;
l'api bombire, ode ronzar le vespe
e i calabroni in mezzo al dolce fico.
Ella non canta, ma le canta il cuore,
che c'era un re ch'era di giorno un uomo,
ma diventava capougello a sera;
volava allora ai boschi ai campi ai fiumi.
E Flor d'uliva lo sapea, ché sempre,
sull'imbrunire, qua e là, sentiva
parlar più forte, tutti insieme, a gara,
perché piatìano innanzi al re, gli uccelli.
In cuore ha il re, ch'ora ha rimesso l'alie,
per certo, e vola al regno suo lontano,
al suo castello in mezzo al mare azzurro,
il falconello, e il cielo empie di gioia.
O forse è là, tra i suoi cavelli d'oro,
in mezzo ai conti, ch'hanno il pugno al mento,
che dorme per incantamento...
E Flor d'uliva giunge al limitare,
all'alte scale del Palagio nuovo;
e qui Zuam Toso la sogguarda e dice:
«Già t'ho, ricordo, a Santo Zuam, veduta».
«Eo son Lucia, ma detta Flor d'uliva,
da Vidaliagla» ella risponde: «sclava
non più, misèr, sì libera...» «Va, dunque.
Scritto è 'l to nome già nel Paradiso».
Ella non sa: monta le scale, ed entra,
da niuno vista, dove alle pareti
stanno addossati i muti cavalieri.
Stante, in un raggio è fiso il Re, di sole.
E Flor d'uliva presso a lui depone
la sua canestra, e scopre dalle arsite
pampane i cerei grappoli dell'uva,
tacitamente.
Ed ha il corollo in capo.
Il Re si volge a lei che aspetta e tace,
con sui morati riccioli le rosse
pampane; l'uva al piè si vede; e guarda
lei.
Gli occhi neri scontrano gli azzurri.
«Deh! forosella, eo già te vidi 'n sogno,
ch'ero addormito, e tu portasti fiori
et erbe e frutta.
Et eo sognavo un campo
grande, di grano.
E da le folte spighe
spuntavi, come un flore, tu; vestita
non più che un fiore.
E c'era il sole e il vento,
e l'ire o stare a suo talento».
Re Enzio prende un grappolo dorato,
e dolcemente gli acini ne spicca,
zuppi di sole.
E poi riguarda e dice:
«Apersi gli ocli ma tu plu non c'eri.
Seppi, qual eri.
Io prigionier, tu sclava».
E Flor d'uliva: «Ora non plu! Riebbi
la libertà...
Non anco vui, meo Sire?»
Ed Enzio dice: «Eo m'era il Falconello
d'un tempo: aveva il vento tra i cavelli
e il sole entorno.
Apersi li ocli un tratto:
non c'eri plu...» «Ma sono a vui tornata».
Ed Enzio dice: «Or viemmi dietro e taci».
E s'incammina ver' la sua cellata:
dietro ai suoi p
...
[Pagina successiva]

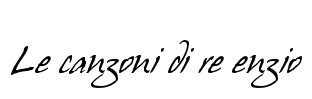 Libri online
Libri online