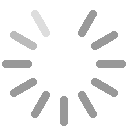[Pagina precedente]...ià eccitate dalle molte commozioni dei giorni antecedenti, o per un particolare influsso fisiologico dell'atmosfera marina, congiunto ad una tendenza insolita alla tenerezza, nata dal sentimento della solitudine, era un fatto, mi disse il Commissario, che la "popolazione" del piroscafo gli dava da pensare e da fare principalmente da quel lato lì, e che quella, per conseguenza, sarebbe stata la frase dominante nella grande sinfonia che avrei sentito suonare per tre settimane. E conchiuse sorridendo: - Se io sapessi scrivere un libro!
Eppure, per quei primi giorni, mi attirò assai di più lo spettacolo dell'arca che quello degli animali. E credo che segua il medesimo a chiunque viaggi per la prima volta in uno di quei colossi che fanno lo scambio del sangue e dell'oro fra i due mondi. Da principio ci si confonde la testa in quel labirinto di passaggi, di cantucci, di nicchie, e in quel via vai di gente dell'equipaggio, d'ufficio e di vestiario diverso, che sbucano e si rimbucano di continuo in una quantità di porticine riposte, somiglianti a quelle d'una carcere o d'un ministero: non par possibile che ci sia bisogno di tanta complicazione di architettura e di servizio per governare e mandare avanti il barcone. Ma poi, quando uno si comincia a raccapezzare, allora ammira la perfezione a cui è arrivato a poco a poco l'ingegno umano nell'arte di stringere insieme, di sovrapporre, d'incastrare l'un nell'altro tutti quei bugigattoli d'uffici, di magazzini, di stanze da dormire, di laboratori d'ogni fatta, in ciascuno dei quali si vede, passando, qualcuno che scrive, o cuce, o impasta, o cucina, o lava, o martella, quasi rimpiattato, con appena tanto spazio da rigirarsi, come un grillo nel buco, e che pure sembra a suo agio, come se fosse nato e vissuto sempre là dentro, sospeso tra l'oceano e il cielo. La macchina smisurata che muove tutto è il nucleo, e la poppa e la prua sono come i sobborghi di quella specie di città forte, detta castello centrale; la quale è formata dai dormitori della seconda classe, dai camerini degli ufficiali, dei macchinisti, del medico e dei cuochi, dai forni, dalla cucina, dai bagni, dalla pasticceria, dalla calderina, dai depositi dei viveri, della biancheria, dei fanali, della posta. E questa città del mezzo, percorsa da due lunghe vie laterali, tutta affaccendamento e rumore, e piena d'odor di carbone, d'olio, di catrame e di fritto, è coperta da una terrazza vastissima, come da una piazza pénsile, alla quale il fusto enorme dell'albero maestro e i due giganteschi fumaiuoli che s'alzano fra le grandi trombe a vento e le alte grue delle lance, e in fondo il palco di comando, col suo lungo terrazzino aereo, danno un aspetto monumentale stranissimo, che alletta la fantasia come l'immagine d'una città misteriosa. Da questa terrazza, occupata in gran parte dai passeggieri di terza, si domina tutta la prua, un pezzo d'arca di Noè, un'altra vasta piazza affollata di passeggieri, che ha lungo i due lati le stalle dei bovi e dei cavalli, le stie dei piccioni e delle galline, le gabbie dei montoni e dei conigli, in fondo il lavatoio a vapore e il macello, di qua i cernieri dell'acqua dolce e gli acquai marini, nel mezzo la casetta dell'osteria e la boccaporta dei dormitori femminili, chiusa da una bizzarra sovrapposizione di tetti vetrati che servon di sedili alle donne, e al di sopra di ogni cosa l'albero di trinchetto, che disegna i suoi cordami e le sue scale nere sul cielo. Ultimo s'alza il castello di prua, che copre i dormitori dei marinai, la fabbrica del ghiaccio e l'ospedale, formando un'altra piazzetta finita in punta, dove un'altra folla si pigia fra gli argani, le bitte, il molinello e le grandi catene delle àncore e altre boccaporte e altre trombe a vento, come sopra il bastione d'una fortezza avanzata, dalla quale l'estremità opposta del piroscafo, col suo ampio cassero ombreggiato dalle tende e popolato di signore, si vede piccola, confusa, lontanissima, da parere incredibile quasi che faccia parte del medesimo corpo. E non son queste che le parti esteriori del colosso; che sotto vaneggia un altro mondo, sconosciuto ai passeggieri: magazzini sterminati di carbone, torrenti d'acqua dolce, provvigioni di viveri per una città assediata, depositi enormi di cavi, di vele, di bozzelli, di braghe, un labirinto interminabile di vani semioscuri riboccanti di bagagli, d'anditi per cui non si passa che curvi, di scalette che si perdon nelle tenebre, di recessi profondi e umidi ai quali non giunge neppure il brulichìo della folla che si agita sopra, e dove si crederebbe d'essere sepolti nei sotterranei granitici d'una fortezza, se il tremito delle pareti non ci avvertisse che tutt'all'intorno freme una vita immensa, e che l'edifizio è fragile e va.
Così, osservando parte per parte il Galileo, e sfogliando i passaporti col Commissario, passai i primi tre giorni, che dal Golfo di Leone in là furono di bellissimo tempo; ma giungendo la mattina del quarto giorno allo stretto di Gibilterra, trovammo una nebbia fitta che non ci lasciò vedere né la rocca, né la costa di Spagna, né quella d'Africa, e ci rese difficile il passaggio. Non difficile per la ragione che teneva inquiete molte donne della terza classe, le quali - mi disse il Commissario - immaginavano che il piroscafo si dovesse infilare in una specie di canale strozzato fra le rocce, dove non avrebbe potuto passare che scorticandosi, a rischio d'andare in pezzi, come le barche per l'apertura della grotta azzurra di Capri; ma perché, a cagion della nebbia, e del gran numero di bastimenti che s'incontrano là, in quel vestibolo dell'oceano, dove si baciano quasi i due continenti, era molto facile un abbordo, che poteva mandarci tutti a fondo, senza lasciarci il tempo di recitar l'atto di contrizione. Fu quindi necessario di procedere con grandissima cautela. E allora si vide una scena mirabile, da cui si sarebbe potuto cavare un grande quadro, intitolato in genovese: - A füffetta [2] - solenne e comico a un tempo. Il Galileo andava innanzi lentissimamente dentro alla nebbia densa, che intercettava la vista da tutte le parti, a brevissima distanza dal bordo; tutti gli ufficiali stavano all'erta; il Comandante, ritto sul palco di comando, mandava sotto ordine su ordine, di piegare dall'uno o dall'altro lato; la macchina a vapore gittava ogni momento la sua voce d'allarme, una specie d'urlo rauco e lamentevole, come l'annuncio d'una disgrazia. E a destra, a sinistra, davanti, di dietro, rispondevano altri suoni rauchi e sinistri di piroscafi invisibili, alcuni lontani che parevano ruggiti di leoni dell'Africa, altri vicinissimi, come di piroscafi che fossero sul punto d'investirci, altri radi e fiochi, altri fitti e affannosi come grida umane che minacciassero e supplicassero insieme. E ad ogni suono, tutti i mille e seicento passeggieri, affollati e ritti in coperta, si voltavano vivamente di là donde il suono veniva, con gli occhi spalancati, trattenendo il respiro, e molti accorrevano da quella parte, dando colore di curiosità alla paura, ma col viso brutto, come aspettandosi di veder apparire la prua d'un colosso che ci venisse sopra. Non si sentiva una voce in quella moltitudine, non si vedeva un viso che sorridesse. Istintivamente le famiglie si stringevano, molti s'andavano affollando vicino alle lance sospese, altri adocchiavano di traverso i salvavite appesi qua e là, tutti volgevano alternatamente gli occhi al comandante, come all'immagine d'un santo protettore, e diritto davanti a sé, su quella nebbia malaugurosa, che poteva nasconder la morte. Uno solo pareva indifferente sul cassero di poppa, ed era il mio vicino di tavola, l'avvocato, seduto con le spalle al mare, che leggeva; e già stavo per ammirare il suo eroismo; ma subito mi disingannai, osservando che il libro gli ballava tra le mani la più allegra danza che possa mai ballare un bicchiere di zozza nel pugno d'uno sbornione condannato. E quella musica funerea di segnali durò più d'un'ora, e con essa il silenzio pauroso a bordo, e quell'andare lentissimo del piroscafo, come d'un esploratore che s'avanzasse nell'agguato d'una flotta nemica. Un'ora eterna. Infine non si sentì più che qualche suono lontano, il piroscafo cominciò a correre più rapido, e il comandante, scendendo dal palco col fazzoletto alla fronte, diede il segnale della liberazione. Giravamo allora intorno al Capo Spartel, e il Galileo faceva la sua entrata nell'Atlantico, in mezzo a uno sciame saltellante di delfini, salutati dagli emigranti con un concerto di grida e di fischi.
La nebbia quasi a un tratto svanì, e a sinistra si mostrò la costa d'Africa: una catena di monti lontani, d'una chiarezza di cristallo. E l'Atlantico ci cullava con le sue onde lunghe e placide, simili a vastissimi tappeti azzurri, frangiati d'argento, scossi da miriadi di mani invisibili, gli uni dietro gli altri, senza fine; a traverso ai quali il Galileo distendeva, passando, uno sterminato strascico di trina bianca. Non era diverso il nuovo mare da quello donde uscivamo; eppure ci veniva fatto di alzar la fronte come se lo spirito fosse più libero e l'occhio spaziasse più lontano, e di ber l'aria a lunghe inspirazioni, con un senso nuovo di piacere, come se già ci portasse i profumi potenti delle grandi foreste dell'America latina, alla quale andava diritto il nostro pensiero con un volo di seimila miglia. Il cielo era tersissimo, e pendeva sull'orizzonte uno spicchio bianco di luna, quasi svanito nella soavità dell'azzurro. Pareva che quell'oceano, a cui la maggior parte di noi aveva pensato fino allora con inquietudine, ci dicesse: - Venite, sono immenso, ma buono.
A PRUA E A POPPA
Due giorni dopo, si poteva dire che ogni cosa fosse in ordine a prua, ed io cominciai le mie osservazioni. Quando salii sul palco di comando, poco dopo le otto, che era l'ora della colezione, la prua offriva l'aspetto tra d'un mercato di campagna e d'un accampamento di zingari, che avessero disfatto le tende. Ciascun gruppo d'emigranti aveva preso il suo posto, dove passava la maggior parte della giornata, e i posti presi, per consuetudine tradizionale, eran rispettati da tutti. Dovunque si potesse star seduti senza ingombrare il passaggio, in tutti i cantucci che formavan le torri di cordami e i mucchi di fieno o di merci addossati all'opera morta, s'era ficcata, come una covata di gatti, una brigatella di conoscenti o una famigliuola, con le sue seggiole e qualche cuscino o coperta, e alcune eran così ben rimpiattate, che vi si sarebbe potuto passar davanti dieci volte senza scoprirle; poiché la povera gente si adatta a tutti i vani come l'acqua. Una parte dei passeggieri intingevano ancora le gallette nel caffè nero, con le gamelle di latta sulle ginocchia; alcuni lavavano le loro stoviglie negli acquai, o distribuivano l'acqua dolce al loro rancio coi così detti bidoni, della forma di coni tronchi, dipinti di rosso e di verde; gli altri stavano accovacciati lungo i parapetti, nelle positure proprie dei contadini, abituati a riposar sulla terra, o passeggiavano con le mani in tasca, come la domenica sulla piazza del villaggio; mentre le donne, coi capelli sciolti giù per le spalle, si pettinavano davanti a specchietti da venti centesimi, ravviavano i ragazzi, passandosi a vicenda spazzole, saponi, asciugamani, davano il latte ai bambini, rimendavano panni e lavavan pezzuole in quattro gocce d'acqua, tutte affaccendate, angustiate visibilmente dalla ristrettezza dello spazio e dalla mancanza di cento cose. Tra la folla fitta e nera si vedevan girare lunghe berrette blu di cafoni, busti verdi di donne calabresi, larghi cappelli di feltro di contadini dell'Alta Italia, cuffie di montanare, papaline rosse, italianelli, raggiere di spilli di villanelle della Brianza, e teste bianche di vecchi e nere capigliature selvagge e una varietà mirabile di facce stanche, tristi, ridenti, attonite, sinistre; molte delle quali facevan creder vero che l'emigrazione porti via dal paese i germi di molti delitti.
Ma l'oceano essen...
[Pagina successiva]